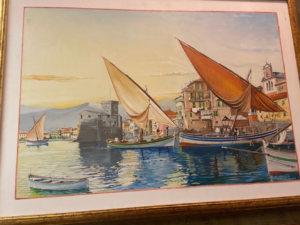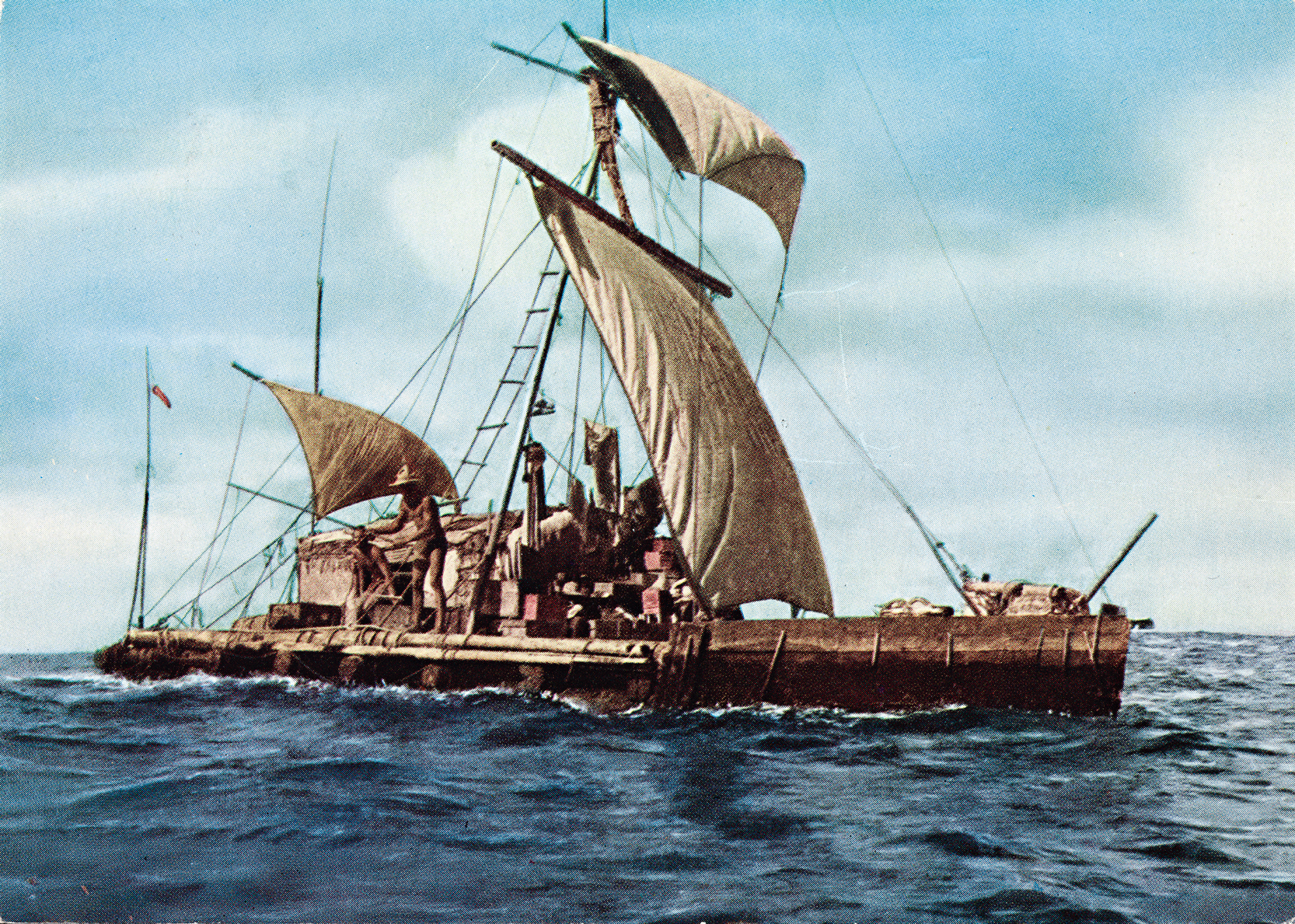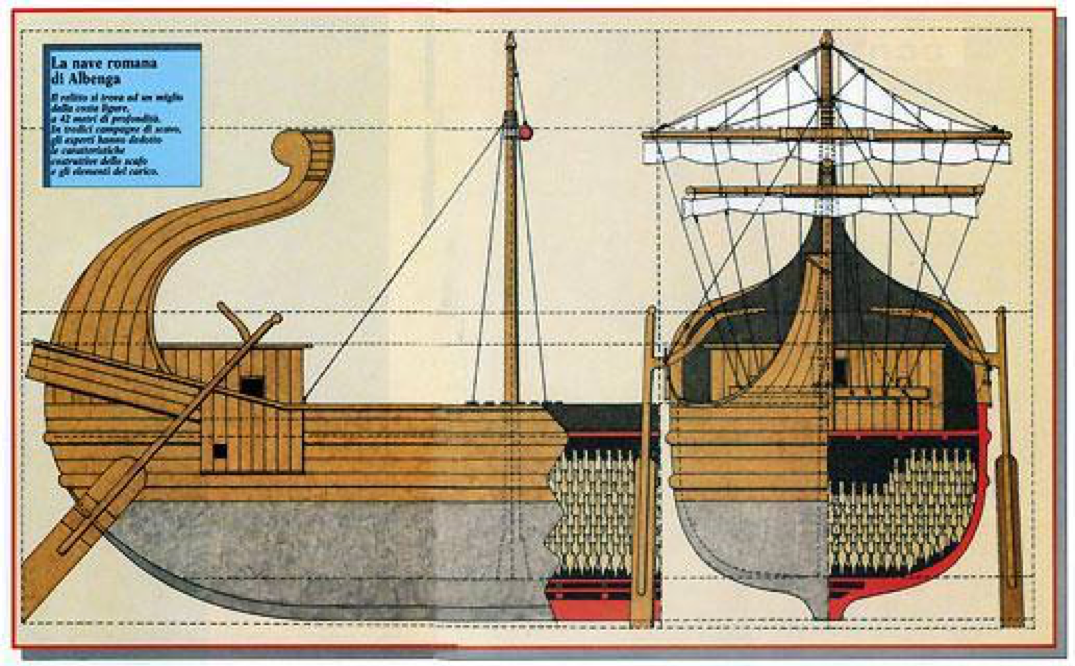IL "BAGNUN" DI RIVA TRIGOSO (SESTRI LEVANTE)
IL BAGNUN
di
Riva Trigoso-Sestri Levante
La Stagione Estiva 2023 è ormai alle porte e con essa si riparla di SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI nostrane che celebrano intimamente il forte legame tra il territorio, i suoi abitanti e tanti turisti in cerca di emozioni. Quest’anno il sentimento di appartenenza è sentito maggiormente ed è atteso con una esplosiva eccitazione generale dalla collettività per cancellare tutti insieme i tristissimi ricordi lasciati nel Paese dal Pandemia Covid-19.
Tra le tante SAGRE, che in seguito elencheremo, come Associazione Marinara, abbiamo scelto una tra le più “salmastre”: IL BAGNUN per farla conoscere o semplicemente ricordare nostalgicamente anche ai tanti AMICI liguri che ci seguono da molto lontano….
Le mappe che seguono servono ad orientare i turisti per raggiungere la meta che stiamo per raccontare.

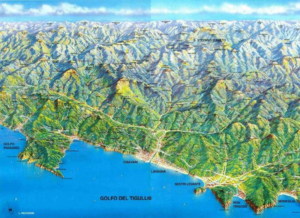
Per dare un’idea del programma, non essendo ancora stata pubblicata la locandina del 2023, riportiamo quella dell’anno scorso:

Sagra del Bagnun a Sestri Levante- Riva Trigoso
sabato 15 luglio 2023 a Sestri Levante, Genova
Secondo il responsabile regionale di Fedragricpesca-Federcopesca Augusto Comes, queste sono manifestazioni che fanno bene al territorio. «Permette di far conoscere il prodotto del pesce azzurro. Sestri Levante è un po’ la capitale dell’acciuga, in Liguria. Abbiamo necessità di far fronte ad un mondo che si è globalizzato, far capire che c’è un’economia locale, ci sono prodotti di giornata freschi. È vero che il settore pesca ha dei costi ma si può incidere sui ricavi».
L’idea di realizzare la sagra del BAGNUN non poteva che venire ad un illustre personaggio di Riva Trigoso che ora andremo a conoscere da vicino.

Il Bagnun, dal 1960, è anche qualcosa di più. Da un'idea di Edoardo Bo, (nella foto) si cominciò ad organizzare una serata, tradizionalmente nel penultimo fine settimana di luglio, durante la quale venivano offerte ai cittadini e agli ospiti generose porzioni della celebre zuppa di pesce.
Breve Biografia:
EDOARDO BO (Trigoso di Sestri Levante-14.7.1923- Trigoso-27.3.2015). Aveva 91 anni.
Aveva continuato la sua attività di pubblicista e scrittore fino a qualche anno fa, poi, dopo la scomparsa dell’amatissima moglie Elsa, la sua vita era cambiata. Edo aveva perduto il suo antico ardore, il suo spirito di combattente di mille battaglie. La famiglia, i cantieri navali di Riva, i giornali, la Croce rossa. La sua vita è ruotata intorno a valori importanti e alle sue grandi passioni. Nel sottocomitato rivano ha operato per 44 anni, da volontario, da autista, poi da presidente. I suoi lunghi anni di volontariato gli sono valsi la medaglia d’argento, massima onorificenza che gli fu consegnata da Maria Pia Fanfani, presidente nazionale della Cri.
Nel mondo dell’informazione levantina dal 1950 in avanti, forse senza nemmeno accorgersene, Edo aveva inventato il ruolo del corrispondente nel senso più vero e ampio del ruolo. Andava ovunque con la sua Lambretta che riportava sullo scudo anteriore i nomi delle testate della Rai e dell’agenzia Ansa. Ma collaborava anche con Il Secolo XIX e gli altri quotidiani genovesi, con il Corriere della Sera, La Stampa e Stampa Sera e con altre testate, compresa Telepace fin dalla sua fondazione.
Consigliere Comunale di Sestri Levante dal 1960 al 1980 e Assessore allo sport e Turismo dal 1969 al 1975, Vice presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, Presidente del Comitato Cittadino Manifestazioni Rivane, promotore di iniziative turistiche, culturali e folcloristiche di cui “Il Leudo - Timone e Ancore d'Oro”, la “Sagra del Bagnun” e della posa sullo scoglio dell'Asseù della Croce a ricordo dei Caduti del Mare.
Il nome di Edoardo Bo, per 44 anni, è stato legato soprattutto alla Croce Rossa Italiana di Riva Trigoso, di cui fu Presidente sino al 1997.
Medaglia d'Argento della Croce Rossa italiana e del Premio "Castrum Sigestri 1977 quale Sestrese dell'Anno, per le attività sociali.
Melvin Jones Yellow, per attività umanitaria del Lions Club International.
Dello stesso autore:
II Leudo nella Storia di Riva Trigoso e della Liguria, 1986, Grafiche Bi-Essepi di Novero di Segrate (Mi)
Riva Trigoso e il suo Leudo, 1987, Edizioni Sagno
Riva Trigoso, il Cantiere e la sua Storia Centenaria, 1991, Tipolito Olona di Copiano (Pv)
Il Leudo Rivano, 2001, Arti Grafiche Lux Genova.
IL SECOLO XIX
22 Luglio 2019 alle 10:09
Nello, il decano del Bagnun «Ecco il segreto del piatto che fu dei nostri marinai»

Nello Trinca (a destra), decano dell’Associazione Bagnun di Riva Trigoso, in compagnia di un altro cuoco, Gianremo Moisello Novant’anni, da trentacinque nell’associazione rivana che promuove la sagra, è uno dei quattro cuochi: quest’anno sono state servite 4.200 porzioni.
Questa bella intervista che segue è ridotta alla parte gastro-marinaresca. Essa è apparsa sul SECOLO XIX il 22 Luglio 2019 e dà l’idea del BAGNUN di Riva Trigoso per come è pensato, vissuto e realizzato nella sua originale e fedele TRADIZIONE da uomini che amano la propria terra e che nel BAGNUN scoprono la propria spiritualità che si sposa con il mare e la sua storia locale.
…….
Entrato nell'associazione, Nello si è fatto strada entrando nella ristretta cerchia dei cuochi del bagnun: «I soci sono un centinaio, ma i cuochi sono quattro: io, Aldo Fois, Ennio Zolezzi e Gianremo Moisello, anche se ci teniamo molto a ricordare Josè Vallerio, che non c'è più». La ricetta è semplice, ma per prepararla al meglio ci vogliono anni, dicono, soprattutto se, al posto che farla in casa per tre o quattro persone, si tratta di cucinare come quest'anno 800 chili di acciughe: «Il procedimento comunque è sempre uno solo – spiegano – si parte dal soffritto con olio, cipolle, aglio e prezzemolo. Si aggiungono una spruzzata (nel calderone di ieri ben 12 litri) di vino bianco, quindi il pomodoro e si lascia cuocere per circa due ore».
La fatica, a questo punto, è quella di pulire le acciughe e non per niente da alcuni anni il Bagnun chiama a raccolta dei volontari per «destettarle», ovvero rimuovere testa e interiora. Le acciughe vengono poi tuffate nel sugo allungato con acqua bollente salata e fatte cuocere per cinque minuti. Il piatto finale si completa con il terzo protagonista, la galletta del marinaio, messa a pezzi ad ammorbidirsi nel sugo.
«Questa era una ricetta che si componeva delle merci di scambio dei nostri marinai che partivano sui leudi, pescavano le acciughe con la “mannata” e le scambiavano con pomodori e il resto».
Di tempo ne è passato da quando il bagnun si cucinava sulla “gnafra” dei leudi e da quando per la prima sagra si usarono «il calderone di rame che serviva per tingere le reti con il “ruscu” e un remo per mescolare».
Certo è che il bagnun conserva il suo fascino, e forse non solo: Valter Longo, noto biochimico originario di Genova e riconosciuto a livello mondiale tra i massimi esperti negli studi sull'invecchiamento, lo ha inserito tra 200 ricette italiane «della longevità».

Il bagnun di acciughe è uno dei sapori più tradizionali di Sestri Levante o, per essere più precisi, di Riva Trigoso. L’acciuga, pesce povero per eccellenza, incontra il pomodoro e la galletta del marinaio, in una ricetta che regala tutto il gusto del Mediterraneo. Questo piatto tradizionale veniva cucinato dai pescatori liguri.
Anziani e giovani si passano il testimone …


Anche l’occhio vuole la sua parte …

Piatto tipico degli ambienti di mare della Liguria, il Bagnun in origine si cucinava, con il bel tempo, a bordo dei LEUDI con cui i marinai liguri viaggiavano per commerciare nel ponente del Mediterraneo utilizzando un semplice fornello a carbonella.

Un pane che potesse conservarsi per molto tempo era noto fin dall’antichità.
Il primo a parlare del pane per i marinai, panis nauticus, fu Plinio, ma se ne trova traccia anche in altre documentazioni storiche e anche gli scavi di Pompei hanno fornito molte informazioni!
Il panis nauticus ad esempio era una galletta forma di anello che si infilava in un bastone, mentre quello per i soldati durante le battaglie era il panis militaris castrensis!
Anche Cristoforo Colombo cita il bizcocho, biscotto o galletta, in una lettera a Isabella di Castiglia scrivendo del suo approvvigionamento durante la sua traversata verso le Americhe!
Tradizionalmente la Galletta del marinaio nasce a Camogli e nelle sue vicinanze, precisamente a San Rocco.
Il Panificio Maccarini (San Rocco di Camogli) le prepara fin dal 1885, secondo l’antica ricetta di famiglia, distribuendole in tutto il mondo!
Per la loro trasportabilità e conservazione, le gallette erano usate anche nelle campagne, a esempio durante la fienagione.
LA GALLETTA DEL MARINAIO
https://www.marenostrumrapallo.it/juan/
di Carlo GATTI
Unite ai prodotti degli orti e nelle dispense costituivano un pranzo sostanzioso durante il lavoro!
Le Gallette del marinaio sono alla base di alcune tra le ricette più tipiche e rappresentative di Genova e della Liguria.
Prima tra tutte il Cappon Magro, l’antipasto principe delle tavole delle feste e portata irrinunciabile a Natale.
STORIE DI MARE - IL CAPPUN MAGRO
https://www.marenostrumrapallo.it/cappun/
di Carlo GATTI
Con il passare del tempo ha conservato la semplicità originaria: lo si prepara, ancora oggi, con acciughe freschissime, cipolle rosolate, pomodori pelati, olio d’oliva extravergine e gallette del marinaio o pane biscottato.
NEL MONDO DEI LEUDI
https://www.marenostrumrapallo.it/nel-mondo-dei-leudi/
di Carlo GATTI

Leudi tirati in secco sulla spiaggia di Sestri Levante
ANCHE LA TRADIZIONE HA LE SUE RADICI NELLA STORIA …
Nato nel 1800, il BAGNUN era il piatto principale preparato a bordo dei LEUDI che lasciavano la baia di Sestri Levante per approdare nei porti del Mediterraneo, ma era anche il piatto dei pescatori che la cucinavano a bordo delle lampare su fornelli a carbone,
Veloce ed economica, questa gustosa zuppa univa due ingredienti tipici della marineria ligure e, soprattutto, levantina. Sono infatti presenti le acciughe e le gallette del marinaio, il pane dei naviganti!
Un tempo il Bagnun si mangiava quasi solo d'estate, ma con gli anni la pesca delle acciughe si è estesa anche nelle altre stagioni ed oggi quindi può essere preparato pressoché tutto l'anno.
Oggi il BAGNUN si prepara un po’ in tutto il Golfo Tigullio.
Un suggerimento colto al volo:
Il bagnun di acciughe è davvero molto semplice da preparare, facile e anche molto economico se comprerete le acciughe in offerta come spesso sono. L’unica raccomandazione che spesso si sente uscire dalla bocca degli specialisti è di non muovere le acciughe con il cucchiaio altrimenti farete una poltiglia informe. Per girare le acciughe nel tegame muovetelo leggermente in modo che il sugo smuova naturalmente le acciughe senza doverle toccare voi e poi…ovviamente preparatevi un sacco di pane per fare la scarpetta perché con tutto quel sughino è davvero d’obbligo.
INGREDIENTI
-
1 kgAcciughe (alici)
-
500 mlPassata di pomodoro
-
1 spicchioAglio
-
1Scalogno
-
4 cucchiaiOlio extravergine d'oliva
-
mezzo bicchieri Vino bianco
-
Sale
PREPARAZIONE
-Tritate finemente lo scalogno.
-Tagliate l’aglio a metà e privatelo dell’anima centrale.
-Pulite le acciughe togliendo la testa e la lisca ma lasciandole intere senza aprirle altrimenti si sfalderanno in cottura.
-Mettete in una pentola grande oppure in un tegame l’olio extravergine di oliva e fateli scaldare.
-Mettete a soffriggere lo scalogno insieme all’aglio per qualche minuto. Aggiungete la polpa di pomodoro, mezzo bicchiere di acqua e il vino bianco e mescolate.
-Fate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti in modo che il sugo inizi a restringere.
-Unite il sale e alzate la temperatura del fuoco al massimo in modo che il sugo diventi molto caldo.
-Adagiate le acciughe pulite e disliscate nella salsa di pomodoro e fatele cuocere per circa 5 minuti con il coperchio fino a che le acciughe saranno completamente cotte.
VARIANTI E CONSIGLI
Potete aggiungere anche il pepe se vi piace o anche prezzemolo tritato fresco al sugo di pomodoro ma consiglio di farlo a cottura già avvenuta.
Non aprite le acciughe quando andrete a pulirle altrimenti si sfalderanno completamente in cottura.
Bagnun di Acciughe.
L’origine di questa ricetta è antichissima: i marinai di Riva Trigoso, già intorno all‘800, cucinavano il bagnùn, a bordo delle lampare e dei leudi sui fornelli a carbone.








Un passo ancora più indietro nella storia ….
Per non addentrarci nei “millenari vicoli della Storia dell’alimentazione navale”, ripartiamo da pochi dati ma certi che risalgono alla Repubblica Marinara di Genova.
Per fare un esempio, nel 1338 circolano documenti in cui si evince la figura del “fornitore navale”, nei quali si dichiara che: il proprietario della nave deve garantire ad ogni singolo membro dell’equipaggio almeno 800g di biscotto al giorno.
Si specifica inoltre che sulle navi si servono: brodo di pesce, zuppe, cappon magro, capponata (galletta, acciughe salate, mosciame, olive, olio e sale) e la “mesciua” (ceci, fagioli, granfano).
Si scopre infine che a bordo dei legni veniva servita: una pasta condita con erbe e formaggio e frutta secca, condimento che potremmo ipotizzare essere un antenato del conosciutissimo pesto.
Proliferano quindi i fornitori del biscotto, che sono tenuti a giurare di fornire: un biscotto “bonus et idoneus” e gli eventuali disonesti sono soggetti a severe punizioni. Il comparto alimentare così descritto appare come un chiaro segnale di quanto il biscotto e il rancio venissero presi sul serio.
Scopro da un eccellente articolo sulla materia che a Candia (Isola di Creta), nel 1821, sono stati trovati dei biscotti, perfettamente conservati, risalenti al 1669! A parte l’improbabile gusto…sul quale si possono avere molti dubbi, ma nulla, penso, si possa obiettare sulla loro conservazione in questo modo accertata!
DALLE NOSTRE PARTI …
FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI
questo è il sito di
|
Aggiornato 2
3
APPUNTAMENTI NEL LEVANTE LIGURE
Feste, sagre, manifestazioni.
* si svolge ogni anno nella stessa data. Cara sagra, quanto mi costi?
GIUGNO 2023
1...4/6 Genova Slow Fish - Coast to coast, al porto antico. Dettagli
1...4/6 Chiavari (Ge) Festival della parola, presso piazza N.S. dell'Orto, auditorium S.Francesco e Società Economica; dettagli su festivaldellaparola.eu
1...4/6 Lavagna (Ge) Lavagna in festa. Gi 1 ore 18 inaugurazione mostra fotografica del Corpo Bandistico cittadino, segue festeggiamenti per i 170 anni della Banda, alla Torre del Borgo. Ve 2 mostra mercato dell'artigianato e dell'hobbistica in piazza della Libertà; ore 9.30 "Anemmo i mòrti i ne ciamman" visita guidata al cimitero monumentale, prenotazioni 349.4109436; ore 11 concerto del Corpo Bandistico al Porticato Brignardello; dalle 17 esibizioni varie di ginnastica e karate in via N. Italia. Sa 3 ore 17.30-19.30 raduno musicale "Lavagna in musica" sfilata complessi musicali nel centro storico. Do 4 ore 9-22 Combat tour nel centro sportivo di via Ekengren; ore 10-12 sfilata complessi musicali nel centro storico. Dettagli
Ven 2/6 Mezzanego (Ge) Loc. Borgonovo L., "Giardiniera che passione" esposizione auto d'epoca e non solo, presentazioni, artigiananto, assaggi e passatempi, dalle ore 10 in poi.
2-3-4/6 Rapallo (Ge) Loc. Montepegli, festa della Madonnina del Ponte, dalle ore 19 stand enogastronomici, ore 21 serate danzanti: 2 "Pietro Galassi", 3 "Hurrà" con Dejanira, 4 "Antonio Maenza". Manifesto
2-3-4/6 Gattorna di Moconesi (Ge) Stand gastronomici dalle ore 19.30 in piazza della Croce Rossa: Ve 2 orch."Caravel"; sa 3 ore 15 Carnival party con pentolaccia, alla sera discoteca in maschera; do 4 dalle 15 Festa del Giocattolo, alla sera orch."William Zolezzi".
2001-2023: Paolino, da 22 anni in rete! |
8...18/6 Sestri L.(Ge) Andersen festival, dettagli
9-10/6 Cogorno (Ge) 36° Sagra dei testaiêu in loc. Belvedere, ore 21 ballo con orchestra: 9 "Daniele Cordani", 10 "Walter Giannarelli". Dettagli
Sab 10/6 Sori (Ge) Loc. Capreno, sagra della ciliegia e delle focaccette: ore 16 focaccette e ciliegie, ore 19.30 apertura stand gastronomici al coperto, ore 21 ballo con orch."Ornella's Group". Info tel.3917704642, prendere la strada provinciale 71 da Sori. Si svolge anche in caso di pioggia
10-11-12/6 Coreglia Ligure (Ge) Festa di S.Antonio al campo sport. Dalle ore 19.30 servizio ristoro con servizio ai tavoli, ore 21.30 ballo, ingresso libero: sa 10 "Fabio Cozzani", do 11 "Giannarelli e Pietrelli", lu 12 "Caravel". Sa 10 e do 11 laboratorio per bambini Manifesto
17-18-19/6 Genova Wine Experience, 1800 mq di esposizione, 300 espositori, al Genova Stadium lungomare Giuseppe Canepa 155 dalle ore 9.30 alle 20, Dettagli
Sab 17/6 Chiavari (Ge) Chiavari Vintage, per rivivere musica, stile, divertimenti e passioni degli anni 60-70-80, concerti e dj set "Diego Picasso", esibizione scuole di danza, esposizione auto e moto d'epoca, in piazza Roma (Luna Park per bambini) e piazza Matteotti (dalle ore 18 "The Beat Barons", "Naim & the Soul Machine")
Sab 17/6 Coreglia Ligure (Ge) Serata discoteca con dj Kelly
Dom 18/6 Conscenti (Ge) Marcia del GhiottoNE, mangialonga in val Graveglia, iscrizione adulti €23; dettagli
24/6...2/7 Genova The Ocean Race, the Grand Finale; info dettagli
30/6 1/7 Cogorno (Ge) Re Raviolo incontro gastronomico e danze ore 21: ve 30 "Macho", sa 1 "Raf Benzoni". Dettagli
LUGLIO 2022
1-2/7 Cogorno (Ge) Re Raviolo incontro gastronomico e danze ore 21: ve 1 "Alex Tosi", sa 2 "Raf Benzoni". Dettagli
1-2-3/7 Camogli (Ge) Festa patronale N.S. del Boschetto presso il Santuario, ore 19 stand gastronomico: ve 1 ore 22 concerto dei "Caravel", sa 2 ore 19 spettacolo burattini "Il mare raccanta", do 3 ore 18 incontro "Camogli sulla rotta delle acciughe" a cura del gruppo U Dragun
*1-2-3/7 Rapallo (Ge) Festività in onore di N.S. di Montallegro, festeggiamenti religiosi e civili: sparate di mortaretti e fuochi d'artificio nelle tre serate dopo le ore 22.30; do 3 ore 22.15 "incendio del Castello". Dettagli.
1-2-3/7 Sestri L.(Ge) Loc. Villa Tassani, sagra delle lumache, ore 19 apertura stand gastronomici, ore 21 ballo con orch.: ve 1 "Primavera", sa 2 "Caravel", do 3 "Paolo Bertoli"
1-8-16-23-29/7 Deiva M.(Sp) "DeivArte… sotto la luna" artigianato artistico e creativo di qualità, sul lungomare ore 19-24
*2-3/7 Chiavari (Ge) Festa patronale di N.S. dell'Orto:
Sa 2 ore 7.30/20 fiera estiva di merci varie, ore 21 concerto in p.zza N.S. dell'Orto.
Do 3 ore 21 processione, ore 23 circa spettacolo pirotecnico musicale sul lungomare.
2-3/7 Lavagna (Ge) Lavagna in musica, con la banda Città di Lavagna, Glenn Miller band di Bedonia, banda Luigi Pini di Fontanellato, banda Mons. G.Nava di Lurago d'Erba, banda di Rapallo: sa 2 ore 18 sfilata per le vie cittadine ed esibizione delle bande in piazza Marconi; do 3 dalle 10 sfilata per le vie cittadine e poi in piazza della Libertà concerto della banda giovanile di Lavagna, a seguire concerto della banda Mons. G.Nava. Manifesto
2-3/7 Sori (Ge) Loc. Sussisa, festa patronale di San Matteo: sa 2 ore 18 S.Messa, ore 18.30 apertura stand gastronomici, ore 21 danze con duo "Les Crikò"; do 3 ore 11 S.Messa, ore 19.30 apertura stand gastronomici, ore 20 vespri e processione, al termine sparata di mascoli, seguirà musica con "Mike from Campo" e i "Demueluìn"
Sab 2/7 Fontanegli (Ge) Sagra del raviolo, ore 19 menù fisso adulti a €20 bevande escluse, ore 21 discoteca e balli latini con "Lucio e dj Ditch", dettagli
2-9-22-30/7 Lavagna (Ge) Creativamente in libertà, artigianato artistico e creativo di qualità, piazza della Libertà ore 18.30-24
Mer 6/7 Conscenti (Ge) Esposizione auto, stand gastronomici e musica, area verde S.Pertini ore 19.30-24
Ven 8/7 Camogli (Ge) Bandinspiaggia, la banda cittadina suonerà brani di intrattenimento, ore 21, gratuito
Ven 8/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Lettura Clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano" Fabrizio Bentivoglio. Dettagli
Ven 8/7 Carasco (Ge) La compagnia Quelli de 'na vòtta presenta la commedia "O nêvo", giardini via Piani, ore 21
Sab 9/7 Fontanegli (Ge) Sagra del pansoto, ore 19 menù fisso adulti a €20 bevande escluse, ore 21 discoteca e balli latini con "Lucio e dj Ditch", dettagli
9-10/7 Sant'Olcese (Ge) Loc. Manesseno, Festa di Sant'Alberto e sagra della lumaca: sa 9 ore 19 apertura Stand Gastronomici e musica dal vivo con i "Tempo Perso"; do 10 ore 11 S. Messa, ore 12.30 e 19 apertura Stand Gastronomici, ore 17.30 S.Vespri e Processione, musica dal vivo con "Rossana e Laura". Dettagli
9-10/7 Camogli (Ge) Loc. S. Rocco, sagra della Capponadda, mercatino di prodotti locali: sa 9 stand gastronomico dalle 18.30 alle 21.30 con intrattenimento musicale in serata, do 10 stand gastronomico dalle 12.30 alle 22.
9...17/7 "Parole e voci sul mare" rassegna di serate d'autore ad ingresso libero sulla Terrazza Miramare, leggi i Dettagli.
9-10/7 Leivi (Ge) Proloco in festa - il ritorno, area sportiva S.Bartolomeo: ore 19 stand gastronomici, ore 21: sa 9 orch."Diego Sanguineti", do 10 tribute band "Tropico del Blasco"
9-10/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Lago delle Lame, Celtic Festival, gruppi storici, musica, cibo e bevande, Dettagli fb
9-10/7 Casarza Lig.(Ge) Loc. Bargone, Fragolata gastronomia e danze: 9 spettacolo danzante con la scuola di ballo "Master Ballet", segue dj Natta; 10 orch."Caravel", elezione miss fragola. Manifesto
10-11/7 Carasco (Ge) Loc. Sant'Alberto di Paggi, festa di S.Alberto. Do 10 ore 12.30 e 20 apertura stands gastronomici, ore 15 intrattenimento musicale con liscio e latini, ore 18.30 S.Messa e benedizione dei panini, ore 21 danze con orch."Primavera". Lu 11 ore 20 stands gastronomici, ore 21 danze con orch."Diego Sanguineti". Manifesto
15-16-17/7 Rapallo (Ge) Loc. S.Andrea di Foggia, festa N.S. del Carmine, stand gastronomici e ballo con ingresso libero: 15 "Giorgio Villani", 16 "Franco Bagutti e Omar Codazzi", 17 "Nicola Congiu". Do 17 ore 19 sparata di mascoli liguri, ore 23 spettacolo pirotecnico. Pullman gratuito con partenza dal cimitero di S.Pietro per la chiesa di S.Andrea.
Scopri gli Eventi in Genovese! |
Ven 15/7 Carasco (Ge) Concerto degli "Spirito nel Buio", tributo a Zucchero, giardini via Piani, sera
Sab 16/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Perché leggere i classici. Da Calvino ad Umberto Eco" Francesco Montanari. Dettagli
16-17/7 Borzonasca (Ge) Sa 16 loc. Brizzolara, discoteca con dj Kelly, apertura stand gastronomici ore 21.
Do 17 loc. Pratomollo, Raduno annuale Alpini, pellegrinaggio alla Madonna delle Nevi: ore 10 colazione alpina presso l'area attrezzata, alzabandiera, ore 11.15 S.Messa, ore 12.30 rancio al sacco (sarà presente un chiosco con porchetta, salumi e formaggi, panini), la giornata sarà allietata dalla fisarmonica di "A.Kalle"
16-17/7 S. Stefano d'A.(Ge) Festival della scultura del legno, artisti e scultori del legno all'opera dalle ore 10 in via Razzetti, dettagli
16-17/7 Sesta G.(Sp) Sagra del raviolo nel parco S.Pertini, stand gastronomici, ore 21 ballo liscio con: 16 "Dove c'è musica", 17 "Caravel"
Mar 19/7 Conscenti (Ge) Festa delle Fisarmoniche con "Enrico Roseto" nell'area verde S.Pertini ore 20, serata con piatti locali e non.
Gio 21/7 Moconesi Alto (Ge) Spettacolo musicale
21-22-23/7 Camogli (Ge) Gi 21 "Artomude Quartet" concerto jazz-fusion con brani anni ‘80-‘90, Rivo Giorgio ore 21, gratuito.
22-23 Festa di Sant'Anna, stand gastronomici, musica e danze, p.le Padri Olivetani San Prospero, bus-navetta per raggiungere il luogo
Ven 22/7 Carasco (Ge) Carascomedy presenta "Salviamo il futuro", giardini via Piani, sera
Ven 22/7 Conscenti (Ge) "Cena con delitto", ore 19 serata enogastronomica, ore 21 presentazione del libro "San Nicolao di Pietra Colice" del prof. Benente con Mario Dentone
22...25/7 Gattorna di Moconesi (Ge) Sagra del raviolo, stand gastronomici e danze con ingresso libero: 22 "Area 69" segue dj set, 23 "Roberto Polisano", 24 "Gigi l'altro" dj set discoteca, 25 "Marco e il Clan". Manifesto
22-23-24/7 Chiavari (Ge) Sagra di S.Giacomo, dalle 19 capponadda e altre specialità tipiche, nel quartiere Rupinaro.
Ve 22 "Faber libera tutti! La libertà secondo Fabrizio De André", con Alter Echo e Napo, piazza Roma ore 21.
22-23-24/7 Leivi (Ge) Festa dell'olio d'oliva nell'area sportiva S.Bartolomeo, stand gastronomici e ore 21 danze con: ve 22 "Jolly", sa 23 "Marianna Lanteri", do 24 "Caravel" ore 18.30 premiazione produttori d'olio. Stand gastronomici coperti. Manifesto
22-23/7 Borzonasca (Ge) Festa della birra, stand gastronomici con 6 tipi di birra, dalle ore 21: ve 22 spettacolo danzante coi bambini, spettacolo comico con Alessandro Bianchi dei Pirati dei Caruggi, segue dj Kelly; sa 23 musica con "Fabio Casanova", segue discoteca 2 Crazy dj
22-23-24/7 Sestri L. (Ge) Loc. Riva T, Sagra del Bagnun: ve 22 ore 21.30 concerto filarmonica; sa 23 ore 19.30-23.30 distribuzione gratuita del bagnun, ore 21.45 ballo con orch."Primavera", ore 23.30 spett. pirotecnico; do 24 ore 12 stand gastronomici, ore 21.30 spettacolo musicale con orch."Discomania".
Sab 23/7 Chiavari (Ge) Festa del Perù: ore 10 visita guidata agli edifici che nel 1900 hanno ospitato gli undici consolati stranieri, prenotazioni allo 0185/323230; ore 21 in p.zza N.S. dell'Orto spettacolo di tango, ingresso gratuito.
Sab 23/7 Statale di Ne (Ge) "E...state a tutta birra" serata enogastronomica con musica di Massimo dj69
Sab 23/7 Deiva M.(Sp) Dj set generation sound, Schiuma party, spiaggia libera dalle ore 22
23-24/7 Lavagna (Ge) Festa dell'agricoltura nei giardini della scuola Riboli e p.za Innocenzo IV, stand gastronomici e ballo con: 23 "Sandro musica nel cuore", 24 "Diego Sanguineti".
Vuoi ridere? Clicca qui! |
23/7...4/8 Lavagna (Ge) Festivart, Festival di arte, poesia e musica di strada
23-24/7 S. Stefano d'A.(Ge) Campionato regionale di Trial, dettagli
Mar 26/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Parazzuolo, ore 16.45 festività di S.Anna; loc. Casaleggio, ore 18.30 Festa in Agorà, spettacolo di animazione per bambini
26-27/7 Camogli (Ge) Ma 26 "Questi posti davanti al mare" Giua e i Cantautori, live intenso e acustico, dalle sfumature jazz, che vede la canzone d'autore e la Scuola genovese protagoniste, Rivo Giorgio ore 21, gratuito.
Me 27 Reggae Roots, a seguire Dj set di musica giamaicana storica, Rivo Giorgio ore 21, gratuito
28/7...1/8 S.Salvatore di Cogorno (Ge) Il ritorno dei ravioli casalinghi, presso Croce Rossa, ore 19 stand gastronomici, ore 21 ballo con: 28 "Caravel", 29 dalle ore 22 discomusic con "Hypnoisia", 30 "Enrico Roseto", 31 "William band", 1 "Caravel"
Ven 29/7 Carasco (Ge) Premiazione miglior uliveto, a seguire concerto di Michele Fenati, giardini via Piani, sera
29-30/7 Mezzanego (Ge) Loc. Vignolo, festa S.Lucia, stand e serata danzante con: 29 discoteca "dj Kelly", 30 "Marino Castelli"; pista in acciaio, parcheggio con servizio navetta
29-30-31/7 Camogli (Ge) Festa sociale della Croce Verde, animazione e musica in spiaggia e stand gastronomici, Rivo Giorgio ore 21
29-30-31/7 Rapallo (Ge) Sagra dell'asado e del fritto misto di pesce, nel parco Nicolò Cuneo via Tre Scalini 7; ore 19 stand gastronomici, ore 21 musica con: ve 29 "Daniele Cordani", sa 30 "Fabio Cozzani", do 31 karaoke con Luca Carboneri. Info 351.6613084
29-30-31/7 Lorsica (Ge) Sagra della tagliata, cena e ballo con: 29 "Marino Castelli", 30 "William band", 31 "A.Kalle"
Sab 30/7 Gattorna di Moconesi (Ge) Notte bianca, dettagli
Sab 30/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Vicosoprano, commedia dialettale "O nêvo" comp. Quelli de 'na vòtta, ore 21
Dom 31/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Ristrutturazione" Sergio Rubini. Dettagli
Dom 31/7 Sestri L. (Ge) Barcarolata, ore 21.30 baia di Portobello tradizionale sfilata di imbarcazioni con addobbi, premiazione; segue spett. pirotecnico
AGOSTO 2022
Mar 2/8 Conscenti (Ge) A Tavola in val Graveglia, serata di sapori tradizionali, accompagnati dalla musica di "Trio e Trio", area verde S.Pertini dalle ore 19.30.
Mar 2/8 Deiva M.(Sp) Spettacolo teatrale "Liberatutti" compagnia ScenaMadre, piazza Bollo ore 21.30 ingresso gratuito
Mer 3/8 S.Stefano d'A.(Ge) Fisarmonicando con orch."Paolo Bertoli" e ospiti, ore 21
4...7/8 Sestri Levante (Ge) Amici del Ponte in festa, parr. S. Stefano, stands e ballo con: 4 "Jolly", 5 "Caravel", 6 "Roller Folk", 7 "Angelo Minoli". Manifesto.
Ven 5/8 Zoagli (Ge) Festa Madonna del mare: ore 21.30 S.Messa sulla spiaggia, benedizione corona in riva al mare e posa lumini, ore 22.30 in piazza dj set in rosa con Rambo dj.
5-6-7/8 Sori (Ge) Loc. Canepa, festa patronale di Sant'Eusebio: ore 19.30 stand gastronomici. Ve 5 ore 21.30 ballo liscio con "Les Crikò"; sa 6 ore 21.30 palio degli asini, tutti in pista con "One More Time"; do 7 ore 20 vespro e processione, ore 21.30 concerto banda di Camogli. Manifesto
Ti piace il sito? Dillo a un amico! |
5-6-7/8 Lavagna (Ge) Quattro Palanche, affari e occasioni per le vie del centro, orario 9-23 (dom 9-13)
5-6/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Priosa, festa N.S. della Neve, dalle 18.30 stand gastronomici, serate danzanti: ve 5 ore 21 orch."William band", ore 22 distribuzione gratuita frittelle di mele; sa 6 ore 21 orch."A.Kalle", esibizione allievi della Janua Accademia Danze Ge. Ve 5 ore 16 Messa, Processione e pesca di beneficenza. Manifesto
5-13-19-26/8 Deiva M.(Sp) "DeivArte… sotto la luna" artigianato artistico e creativo di qualità, sul lungomare ore 19-24
Sab 6/8 Borzonasca (Ge) Loc. Brizzolara, sagra della porchetta, ore 19 stand gastronomici, ore 21.30 orchestra "Tonya Todisco".
Sab 6/8 Sestri L.(Ge) Sagra da sardenn-a pou feugo, distribuzione gratuita di sarde alla griglia, in p.tta M.Antonietti dalle ore 19; mostra di ceramiche modellate a mano da R.Giannotti
Sab 6/8 Maissana (Sp) Loc. Tavarone, Wild West, gastronomia, musica folk e dj set con Roberto Geo Cerchi
6-7/8 Cicagna (Ge) Notte Bianca fino oltre le ore 24: sa 6 a Cicagna, do 7 a Monleone.
6-7-8/8 Avegno (Ge) Loc. Salto, festa N.S. della Salute, ore 19 stand gastronomici e ore 21 danze con: sa 6 "Marco Rinaldi" e i suoi "Eroi Superbi", do 7 ore 10.30 e 20.30 S.Messa, lu 8 musica coi "Jolly". Si svolgerà anche in caso di pioggia (stands gastronomici al coperto) Manifesto
6-7-8/8 Coreglia Lig.(Ge) Loc. Canevale, festa di S. Giacomo, servizio ristoro; ore 21 ballo con: sa 6 "Primavera", do 7 "Caravel", lu 8 "Giannarelli Pietrelli". Do 7 ore 18 tradiz. corsa col santo a cavallo. Manifesto
6-15-20-27/8 Lavagna (Ge) Creativamente in libertà, artigianato artistico e creativo di qualità, piazza della Libertà ore 18.30-24
6-7-8/8 S.Stefano d'A.(Ge) 6-7 Arte è femmina, mercatino femminile. Sa 6 ore 21 commedia dialettale. Lu 8 dalle ore 17: Le Miss in vetrina e finale reg. Miss Blumare
Dom 7/8 Camogli (Ge) Festa della Stella Maris: ore 10.15 uscita del Dragun e delle barche, ore 11 benedizione barche e Messa all'aperto a Punta Chiappa, alla sera posa lumini in mare, segue spettacolo in mare; info 0185-771066 (1° dom d'agosto). Dettagli (PDF).
Sa 6 Aspettando la Stella Maris, concerto della banda di Camogli, ore 21.
Dom 7/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Intorno a Paganini" (fisarmonica e violino), sagrato S.Lorenzo ore 21.15, Manifesto
*8-9-10/8 S.Margherita (Ge) Loc. S. Lorenzo d. Costa, Festa di S.Lorenzo serate danzanti: 8 "Caravel"; il 10 ore 12 sparata di mortaletti, ore 22.30 sparata mortaletti a terra e spettacolo pirotecnico
9-10/8 Conscenti (Ge) Ma 9 Commedia ge "Giacomin, bello e fantin" comp. I Ruspanti, ore 21. Me 10 Festa San Lorenzo, A tavola sotto le stelle: ore 19.30 serata enogastronomica, ore 22 salotto musicale con "Vilma Goich e il Pentagramma"
Mer 10/8 Sestri L.(Ge) Sagra del Minestrone alla genovese in p.za Matteotti, inizio ore 19. Manifesto
Mer 10/8 Camogli (Ge) "Ma se ghe penso", Laura Parodi Trio & Gruppo spontaneo Trallallero con canti, musiche e racconti delle Tradizioni liguri, Rivo Giorgio ore 21.15 gratuito
10...12-20/8 Chiavari (Ge) Sbarassu, vendita nei negozi di rimanenze di magazzino: 10-11-20 centro, 12-21 lungomare e porto
Gio 11/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Alpepiana, serata in musica con Michele Fenati "Lucio, Dalla e Battisti per la prima volta insieme", circolo Lagin ore 21.15
11-12/8 S.Stefano d'A.(Ge) Gi 11 ore 21 serata dj con Hypnosia eventi; Ve 12 ore 21 giro delle piazze del Coro La Contrada
12-13/8 S.Salvatore Cogorno (Ge) Ve 12 Medioevo nel borgo, dame, cavalieri, contadini, giullari, sputafuoco e antichi mestieri: ore 17 esibizione di falconeria, ore 18 la via del giullare, ore 19 stand gastronomici, ore 21.15 concerto "Dal Medioevo alle tradizioni popolari" Ensemble Enerbia.
Sa 13 "Addio do Fantin", rievocazione storica-medioevale de "l'addio al celibato" del conte Opizzo Fieschi, allietato da balli e musiche antiche, giochi di bandiere e figure d'armi, con i Sestieri di Lavagna, le Gratie d'amore ed i Cavalieri del Fiesco, ore 21. È stato istituito un servizio bus navetta gratuito che alla fine dell’evento riaccompagnerà dalle ore 23 i turisti a Lavagna e Chiavari; il percorso prevede il passaggio da p.zza Cordeviola a Lavagna per terminare alla Stazione ferroviaria di Chiavari.Manifesto, Video
12-13-14/8 S.Stefano d'A.(Ge) Beer Festival, birra artigianale, street food e musica, dettagli
Sab 13/8 Camogli (Ge) Omaggio a Giuseppe Mazzini, concerto che si inserisce nelle celebrazioni del 150° anniversario della morte, Chiostro N.S. del Boschetto ore 21.15 ingresso libero
Sab 13/8 Chiavari (Ge) Spettacolo di tango in p.zza N.S. dell'Orto, ore 21 ingresso gratuito.
13-14/8 Deiva M.(Sp) Sa 13 White Night, musica e animazione con "New Generation Sound" dalle ore 22, ingresso libero, info 0187/815858-826123.
Do 14 ore 23 spettacolo pirotecnico sul mare.
13...15/8 Uscio (Ge) Loc. Calcinara, festa N.S. dell'Assunta, stand gastronomici e musica. 13 ore 22 "Radio Ga Ga"; 14 ore 14 gara scopone, ore 22 "Explosion"; 15 ore 18 processione, ore 22 cabaret con "Enzo Paci e Romina Uguzzoni" segue dj F.Fontes. Manifesto
13...15/8 Favale (Ge) 39° sagra del Vino bianco, specialità alla piastra e asado, ore 21 ballo con: 13 "Caravel", 14 "Giuse e Alessia", 15 "Serena". Manifesto
13...15/8 Casarza L.(Ge) Sagra del calamaro e gusto di mare, serate danzanti con: 13 "Diego Zamboni", 14 "W.Giannarelli", 15 "Macho".
Dom 14/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Trio jazz/fusion" (batteria, basso e chitarre), sagrato S.Rufino ore 21.15, Manifesto
*Dom 14/8 Lavagna (Ge) Torta dei Fieschi ore 22 p.zza V. Veneto
rievocazione storica delle nozze tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna Bianca De Bianchi avvenute nel 1230, gioco delle coppie: si acquista un biglietto (azzurro per i maschi, rosa per le femmine) recante sopra un nome, bisogna trovare il biglietto con lo stesso nome ma di colore diverso dal proprio, ed insieme si ritira la porzione di torta; corteo storico, palio d'armi, sbandieratori. Si consiglia l'uso del treno.
14-15/8 Ruta di Camogli (Ge) Sagra delle focaccette nel giardino parr. della chiesa di S.Michele, ore 18-22 stand gastronomico, bancarelle
14-15/8 Sestri L.(Ge) Loc. Montedomenico, sagra dei testaieu e asado, ballo con ingresso libero: 14 "Caravel", 15 "Roller Folk". Montedomenico si raggiunge dallo svincolo autostradale di Sestri, per S.Vittoria
Lun 15/8 Borzonasca (Ge) Loc. Sopralacroce, ferragosto a Sopralacroce, ore 19 stand gastronomici e serata danzante con "William band" ingresso libero, info e prenotazioni 340.3298657 334.9211077
*Mar 16/8 S.Rocco di Camogli (Ge) 61° Premio internazionale Fedeltà del Cane: ore 16 presentazione delle storie dei cani, premiazione e benedizione cani
16/8 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Enzo Paci Show" Enzo Paci. Dettagli
16-17/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Villanoce, festa di San Rocco, animazione per bambini con "Sabry la birba" e serata musicale con "A.Kalle"; me 17 festa campestre, gara di bocce a coppie sui prati.
Ma 16 loc. Alpepiana, festa di S.Rocco, serata danzante con "Caravel", info 0185.85513
Mer 17/8 S.Stefano d'A.(Ge) Loc. Amborzasco, sagra itinerante, un viaggio alla scoperta dei sapori della nostra tradizione: ore 11.30 stand gastronomici, ore 14.30 spettacoli e musica con la compagnia teatrale "Spettacolo senza mura" e gli "Spunciaporchi", ore 17 merendin al vecchio mulino. Dettagli
Gio 18/8 Lavagna (Ge) Serata danzante con orch."Caravel" in piazza V.Veneto
19-20-21/8 Rapallo (Ge) Loc. S.Massimo, Te lo do io il raviolo! ore 19.30 stand gastronomici, ore 21 ballo con: 19 "Caravel" ed esibizione scuola ballo Maury Sport, 20 dj "Angiolini", 21 "Lara Agostini"; dalle 19 servizio navetta gratuito con partenza dal piazzale sovrastante Valle Christi
19-20-21/8 Statale di Ne (Ge) Festa di S.Bartolomeo: ve 19 ore 21 tombolata, servizio bar e testaieu; sa 20 ore 19 cena all'aperto, musica dal vivo e karaoke con "Roberto Rossi"; do 21 ore 12-19 gastronomia, ore 17 Messa e Processione, ore 21 danze con "Caravel"
Paolino è su facebook! |
Sab 20/8 Camogli (Ge) Equipe 84 la storia, presso Rivo Giorgio ore 21.30, gratuito
Sab 20/8 Rapallo (Ge) Orange night, indossa qualcosa di arancione: ore 20 menu con prenotazione (bevande comprese), serata ad ingresso libero con orch."Sandro" presso campetto parr. via Fico 3, info e prenotazioni 335.5954769
*20-21/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Cabanne, sagra del minestrone con stand gastronomici e serate danzanti a ingresso libero. Sa 20 minestrone gratis per tutti, ore 16 S.Messa e processione segue intrattenimento per bambini e truccabimbi, ore 21 ballo con orch."Bagutti".
Do 21 ore 21 ballo con "Pietro Galazzi"; si svolge anche in caso di pioggia. Manifesto Dettagli
20...24/8 S. Colombano C.(Ge) Loc.Vignale, Festa S.Rocco, do 21 ore 17 concerto della banda di Casarza L. Danze: 20 "Primavera", 21 "Enrico Cremon Notte Italiana", 22 "Mister Domenico", 23 "Luca Canali", 24 "Ringo & Athos Bassissi". Manifesto
20-21/8 S. Stefano d'A.(Ge) Sa 20 ore 21.30 concerto dei Buio Pesto. Do 21 festa patronale N.S. di Guadalupe, concerto della banda e del Coro polifonico.
Dom 21/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Vissi d'arte" Praeludium Ensemble, sagrato S.Bartolomeo ore 21.15, Manifesto
Lun 22/8 Recco (Ge) Concerto dei Trilli con la band al completo, ospite Massimo Morini, sul lungomare ore 21.30 gratuito
25...28/8 S. Colombano Certenoli (Ge) Expo Fontanabuona-Tigullio: rassegna di artigianato, prodotti agricoli e per l'agricoltura, risparmio energetico, cucina e gastronomia, attività per bambini. Parco esposizioni Fontanabuona Cálvari, ingresso libero. Orario: 15-23, dom 10.30-22.30. Dettagli.
Do 28 ore 21 commedia in zeneize "Giacumin, bello e fantin" comp. I Ruspanti.
Ven 26/8 Casarza L.(Ge) Gran Galà d'estate in favore della Croce Verde, ballo con orch."Caravel", ore 19.30 stand gastronomici, in piazza Unicef
26...29/8 Rapallo (Ge) Tigullio Expo: artigianato, musica, eventi culturali, enogastronomia, sul lungomare e centro storico
26-27-28/8 Maissana (Sp) Loc. Tavarone, Sagra del fungo, gastronomia e serate danzanti con: 26 "Paolo Bertoli", 27 "Caravel", 28 "Primavera"
*Sab 27/8 S. Stefano d'A.(Ge) Pellegrinaggio al monte Maggiorasca in onore di N.S. di Guadalupe
Dom 28/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Napo canta De André", sagrato del Curlo ore 21.15, Manifesto
Dom 28/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Lovari, festa Sacro Cuore di Maria: ore 11 Messa con Processione, coro Voci d'Alpe S.M.L. ore 12.30 pranzo al circolo Lagin di Alpepiana, info e prenotazioni 0185.85513 o 328.1756690 programma
Dom 28/8 S. Stefano d'A.(Ge) Loc. Alpicella, Se batte u gran: ore 12 menu completo €20, ore 16 si batte il grano, canti e balli, info e prenotazioni 329.1525803
Mar 30/8 Chiavari (Ge) Gran Galà delle Fisarmoniche con gli allievi del m° Enrico Roseto, ospiti: Marianna Lanteri, Marco Valenti, Giuse & Alessia, Veronica Cuneo; in p.zza Madonna dell'Orto ore 21 ingresso gratuito
CARLO GATTI
Rapallo, 31 Maggio 2023
IL LEUDO DI MOSE' BORDERO
IL LEUDO DI MOSE' BORDERO


CASA GOTTUZZO
Rione Scogli - Chiavari
Nel 1997 il Comandante Ernani Andreatta fonda il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che prende il nome anche dal suo co-fondatore Franco Tommasino detto “Mario”.
Sino al 2001 viene ospitato nei locali sottostrada dell’Antica Casa Gotuzzo a Chiavari. Dal 2001 sino al 2008 il Museo è stato ospitato presso gli uffici della Promo-provincia a Calvari, in Val Fontanabuona. Nel 2008, la Scuola Telecomunicazioni FFAA di Chiavari, consapevole della rilevanza storica e tradizionale del Museo Marinaro e allo scopo di preservarne e valorizzarne il patrimonio culturale decise di ospitarlo al suo interno assieme alla notevole biblioteca, principalmente di mare, che raccoglie oltre 6.000 volumi.
Proprio nel 2013 il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta ha avuto il riconoscimento dello (SMM) Stato Maggiore della Marina e nel completamento della pratica di acquisizione da parte del Ministero della Marina, sarà affiancato ai Musei Navali di Venezia e di La Spezia.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accertato l’interesse culturale della raccolta ne ha proposto la tutela e la valorizzazione con modalità da concordare.
Sono stati scritti molti libri ed articoli sul LEUDO che per noi rivieraschi rappresenta un pezzo di storia nata, navigata e vissuta nel levante ligure. Anche noi di Mare Nostrum Rapallo abbiamo scritto “quasi tutto” su questa imbarcazione che ancora oggi ci attira, c’incuriosisce ed ogni volta che trattiamo questo argomento, scopriamo dentro di noi un desiderio sempre più forte di conoscenza!
L’occasione per ritornare sul mondo dei LEUDI ce l’ha data, ancora una volta, il nostro socio fondatore Comandante Ernani “Nanni” Andreatta i cui avi, come sapete, costruivano grandi velieri oceanici, ma anche i LEUDI nel Cantiere di famiglia nel Rione Scogli a Chiavari.
MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA - CHIAVARI
https://www.marenostrumrapallo.it/nanni-2/
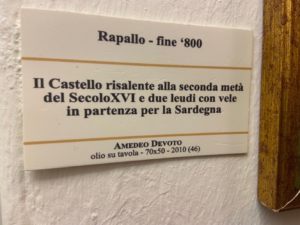
Amedeo Devoto, dipinto di due Leudi ancorati nella zona antistante le CLARISSE. Sullo sfondo si scorge il cinquecentesco Castello di Rapallo con relativa didascalia.
La foto è la copia “perfetta” che si può ammirare nel Museo Marinaro – L’originale si trova nell’entrata di casa Gottuzzo-Andreatta per omaggiare il LEUDO ed anche la città di Rapallo.
LA STORIA DEI LEUDI NON E’ ANCORA FINITA …
IL LEUDO DI MOSE’ BORDERO
Andreatta racconta: "Nel Novembre 2020, siamo stati invitati a visitare il leudo in costruzione di Mosé Bordero. Il compianto Sindaco di Chiavari Marco di Capua con suo padre Pino, ex Maestro d’Ascia con cantiere a Lavagna in via Dei Devoto (per anni ha sfornato un gozzo al mese)".

Da sinistra Mosé Bordero, Pino Capua, Ernani Andreatta ed il compianto sindaco di Chiavari, Marco Capua.



Giancarlo Boaretto racconta:
“Mosè Bordero sta completando un LEUDO, realizzato il legno lamellare - lui è a metà tra gli 80 e i 90... Pochi fogli costruttivi gli sono bastati; con l'aiuto di PC - un ingegnere abilitato ha firmato il suo progetto.
credits: Teleradiopace
Quando si commissionava un nuovo leudo, la prima cosa da fare era di decidere la lunghezza... il mastro d'ascia e il committente si incontravano sulla spiaggia, il maestro lanciava un sasso: "va bene così?", se no, non un altro sasso ... un numero in metri non sarebbe stato capito da nessuno...
Cos’hanno scritto i media?
01 Aprile 2010 | in categoria/e attualità
RICOMPAIONO I LEUDI
Su facebook migliaia di fan e Mosé Bordero, maestro d'ascia, ne costruisce uno.

Leudo - FELICE MANIN
Tornano i LEUDI sulle spiagge del Levante. Si tratta di antiche barche a vela latina, nate e diffuse nel golfo del Tigullio. Il loro disegno inconfondibile è apprezzato in tutto il mondo: gli Stati Uniti alcuni anni fa hanno restituito il Felice Manin alla Liguria, che però lo ha tragicamente lasciato marcire sulla darsena di Spezia.
Il nome LEUDO deriva dalla forma di “liuto”, le barche venivano utilizzate per il commercio di olio, vino, sabbia, pecorino con l’isola d’Elba e la Sardegna. I LEUDI sono stati una fonte di ricchezza e di scambi culturali: fino agli anni ’80. Sestri Levante era la città più aperta e dinamica del Levante, essendo terra di imprenditori e commercianti che andavano da soli per il Mediterraneo.
Adesso si cerca di recuperare alcune delle barche che riempivano le baie e le spiagge, da Riva Trigoso a Chiavari, e Mosé Bordero sta costruendo da solo con l’arte dei maestri d’ascia un nuovo leudo, in un capannone di Casarza Ligure.
Non è da solo: Giovanna Bregante–imprenditrice nel settore turistico e componente di un’antica famiglia sestrina - cerca di riportare in città la cultura della marineria. In attesa di un’associazione, è nato il gruppo Facebook “Tornano i leudi da ponente”, in crescita continua, grazie a una serie di felici concause, a partire dalla meritoria opera di Bordero. “Questi antichi simboli non fanno parte delle cose da buttare, ma possono essere decisivi per far ripartire il settore turistico”, sostiene Giovanna Bregante.
Anche altrove si ritorna alla tradizione del mare. A Chiavari il comandante Ernani Andreatta ha creato il museo della marineria in “piazzetta dei pescatori”. E’ chiavarese anche Luciano Costa, ora trasferitosi a Modena da dove cerca di salvare dal degrado tre barche tra cui un leudo. Il problema principale è quello dei costi necessari per recuperare dei monumenti di straordinario valore, dei musei vivi da piazzare in mare e sulle spiagge per connotare il paesaggio marino e dare al Tigullio un profilo finalmente diverso da Rimini o dalla Costa Brava. Si deve evitare il ricorso alla logica perdente dei finanziamenti pubblici (necessari solo per la fase iniziale). Il Comune di Lavagna aveva risistemato un leudo, dedicandolo al “charteraggio”, ma l’esperimento è fallito.
Servono piuttosto imprenditori privati con idee dinamiche.
Si potrebbero trasformare i leudi in boutique naviganti o in ristoranti con menu di mare straordinari. Si creerebbe così un’offerta turistica unica e imbattibile. Meglio però pranzare su leudi ormeggiati, per evitare che il cibo vada di traverso…
Ridare al leudo la sua missione commerciale originale è una via di salvezza fantastica, se vogliamo utilizzarli anche per finalità culturali pubbliche senza gravare sui bilanci comunali.
Si deve fare attenzione alle museificazioni pure e semplici: un disegno di Legge dell’on. Mondello giace in parlamento da anni, ma il comune di Sestri Levante si è impadronito dell’idea ed ha imposto alla Regione il finanziamento di 300.000 euro per la realizzazione di un Museo del mare nel Palazzo Fascie-Rossi.
Una determinazione dirigenziale del 2008 ha appaltato alla coop Terramare l’incarico di recuperare dati e documenti sui leudi e la marineria (con una spesa di 20.000 euro). Tra i siti indicati per lo studio non risultano i pur ricchi archivi del Comune di Sestri, da troppi anni abbandonati al loro destino in Piemonte.

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 22 MAG.2021 - Varo storico oggi a Sestri Levante: è tornato in acqua l'ultimo leudo navigante della Liguria il:
"NUOVO AIUTO DI DIO"
Il leudo è una barca a vela latina che ancora fino alla fine del Novecento veniva utilizzata in Liguria per attività di trasporto merci.
L' imbarcazione varata oggi è lunga 15 metri, oltre a 5 metri del bompresso, fu costruita a Sestri Levante nel 1925, navigò verso la Sardegna per il trasporto del formaggio e l'Isola d'Elba per il trasporto di vino per poi cessare la attività commerciale. Dopo decenni di sosta sull'arenile nel 2010 nacque l'Associazione amici del leudo che con numerose iniziative promozionali è riuscita a riportare il 'Nuovo aiuto di Dio' agli antichi fasti. Rifatti i circa 150 metri quadrati di velatura latina e sistemato il fasciame il leudo, che può trasportare fino a 20 persone, dalla prossima settimana inizierà il suo programma estivo di mini crociere nel mar Ligure oltre ad alcuni concerti musicali che saranno organizzati nel porto sestrese.
Arriva dalla Scozia un aiuto per risistemare il Nuovo Aiuto di Dio, unico leudo sopravvissuto sulle spiagge di Sestri Levante. I lavori saranno eseguiti in spiaggia col contributo del Consorzio Tassano. L’armatore, il commercialista Traversaro, pensa di tornare al varo e all’alaggio annuale della barca, un evento che già di per sé costituisce uno spettacolo di sicuro richiamo.
Paolo Della Sala
LEVANTE NEWS – LA VOCE DEL TIGULLIO
Sabato 8 gennaio alle 17.00, nella sede della Lega Navale di Chiavari (box 51 porto turistico), si chiuderà la rassegna culturale “Uomini e Navi”. Protagonista dell’ultimo incontro sarà Mosè Agostino Bordero, che parlerà dell’incantevole mondo dei leudi, splendide barche, viste con gli occhi e l’esperienza di un comandante ed armatore. Bordero sta costruendo da anni, con le proprie forze, la copia fedele dell’antico leudo presente in passeggiata mare a Sestri Levante, chiamato “Con l’aiuto di Dio”. Un lavoro portato avanti con passione e tenacia, per un progetto tutto da scoprire.
“E’ da 3 anni che sto portando avanti questo lavoro nel cantiere di Masso (Casarza ligure) – racconta Mosé Bordero - Un leudo di due metri più grande rispetto alla sua copia, in passeggiata mare a Sestri levante e del quale possiedo il piano di costruzione. La barca potrà trasportare 300 quintali e andare in mare: il varo, quando Dio vorrà, ma la costruzione è già a buon punto. Oggi, grazie al computer, a colle innovative e nuovi materiali, anche un non maestro d’ascia come me può costruire un favoloso leudo”.
Mosè Agostino Bordero
“Uomini e Navi” è un ciclo di incontri promossi dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna, patrocinati dalla Provincia di Genova e dal Comune di Chiavati, nati con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare la cultura del mare. La rassegna è giunta quest’anno alla terza edizione: 8 gli incontri svoltisi con esperti, in settori diversi, del vasto patrimonio del mare, a partire dal 6 novembre sino all’8 gennaio.
L’appuntamento si è svolto al sabato, alle 17, nella sede della Lega Navale guidata dal presidente Gian Battista Nicolini: luogo, il porto turistico di Chiavari Amm. Luigi Gatti, nel box numero 51. Durante i pomeriggi gli incontri sono stati affiancati da video e proiezioni, per una visione completa del tema affrontato.
Video girato nel Dicembre 2009
http://www.youtube.com/watch?v=F8ThU4qhXC8&feature=player_embedded#!
Il leudo di Mosè Bordero esce dal capannone
06 Settembre 2012 alle 13:541 minuto di lettura

Casarza Ligure - Il primo passo è compiuto. Il leudo di Mosè Bordero si trova oltre la soglia del capannone dove è stato, almeno fin qui, costruito. Ieri mattina, una gru l’ha sollevato e poggiato sopra il camion che stamattina lo ha condotto in via De Gasperi, nell’area accanto alla cooperativa Tassano messa a disposizione dal Comune di Casarza.
“Malgrado non sia ancora finito, è già abbastanza solido perché poggi su due cunei laterali “ - afferma Bordero, unico costruttore di “Con l’aiuto di Dio” -. “Occorrerà una mezz’ora per raggiungere il parcheggio e poi un mesetto per montare le capriate a protezione del leudo e proseguire i lavori”.
Sul piazzale, tappa del primo viaggio, "del leudo su strada", Bordero costruirà anche la copertura in legno che gli consentirà di ultimare i lavori in sicurezza, senza la preoccupazione delle intemperie.
Il capannone di Masso, dove si trovava fino a ieri, ha dovuto abbandonarlo per via del contratto di locazione scaduto e rinnovato dal proprietario con un altro inquilino. Quando aveva scelto la scadenza, confermando di lasciare il sito alla fine di maggio, Bordero contava di spostarsi sulla spiaggia di Riva, per trasformare la sua impresa – la costruzione di un leudo in solitaria, all’età di 83 anni – in un’esperienza pubblica, culturale e didattica.
«Pensavo di finire il lavoro nel posto che un tempo brulicava di leudi, non a caso ribattezzati “rivani” – afferma -. Con un po’ di rammarico ho dovuto abbandonare quella possibilità, perché contro la burocrazia preferisco non scontrarmi».
Ripete che se gli intoppi e le difficoltà tecniche non lo spaventano, delle scartoffie ha timore eccome.
Sulla spiaggia di Riva non avrebbe potuto montare la copertura in legno, ma accontentarsi di un telone provvisorio; e visto che la decisione definitiva continuava a slittare ha tentato con l’amministrazione di Casarza che ha detto sì alla sua richiesta. Da domani e per un paio d’anni ancora, Bordero, maestro d’ascia autodidatta, sarà in via De Gasperi a martellare, aggiungere componenti e rifiniture alla barca di cui va fiero: «è il simbolo dell’intelligenza dei liguri» dice, aggiungendo che alcuni conoscenti stanno avviando la pratica per annoverarlo come patrimonio dell’umanità dell’Unesco.
LEUDO
“NUOVO AIUTO DI DIO”
Una vela latina
impaginazione e foto di Pighin (SESTANTE)
Il "Nuovo Aiuto di Dio", quando ormai tutto sembrava perduto, è stato restaurato da Mosé Bordero.
Racconta Pighin: [ nel 2002 Bordero mi permise di salire a bordo del Leudo per fare un po' di documentazione fotografica ... sapevo che era una occasione quasi irripetibile ... con questo spirito, e con molto meno esperienza di adesso con la fotocamera, ho proceduto tentando di non dimenticare nulla ... intanto è documentata l'ancora originale, che ora non c'è più perché rubata ... n.d.r. ]
... Pensate che nel 1800 due velieri, al largo di Vernazza, sono entrati in collisione; poi c’è stato un processo e chi ha sbagliato è stato condannato perché aveva creato intralcio sulla “pubblica via”. Quindi il mare era considerato la “pubblica via”, non c’erano altri mezzi. Quindi era necessario avere un veliero che fosse veloce, che avesse una grossa capacità di carico e che contemporaneamente avesse un’ottima tenuta di mare ...
... È lungo da 15 a 16 metri, perché? Perché ha un peso che può essere tirato in secco sulle spiagge, se fosse più grande potrebbe creare dei problemi per tirare in secco sulle spiagge. Perché tirare in secco? ...
[ Per la mancanza di una rete capillare di porti, ma anche per economia nella gestione ... stare all'ancora in un porto attrezzato può costare, stare in mare tutto l'anno a fronte di pochi viaggi brevi avrebbe causato maggiore usura dell'opera viva, con relative spese ... le spiagge di Riva e Sestri Levante erano gratuite ... quando erano in secco i leudi erano coperti da teli, ricordo la cura infinita, quotidiana, nel controllare che essi coprissero il sole in modo perfetto ... sapevo che ciò era molto importante per preservare lo scafo dalle intemperie, e che, cosa ancora più importante, era "non spendere" in manutenzione, avrebbe compromesso la sussistenza dell'impresa ... n.d.r. ]
da una conversazione del 2002 di Mosé Bordero: Bagni Liguria - Sestri Levante
La spiaggia era tutta per le barche
Anno 1910

LEUDO
“NUOVO AIUTO DI DIO”
VISTO DA VICINO....ANZI A BORDO!
Uno sguardo di assieme: "Vista da poppa"

Uno sguardo di assieme: "vista da prua"

Uno sguardo di assieme: "vista laterale"

Una parte emersa molto arcuata: "la coperta"

Il futuro si vede da qui: "la zona di prua"

L'innesto del bompresso: "è il secondo albero, quello per il fiocco"

E' da qui che si conduce la barca: "la zona poppa"

Lo strumento di governo: "il timone"

L'organo di propulsione a partire dal dopo-guerra: "l'elica"

Le correnti galvaniche consumano le placche invece che l'elica:
"sono di zinco puro"

Questo strumento misura la velocità: "è il solcometro"

La parte immersa nell'acqua si chiama "opera viva":
"la chiglia e il dritto di prua"

La barca è molto panciuta, ciò favorisce la capienza: "la fiancata"

Questa è la paratia di protezione del ponte: "la battagliola"

Anche sopra coperta tutto è curvo: "la battagliola da dentro"

Per sostare alla fonda in sicurezza: "l'ancora"

Per superare la calma piatta, o per attraccare in sicurezza: "i remi"

La forcella per l'appoggio del remo: "lo scalmo"

Un semplicissimo strumento per l'orientamento: "la bussola"
Bisogna anche farsi vedere di notte: "il fanale"

E' il sostegno della vela latina: "l'antenna"

L'antenna è sostenuta da un sistema di funi e nodi: "l'imbracatura"

Anche l'albero inclinato è sostenuto da funi: "uno strallo"

Demoltiplicando tutto rallenta, ma le forze applicate sono immense:
"la tagliola"

Il leudo "Nuovo Aiuto di Dio" in navigazione nel Mar Ligure [anno 2013]:
"il Golfo del Tigullio"


COMPLIMENTI E UN GRAZIE DI CUORE A PIGHIN E AGLI AMICI DEL SESTANTE PER QUESTO BELLISSIMO SERVIZIO FOTOGRAFICO CON DIDASCALIE ECCELLENTI E PRECISE
AMANTE O DRIZZA D’ANTENNA E SCIONCO

Bozzello che serviva alla manovra dell’Antenna che portava inferita la vela del Leudo per issare o ammainare l’antenna viene usato un complesso composto da un paranco.
(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari – foto C.Gatti)

Bozzello a 5 cavatoie
Concludo il servizio con l’immagine dell’unico esemplare esistente di ARGANO A MANO utilizzato per virare il LEUDO a riva.
(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta. Foto C. Gatti)

MARE NOSTRUM RAPALLO - DOVE SI PARLA DI LEUDI ...
ISOLA DELLE CHIATTE - GENOVA – PORTO ANTICO
https://www.marenostrumrapallo.it/isola-delle-chiatte-genova-porto-antico/
CANCARONE E VINO NAVIGATO
https://www.marenostrumrapallo.it/cancarun/
LA GALLETTA DEL MARINAIO
https://www.marenostrumrapallo.it/juan/
SAN PE', L'ULTIMO MARINAIO DEL '900
https://www.marenostrumrapallo.it/bobba/
LEUDO, UNA MANOVRA PARTICOLARE...
https://www.marenostrumrapallo.it/leudo/
NEL MONDO DEI LEUDI
https://www.marenostrumrapallo.it/nel-mondo-dei-leudi/
DA TRELO ALLE MERICHE
https://www.marenostrumrapallo.it/juan-2/
CHIAVARI - RIONE SCOGLI
https://www.marenostrumrapallo.it/ciassa-di-barchi/
IL RIMORCHIATORE D'ALTURA BRASILE NEL MISTRAL!
https://www.marenostrumrapallo.it/mistral/
A cura di Carlo GATTI
Rapallo, 8 Maggio 2023
THOR HEYERDHAL - L'ULTIMO GRANDE ESPLORATORE
THOR HEYERDHAL
L’ULTIMO GRANDE ESPLORATORE
LA NORVEGIA - TERRA DI GRANDI MARINAI
La Norvegia ha una popolazione di 5.000.000 di abitanti, la metà della regione Lombardia, eppure possiede una flotta mercantile tra le più moderne al mondo: 1.600 navi (dati 2020). E’ sufficiente questo dato per comprendere quanto sia necessario ed importante essere MARINAI in quella lunga porzione di bagnasciuga chiuso alle spalle da monti innevati fino al Polo Nord, e quanto sia probabile che in un simile contesto ambientale nascano persone eccezionali come:
THOR HEYERDHAL

Monumento dedicato a Thor Heyerdhal dal comune di Güímar - (Tenerife-Spagna)
(Larvik 1914 - Colla Micheri, Savona, 2002)
THOR HEYERDHAL - Etnologo, antropologo, esploratore, regista, scrittore e soprattutto navigatore norvegese noto soprattutto per aver dimostrato la possibilità di collegamenti tra alcune antiche popolazioni. Nel 1947 attraversò con una zattera chiamata Kon-Tiki il Pacifico tra Perù e Polinesia e nel 1970, usando un'imbarcazione di papiro simile a quelle costruite dagli antichi Egizî, coprì la distanza tra il Marocco e l’isola Barbados, dimostrando in questo caso la possibilità di un'influenza culturale della civiltà egiziana su quella precolombiana; nel 1978 costruì, con la stessa tecnica, un'imbarcazione, il Tigris, per confutare le teorie secondo le quali i Sumeri non si sarebbero potuti spingere oltre la foce dei fiumi Tigri ed Eufrate a causa della natura delle loro navi. A partire dal 1982 T.H. si dedicò a una serie di scavi archeologici alle isole Maldive, documentando, attraverso la scoperta di alcuni templi, l'esistenza di una civiltà in epoca preislamica. Nel 1992 si rese protagonista, a Tenerife, della scoperta di alcune piramidi. Descrisse i suoi viaggi in alcuni apprezzati documentari: Kon-Tiki expedisjonen (1949), che nel 1951 gli valse il premio Oscar; Galapagos (1953); Aku-Aku (1957); The Ra expeditions (1971); The Maldive mystery (1986).

LARVIK

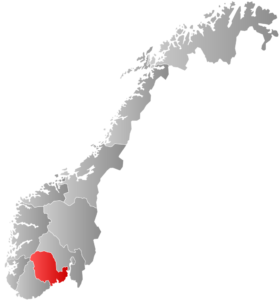
Comune di LARVIK

Larvik (Sud Norvegia)
T.H. nasce a Larvik – Norvegia il 6 ottobre 1914,
Muore: il 18 aprile 2002 a Colla Micheri – frazione del comune di Andora, in provincia di Savona, Liguria (Italia).
LA FAMIGLIA:
Thor Heyerdahl, esploratore, antropologo, geografo, zoologo e scrittore, ebbe una famiglia che partecipò intensamente alla sua vita e lo seguì nelle sue scelte. La madre Alison, che era a capo dell’Associazione del Museo di Larvik, ispirò nel figlio un grande interesse per gli animali e per le scienze naturali. Il padre Thor, mastro birraio, ospitò nei vecchi locali della birreria, il primo museo zoologico del figlio. Thor Heyerdahl si sposò tre volte: la prima nel 1936 con liv Coucheron-Torp (1916-1969) con la quale ebbe due figli: Thor junior e Bjørn. Dopo il divorzio da Liv, nel 1949 sposò Yvonne Dedekam-Simonsen (1924-2006) da cui ebbe tre figlie: Anette, Marian e Helene Elisabeth. Divorziarono nel 1969 e anni più tardi, nel 1991, Heyerdahl sposò Jaqueline Beer (1932) con cui visse a Tenerife, Canarie e con cui condivise vari progetti archeologici, specie a Tucumé, Perù e ad Azov, sino alla sua morte avvenuta nel 2002, a Colla Micheri.

Coniuge: Jacqueline Beer (s. 1991–2002),
Luogo di sepoltura: Heyerdahl Family Estate, Colla Micheri
Figli: Bjorn Heyerdahl, Marian Heyerdahl, Annette Heyerdahl, Thor Heyerdahl, Jr., Helene Elisabeth Heyerdahl, Thor Heyerdahl
Suo padre Thor, possedeva una birreria; la madre, Alison, era direttrice di un museo di Larvik. Fu lei ad ispirare nel figlio un grande interesse per le scienze naturali. Thor era bravo a disegnare, e già all’età di otto anni disegnava fantasiosi paesaggi delle isole dei mari del sud decidendo già allora di diventare un esploratore.
Biologo, specializzato all’Università di Oslo in antropologia delle Isole del Pacifico, divenne in realtà famoso per la sua attività da archeologo non esitando ad organizzare ardite navigazioni con natanti rudimentali per dimostrare la possibilità di viaggi transoceanici in epoca antica.
I suoi progetti di viaggi via mare si basavano su teorie e documentazioni storiche ed erano progettati con l'aiuto di maestranze del posto abili in lavorazioni antiche e originale. I dubbi della Comunità Scientifica dell'epoca si riferivano generalmente all'uso di materiali poco noti e ritenuti inaffidabili quali legno di balsa, papiro e giunco.
Fu anche autore di documentari sulle sue spedizioni. Kon Tiki ricevette l’Oscar al miglior documentario nel 1952, mentre Ra (The RA Expeditions) fu candidato allo stesso premio nel 1972.
KON-TIKI
fu la prima grande impresa oceanica
“Kon-Tiki” vuol dire letteralmente “Dio Sole”. Kon-Tiki è il nome della zattera costruita nella primavera del 1947 dall'esploratore norvegese.
Il libro Kon-Tiki (Kon-Tiki ekspedisjonen, 1948) è stato tradotto in oltre 70 lingue e ha venduto decine di milioni di copie – cosa che lo rende uno dei libri di autori norvegesi più venduti di sempre. Thor Heyerdahl realizzò anche dei film su molte delle sue spedizioni.

Il Kon-Tiki su cui Thor Heyerdahl raggiunse l'atollo di Raroia partendo da Callao, Perù
IL KON-TIKI (1947)
Sul Kon-Tiki, zattera di legno di balsa di ispirazione INCA l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl salpò a vela dal Perù approdando in Polinesia: è stata la prima grande impresa mediatica atta a dimostrare che la colonizzazione della Polinesia poteva essere avvenuta, in epoca precolombiana, da parte dei popoli sudamericani.
Leggiamo e riportiamo da Nautica Report una dettagliata descrizione della zattera KON-TIKI
Il corpo principale, e primaria parte galleggiante della zattera, fu costituita da nove tronchi di balsa accostati tra loro, lunghi fino a 14 metri e 60 cm di diametro. I tronchi erano accostati e fissati ai sovrastanti traversi, costituiti sempre in tronchi di balsa lunghi 5,5 m, e di 30 cm di diametro, spaziati tra loro di circa un metro. I tronchi longitudinali ed i traversi erano legati tra loro da robuste funi di canapa di 3 cm di diametro. Tra i tronchi longitudinali lunghe pale di legno di pino svolgevano la funzione di derive. L’albero in legno, in fusti di Mangrovia, era composto da più fusti uniti a costituire una forma ad “A” di circa 8,8 m di altezza, a poppa dell’albero fu costruita una “cabina” in bambù intrecciato, lunga 4,2 m e larga 2,4 m coperta da un tetto di foglie di banano.
A poppa un lungo remo (circa 5,8 m), in legno di mangrovia, collocato tra pioli e brandeggiabile, con alla estremità una “lama” di legno di abete funzionava da timone. La grande vela (4,6 x 5,5m) era fissata ad un boma costituito da un fascio di steli di bambù legati tra loro. Le immagini fotografiche rappresentano anche una piccola vela superiore alla grande, ed inoltre una terza a poppa. La zattera era coperta in parte, come piano di calpestio, da una sorta di stuoia di fusti di legno intrecciati con bambù.
Il Kon-Tiki aveva una riserva di 250 litri di acqua in “tubi” ricavati in canne di bambù. Come cibo aveva circa 200 noci di cocco, patate dolci, e vari altri tipi di frutti. L’esercito americano fornì razioni da campo, scatolame e porzioni di sopravvivenza. In cambio l’equipaggio del Kon-Tiki era impegnato a testare la qualità delle provviste e fare un rapporto sulla dieta praticata. In realtà l’equipaggio confidò sulle possibilità di pesca, e sulla possibilità di raccolta dell’acqua piovana, tale fiducia, fortunatamente, ebbe positivi riscontri, sia per la pesca che per ricorrenti temporali.
La spedizione con emittenti radio amatoriali, con sigla LI2B, mantenne la comunicazione regolare con corrispondenti americani, canadesi, e sud americani i quali tennero la Ambasciata norvegese a Washington informata sugli sviluppi della spedizione. Il successo di tali contatti fu dovuta alla esperienza maturata nella Seconda guerra mondiale come operatori di radio clandestine. Knut Haugland, LA3KY, e Torstein Raaby, il 5 di Agosto riuscirono a collegarsi con Oslo, in Norvegia, su una distanza di circa 10’000 miglia. La spedizione era dotata di tre apparecchi radio trasmittenti a tenuta d’acqua. Il primo operava su una lunghezza d’onda di 40 metri, un secondo di 20 metri ed il terzo di 6 metri. Le radio, con la tecnologia allora in uso, erano apparecchi voluminosi e con tecnologia a valvole termoioniche 2E30, con una uscita in radiofrequenza di 10 Watt.
Come trasmettitore di emergenza usarono anche un trasmettitore tedesco Mark V del 1942. L’energia per la trasmissione era erogata da batterie e da un generatore azionato a manovella. La radio ricevente del Kon Tiki fu una National Radio Company NC-173. L’equipaggio trasmetteva inoltre a mezzo la radio amatoriale LI2B, con la corrente del generatore azionato a manovella, il messaggio ripetuto “all well” (tutto bene) in modo da evitare inopportune attivazioni dei soccorsi in caso di altre interruzioni dei collegamenti radio. Il Kon-Tiki lasciò Callao, Peru, il pomeriggio del 28 aprile 1947. La zattera fu inizialmente trainata in mare aperto a circa 50 miglia dalla costa dal rimorchiatore Guardian Rios della Marina Militare peruviana; lo scopo fu quello di far raccogliere la zattera dalla Corrente di Humboldt, che nelle intenzioni della spedizione sarebbe stato il motore primario del movimento della zattera nel Pacifico. La prima terra avvistata fu l’atollo di Puka-Puka il 30 luglio, si ebbe un breve contatto con pescatori dell’isola di Angatau il 4 agosto, ma le condizioni di mare e delle coste non permisero di approdare. Il 7 agosto la zattera fu scagliata dal mare sulle scogliere coralline di un isolotto disabitato dell’atollo di Raroia, nell’arcipelago delle Tuamotu, subendo notevoli danni. La zattera aveva percorso una distanza di circa 3’770 miglia nautiche (circa 4300 effettivamente navigate) in 101 giorni, con una velocità media di circa 1,8 nodi. Dopo aver passato diversi giorni in solitudine sull’isolotto l’equipaggio fu raggiunto da abitanti delle isole vicine, dopo che pescatori indigeni avevano avvistati i rottami della zattera incastrati nella scogliera. L’equipaggio fu trasferito al villaggio dove ne fu festeggiato l’arrivo con canti e danze tradizionali. Infine fu trasportato a Tahiti dallo schooner francese “Tamara”, con il relitto della zattera e tutto quanto si riuscì a recuperare.
Le altre Campagne e spedizioni
Polinesia (1937-1938)
Qui sentì da un vecchio indigeno le leggende che ispireranno il viaggio del KON-TIKI. Incontrò un altro norvegese, Henry Lie, residente a Fatu Hiva da trent'anni, che gli mostrò delle statue di pietra simili ad altre trovate in Columbia. Scopo originale della spedizione era capire come gli animali avessero potuto raggiungere un'isola precedentemente deserta. Il periodo trascorso sull'isola di Fatu Hiva venne poi narrato nel suo primo libro Paa Jakt efter Paradiset (1938), che fu pubblicato in Norvegia ma, per l'incombere della seconda guerra mondiale, non fu mai tradotto. Molti anni dopo, a seguito della fama raggiunta con i suoi libri e documentari, Heyerdahl pubblicò una rielaborazione di questo libro sotto il titolo di Fatu Hiva (1974), incorporandovi la sua vena salutista.
Columbia britannica
Nel 1939 partì in cerca di una rotta dall'Asia alla Polinesia; la spedizione era finalizzata alla ricerca di contatti tra civiltà asiatiche, polinesiane e pre-colombiane. Elaborò una prima ipotesi di origine "nordamericana" delle popolazioni polinesiane.
Perù e Polinesia (1947)
Il Kon-Tiki su cui Thor Heyerdahl raggiunse l'atollo di Raroia partendo da Callao, Perù.
Il 28 aprile 1947 Heyerdahl salpò da Callao con un'imbarcazione di legno di balsa d'ispirazione incaica, il Kon-Tiki, trasportato dalla Corrente di Humboldt. Il 30 luglio l'equipaggio avvistò l'isola di Puka Puka, nell'arcipelago delle Tuamatu, e dopo un'altra settimana riuscì ad approdare sull'atollo di Raroia. Questa spedizione dimostrò la possibilità tecnica per le popolazioni sudamericane di raggiungere e colonizzare la Polinesia, anche se tale ipotesi non ha trovato pieno riscontro in verifiche effettuate con mezzi moderni, quali le analisi genetiche, che hanno però dimostrato il flusso inverso, tecnicamente analogo dal punto di vista della navigazione.
Galápagos (1952)
I detrattori della sua teoria sostenevano che prima di raggiungere la Polinesia, le popolazioni sudamericane avrebbero dovuto raggiungere le Galapagos, più vicine ma disabitate. Nessun archeologo aveva mai studiato quelle isole, considerate disabitate. Con questa spedizione Heyerdahl dimostrò che queste isole erano state punto di approdo di navigatori provenienti dalle Americhe in epoca precolombiana. Individuò l'isola come possibile attracco delle zattere pre-incaiche preistoriche, ritrovamento di abitazioni precolombiane con resti di centinaia di vasi in ceramica pre-incaici dell’Ecuador e del Perù settentrionale. Le isole avrebbero potuto essere uno scalo migratorio dal Sud America verso la Polinesia.
Isola di Pasqua (1955)
Stabilitosi a Rapa Nui per un anno, Heyerdahl analizzò scientificamente le possibili tecniche di costruzione e trasporto dei MOAI. Dimostrò che molti di essi erano sepolti dentro la collina e più grandi del previsto, e che in origine recavano sul capo una sorta di copricapo in pietra rossa.
Aiutato da archeologi professionisti, effettuò un'analisi stratigrafica sulla colonizzazione dell'isola, risalente almeno al 380. Tramite l'analisi dei pollini nelle stratificazioni in un lago paludoso, dimostrò definitivamente che alcuni secoli prima dell'arrivo degli Europei, l'isola era coperta da una fitta vegetazione arborea.
Vennero confutate, con un efficace esperimento pratico, le teorie legate all'impossibilità per un popolo primitivo di scolpire ed erigere statue di quelle dimensioni e quel materiale senza una tecnologia avanzata. Durante l'esperimento, con una speciale tecnica e strumenti rudimentali, sei uomini riuscirono in soli tre giorni a scolpire interamente una statua di dodici tonnellate in tufo vulcanico e trasportarla utilizzando 180 uomini, muniti di funi e di un'enorme slitta di legno. Un'altra statua pesante trenta tonnellate, rimasta a terra per secoli, venne issata su un'alta piattaforma di muratura, mediante un apposito basamento di pietre.
Ra
Nel 1969 partì dalla città fenicia di Safi (Marocco Atlantico), con un'imbarcazione costruita da maestranze del lago Ciad. Il progetto si basava su documentazioni di tipiche antiche imbarcazioni egizie in PAPIRO, eccessive per navigare solo sul Nilo. Dopo 56 giorni, naufragò a circa una settimana di navigazione dalla meta. Del ridotto equipaggio, anche per la successiva traversata della RA II, fece parte l'esploratore documentarista e alpinista italiano Carlo Mauri.
Ra II
Nel 1970, sempre dal Nord Africa, partì con un'imbarcazione costruita da amerindi Aymara del lago Titicaca, percorse in 57 giorni 3 270 miglia, raggiungendo l'isola di Barbados. Con questa impresa dimostrò la fattibilità tecnica, già nell'antichità, di viaggi dal vecchio verso il nuovo mondo, suggerendo che la somiglianza culturale tra i popoli precolombiani e le popolazioni assiro-babilonesi, potrebbe non essere dovuta al caso.
Iraq (1977)
Con una nave di giunchi percorre 6800 km, discendendo il fiume Tigri fino al Golfo Persico, poi nell’ Oceano Indiano fino alla valle dell’Indo in Pakistan e verso ovest fino al Bab el-Mandeb, l'imboccatura del Mar Rosso. Con questa impresa, dimostrò la possibilità di scambi culturali e commerciali in epoche molto antiche a opera dei popoli mesopotamici, anche se la tecnica di costruzione della sua imbarcazione era mutuata da indigeni del Lago Titicaca, in Sudamerica, e non dalle antiche tecniche sumeriche.
Maldive
Dal 1981 al 1984 fu alle Maldive: durante questa spedizione archeologica scoprì reperti che dimostrano come le isole, già 2000 anni prima di Cristo, fossero punto di passaggio per navigatori provenienti dalla terraferma e diretti in India.
Nuovi scavi sull'Isola di Pasqua
Tornò sull'Isola di Pasqua dal 1986 al 1987: compì nuovi esperimenti che dimostrarono ulteriormente la facilità di trasporto delle statue da parte di una squadra di soli 15 uomini.
Esplorazioni successive
Studiò le piramidi di Tùcumé (Perù) nel 1988; dal 1992 al 1995 eseguì scavi nelle isole Canarie; s'interessò alle Piramidi Güimar, dimostrando che non sono ammassi casuali di pietre, ma opera dell'uomo.
Eseguì scavi ad Azov, in Russia, nel 2002, alla ricerca delle origini dei popoli vichinghi, ossia la mitica terra dell’Asaheimir: gli scavi furono però interrotti dal peggioramento della sua salute.
ALCUNI DEI TANTI PREMI E RICONOSCIMENTI …
Nel 1950 ricevette la "Retzius Medal" dalla Royal Swedish Society for Antropology and Geography”. Nel 1952 venne premiato con l’Oscar al miglior documentario per il resoconto sul viaggio della zattera Kon-Tiki.
Nel 1960 viene eletto quale membro della Norwegian Academy of Sciences, nel 1962 fu insignito della "Lomonosov Medal" dall'università di Mosca, della Gold Medal Royal geographical di Londra, della Medaglia Norvegese St. Hallvardsmedaljen e del Bradford Washburn Award dal museo della Scienza di Boston.
Fu di nuovo candidato nel 1972 all'Oscar per la categoria Documentari, ricevette dottorati Honoris causa dall'Università di Lima e da quella di Cuba.
Oltre a questo a Heyerdhal è stato intitolato un asteroide che ruota fra i pianeti Marte e Giove: 2473 Heyerdahl è un piccolo asteroide della fascia principale, scoperto da Nikolaj Stepanovich Cernich nel 1977.
Il 18 gennaio 2011 la Marina Norvegese ha immesso in servizio la fregata F314 THOR HEYERDAHL (classe Nansen), rendendo omaggio al nome di uno dei più illustri esploratori norvegesi
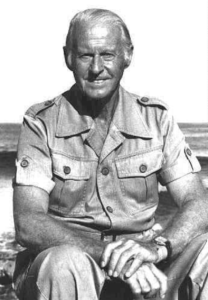

ALCUNE FRASI CELEBRI DI THOR HEYERDHAL:
"Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone."
“Il ricordo più forte che ho nella memoria del viaggio sul Kon-Tiki è l'oceano completamente libero per i 101 giorni di navigazione; non vedevo nessun'altra imbarcazione né alcun segno dell'uomo. Come viaggiare su un tappeto magico nell'universo. Nessun Oceano può isolare un uomo con un certo livello di cultura”.
“Il progresso è la capacità dell’uomo di complicare la semplicità”.
“Nella mia esperienza, è più raro trovare una persona davvero felice in una cerchia di milionari che tra i vagabondi”.
QUANDO L’ESPLORATORE THOR HEYERDHAL APPRODO’
A COLLA MICHERI
Ormai quasi disabitato, Colla Micheri diventò famoso negli anni ’50 perché Thor Heyerdhal decise di stabilirvisi, acquistò una casa in questa piccola frazione di Andora nella Riviera Ligure, dove morì il 18 aprile 2002.
Colla Micheri è un antico borgo di origine medievale situato nella Liguria di ponente, più precisamente nel comune di Andora, in provincia di Savona. Adagiato sul valico di un colle a 162 metri d’altezza, proprio alle spalle di Laigueglia, questo paesino di soli 32 abitanti sembra volersi slegare dal concetto di tempo. Passeggiando per le antiche strade lastricate l’atmosfera che si respira è davvero singolare. Ma la vera storia di Colla Micheri iniziò negli anni ’50 del Novecento, quando l’esploratore e antropologo norvegese Thor Heyerdahl, dopo aver girato il mondo, si innamorò di questo borgo tranquillo e pittoresco e decise di stabilirvisi. Colla Micheri all’epoca stava vivendo un destino comune a molti borghi liguri e dell’Italia in generale, quello dello spopolamento e dell’abbandono. Thor Heyerdahl si occupò personalmente del recupero dell’antico paesino, ricostruendo e restaurando edifici, pulendo boschi e terrazzamenti. Acquistò una casa con un parco, oggi chiamato il Parco degli eredi di Thor. L’esploratore, artefice della rinascita di Colla Micheri, visse qui con la famiglia, quando non era in viaggio, fino alla sua morte.
Si racconta che lo studioso norvegese fosse in cerca di un “paradiso in terra” dove trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Il tassista che lo conduceva nelle località italiane (lui non guidava la macchina) gli disse che non sarebbero dovuti andare tanto lontano, e lo portò proprio a Colla Micheri.
Il paesaggio che si mostra alla vista nelle giornate serene è, infatti, davvero unico: da una parte si assiste allo spettacolo del mare, da cui emergono le coste della Corsica, dall’altro i monti innevati delle Alpi. Il suo pensiero ecologista e il suo amore sconfinato per la natura, lo portavano a preoccuparsi dei numerosi incendi che affliggevano la Liguria.

Il borgo di Colla Micheri e Thor Heyerdahl. “Un paradiso in terra”: così Thor Heyerdahl definì Colla Micheri. Se dopo aver girato il mondo e affrontato il Pacifico sulla zattera “Kon Tiki”, l’esploratore norvegese decise di trasferirsi in questo piccolo borgo ligure, un motivo ci sarà stato: l’assomiglianza con la sua terra natìa e forse anche il carattere duro e schivo dei norvegesi e dei liguri.

Colla Micheri è una frazione di Andora ma si raggiunge facilmente con una passeggiata da Laigueglia, tra ulivi e pini marittimi. Da via Monaco si prende una strada in salita finché non si raggiunge una mulattiera che conduce verso la cima della collina. Presto si incontrano delle indicazioni: proseguendo a sinistra si raggiunge Colla Micheri. La particolarità di questo borgo è che le case sono state costruite sul versante posteriore della collina, in modo da evitare le incursioni sulla costa, non potendo essere avvistate dai saraceni che sbarcavano a Laigueglia.
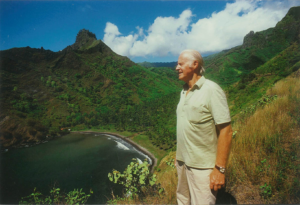
Un luogo che per la sua immensa bellezza e la sua tranquillità conquistò anche il famoso esploratore e antropologo di fama mondiale Thor Heyerdahl, che qui trascorreva i momenti di riposo, la sua dimora tra un’avventura e l’altra.

Colla Micheri. Piccola perla medievale incastonata sulle alture tra Laigueglia e Andora, nel territorio del comune di Andora, lungo il tracciato dell’antica via Romana Julia Augusta, Colla Micheri fu scelta come dimora dal celebre antropologo, navigatore ed esploratore norvegese Thor Heyerdahl.

Colla Micheri è un luogo incantato capace di portarci in pochi istanti in un mondo magico e lontano fatto di meraviglia e suggestioni. Per una totale immersione nella bellezza, di cui tutti abbiamo sempre bisogno.

Una scelta che si rivelò particolarmente felice, anche da un punto di vista più “poetico”, perché all’ora del tramonto a Colla Micheri si può godere di uno splendido spettacolo: il sole che va a tuffarsi in un “mare” di ulivi dietro le colline.
Per aver ospitato il loro connazionale Thor Heyerdahl, Laigueglia è una città particolarmente cara ai norvegesi. Questo celebre e affascinante personaggio viene ricordato sempre con grande affetto dagli abitanti di Laigueglia.
Per suo volere, alla sua morte fu sepolto a Colla Micheri e la sua tomba si trova sotto la Torre saracena, che si erge in posizione dominante.

La tomba di Thor Heyerdahl a Colla Micheri
Il 18 ottobre 2002 muore a Colla Micheri, in Liguria tra Andora e Laigueglia, a 88 anni, l'esploratore norvegese Thor Heyerdhal. La Norvegia gli tributò funerali di Stato.
Di fronte alla chiesa parte un sentiero che in pochi minuti conduce alla tomba di Thor Heyerdahl. Lungo il tracciato s’incontra un piccolo cancello in legno: aprendolo si scopre una rudimentale costruzione in pietra a secco addossata a un terrazzamento. Si tratta della tomba di Thor Heyerdahl, riconoscibile anche dalla targa in ceramica blu che commemora la più grande e celebre impresa dell’esploratore norvegese, ovvero i 101 giorni di navigazione dal Sud America alla Polinesia a bordo della zattera Kon-Tiki in semplice legno di balsa.
UN PO’ DI STORIA …
IL BACK GROUND …
Con la dichiarazione di guerra, Thor Heyerdahl si unì alle libere forze norvegesi nel 1941: la resistenza. Ingaggiato dai paracadutisti e dall'intelligence, si offrì volontario per essere paracadutato in Norvegia per azioni di sabotaggio. È lì che incontrerà alcuni dei cinque accoliti che lo accompagneranno sul Kon-Tiki per realizzare un transpacifico nel 1947.
Gli Amici di THOR HEYERDHAL
GLI EROI DI TELEMARK
Joachim Rønneberg-Torstein Pettersen Raaby–Knut Augland-Arne Kjelstrup
Jens-Anton Poulsson e Claus Helberg.
Berlino. Kirk Douglas impersonò Joachim Rønneberg nel celebre film di guerra Gli eroi di Telemark con anche Richard Harris, storici ed esperti militari di tutto il mondo lo consultarono per decenni per imparare da lui. Ora è morto, lui Joachim Rønneberg, comandante partigiano norvegese addestrato dai britannici, lui massimo eroe della Resistenza nordica contro l'occupazione nazista. Si è spento sereno a 99 anni, lui che nel 1943 con commando di partigiani riuscì ad attaccare e distruggere a Telemark, appunto nella Norvegia occupata, l'impianto supersegreto in cui il Terzo Reich produceva l'acqua pesante, componente indispensabile alla bomba nucleare.
Cinque dei sei uomini della spedizione del Kon-Tiki erano scout.
Dopo la guerra Knut Haugland continuò la carriera militare per molti anni, tranne nel 1947 quando prese parte alla spedizione del KON-TIKI. Partecipò alla Brigata Indipendente Norvegese in Germania dal 1948 al 1949, proseguendo poi nel Forsvarsstaben fino al 1952 quando fu trasferito al Kongelkige Norske Luftforsvaret (Aviazione militare Norvegese). Guidò il servizio di intelligence elettronico in Nel Nord della, Norvegia incarico importante durante la “guerra fredda”. Divenne maggiore nel 1954 e tenente colonnello nel 1977.
Abbandonò l'aeronautica nel 1963 per diventare direttore del Museo norvegese della Resistenza. Diede le dimissioni nel 1983. Fu anche direttore del KON-TIKI Museet dalla sua fondazione nel 1947 fino al 1990. Terminò la carriera come presidente del consiglio del Kon-Tiki Museet nel 1991.
THOR HEYERDAHL E IL KON-TIKI





3700 miglia stimate
Il tuo tiki è il nome del dio del sole Inca. Heyerdahl e il suo equipaggio (6 uomini e un pappagallo) sono partiti per una "piccola" escursione di 3700 miglia attraverso il Pacifico! Hanno navigato con grande stima, dirigendo la loro zattera con l'aspetto dei remi. Anche se generosamente rifornito di provviste americane, cucinavano ogni mattina il pesce volante che cadeva sulla loro nave senza bordo libero durante ogni notte!
L'ecosistema che è apparso sotto le loro conchiglie, composto da alghe e crostacei, ha attirato tutta una serie di fauna ittica, dai delfini ai tonni e squali balena lunghi 10 metri che hanno quasi affondato il loro fragile skiff!

Arrivo in Polinesia Francese
Dopo 101 giorni di navigazione, trasportati dalla corrente Humboldt, il Kon-Tiki fece un violento approdo: colpendo una barriera corallina a Raroia, un atollo paradisiaco a Tuamotu (Polinesia francese) il 7 agosto 1947. Sono atterrati tutti illesi, tranne il loro pappagallo, rapito da una lama infida, una notte in caso di maltempo.


Cittadino del Mondo
“Tutti gli esseri umani sono uguali. Affrontiamo tutti le stesse sfide pratiche”.
Questa era una delle idee fondamentali di Thor Heyerdahl a proposito della vita umana. Credeva anche che la gente potesse lavorare e vivere insieme a prescindere dalle differenze etniche, politiche e religiose.
È stato soprattutto tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘90 che Heyerdahl è stato coinvolto nel lavoro per la pace globale. Ha fatto appello alle più alte autorità e ai politici più potenti in diversi stati, tra gli altri Andrej Gromyko e John F. Kennedy.
Heyerdahl fece sentire i propri valori nel Movimento federalista mondiale (World Federalist Movement) e ne divenne rapidamente un membro molto attivo. Il Movimento federalista mondiale è un’organizzazione che lavora per la pace, per la cooperazione oltre le frontiere e per un mondo costruito sulle leggi e sul diritto internazionale. Heyerdahl divenne vice-presidente onorario dell’organizzazione.
Heyerdahl si impegnò anche nel lavoro dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges). L’organizzazione gestisce diverse scuole superiori in tutto il mondo, dove giovani provenienti da diversi paesi possono vivere e studiare. L’organizzazione è stata fondata durante la guerra fredda e l’idea è che tali scuole siano in grado di stimolare i giovani provenienti da diversi contesti culturali ad imparare gli uni dagli altri.
Attraverso le spedizioni di Ra, Ra II e Tigris, dove gli equipaggi erano composti da persone provenienti da diverse nazioni e parti del mondo, Heyerdahl aveva cercato di dimostrare che si può lavorare bene insieme nonostante le differenze culturali. Con questo, aveva anche voluto dimostrare la propria ipotesi che l’oceano fosse stato un’arteria di traffico che aveva portato al contatto tra culture diverse, anche in epoca preistorica.
Quando Heyerdahl nel 1978 viaggiò con l’imbarcazione di giunco Tigris dall’Iraq a Djibouti, voleva navigare nel Mar Rosso, ma rinunciò a causa delle guerre nella regione. Decise di bruciare il Tigris. Allo stesso tempo, inviò una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim, in cui protestava contro la guerra e contro il modo in cui gli stati occidentali vendevano armi ai paesi in via di sviluppo. L’intero equipaggio firmò la lettera.
«Il nostro pianeta è più grande dei fasci di giunchi che ci hanno portato attraverso i mari, eppure abbastanza piccolo per correre gli stessi rischi, a meno che quelli di noi che sono ancora vivi aprano gli occhi al disperato bisogno di una collaborazione intelligente se vogliamo salvare noi stessi e la nostra comune civiltà da quella che stiamo trasformando in una nave che affonda.»
THOR HEYERDHAL - Ambientalista
Durante il viaggio di Ra, Heyerdahl scoprì che l’Atlantico era stato contaminato. L’equipaggio trovò grandi e piccole macchie d’olio sulla superficie dell’oceano, e la scoperta fu resa nota all’ONU (Nazioni Unite). Durante il viaggio di Ra II, il Segretario generale delle Nazioni Unite chiese a Heyerdahl di fare osservazioni giornaliere riguardo all’inquinamento del mare. In 43 dei 57 giorni di viaggio furono avvistati grumi solidi di olio.
L’equipaggio inviò una petizione al Segretario generale dell’ONU U Thant e l’inquinamento da idrocarburi negli oceani ottenne molta attenzione, soprattutto dai media americani. Thor Heyerdahl fu convocato per un’udienza al Congresso degli Stati Uniti. Lavorò anche per il Dipartimento di Stato come uno dei rappresentanti della Norvegia nelle riunioni preparatorie per la prima Conferenza sull’ambiente dell’ONU, svoltasi a Stoccolma nel 1972.
La Conferenza, tra le altre cose, istituì il divieto di scarico di oli usati in mare, una diretta conseguenza della petizione che l’equipaggio internazionale aveva mandato dalla barca di giunco Ra mentre affondava.

Disegno di Thor Heyerdahl, 1946
ARTISTA
È sconosciuto ai più il lato artistico di Thor Heyerdahl. I suoi interessi principali erano la preistoria, l’antropologia e l’archeologia – e questo si riflette nei libri, nei film e nei disegni che ha realizzato.
Come tutti i bambini, Thor Heyerdahl disegnava e dipingeva molto. I racconti dei primi giri di Heyerdahl nei boschi e sulle montagne sono stati pubblicati in giornali e riviste, spesso accompagnati dai suoi disegni umoristici. Durante il viaggio nell’Oceano Pacifico, intrapreso con la moglie Liv tra il 1937 e il 1938, realizzò una serie di disegni caricaturali basati sulle esperienze da loro vissute. Successivamente, fino al momento della spedizione Kon-Tiki, i suoi disegni si fecero più pregni di critica sociale, con riguardo a come guardiamo alle altre razze, alla fede cieca nel processo e alla politica di distribuzione del mondo. Inseriva spesso anche commenti o didascalie nei suoi disegni.
Intagliare il legno era un altro interesse che Thor Heyerdahl coltivò per tutta la vita. Già nella prima adolescenza si era dimostrato portato per questo mestiere. Si è conservato un meraviglioso piccolo tableau raffigurante un’isola tropicale, intagliata sul coperchio di una cassa che Heyerdahl realizzò da adolescente.
In vecchiaia, Heyerdahl intagliò due teste di Kon-Tiki nell’imponente portone d’ingresso di Casa Kon-Tiki, la casa di Heyerdahl a Túcume, in Perù.

Thor Heyerdahl passò la maggior parte della sua vita dietro ad una scrivania, a casa a scrivere, o in biblioteche in giro per il mondo per apprendere nuove conoscenze. Nel corso della sua vita pubblicò una serie di libri e oltre cinquanta articoli scientifici.
Heyerdahl non aveva forse sempre ragione, ma l’essenza della scienza sta nel porsi domande, e le domande che si poneva Thor Heyerdahl sono ancora oggi di interesse accademico.
La maggior parte delle persone ricorda Thor Heyerdahl come un grande divulgatore. Il suo talento naturale consisteva nell’essere in grado di coinvolgere le persone in una conversazione su un dato fenomeno. Egli voleva sempre trasmettere la propria esperienza e diventò un maestro nel farlo attraverso i suoi libri ben scritti, i film, le fotografie e le presentazioni.
HEYERDAHL - DIVULGATORE
Thor Heyerdahl viene ricordato dalla maggior parte delle persone come un grande divulgatore. Il suo talento naturale consisteva nell’essere in grado di coinvolgere i suoi interlocutori in una conversazione su un dato fenomeno. Egli voleva trasmettere la sua esperienza e diventò un maestro nel farlo attraverso i suoi libri, i film, le fotografie e le presentazioni.
Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’90 Heyerdahl si è dedicato alle attività internazionali relative alla pace globale, facendo appello alle più alte autorità e ai politici più potenti del mondo, tra cui Andrej Gromyko e John F. Kennedy. Heyerdahl è stato membro di alcune delle più prestigiose istituzioni mondiali e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.
Per le connessioni di Thor Heyerdhal con la guerra partigiana norvegese nella Seconda guerra mondiale (fece parte del SOA-Servizi Segreti Norvegesi) e per l’amicizia stabilita con alcuni dei protagonisti dell’atto di eroismo: distruzione dell’Impianto di ACQUA PESANTE a Rjuka, propongo il LINK di un mio articolo in cui riporto i nomi e le valorose azioni militari di chi seguì Heyerdhdal sul KON-TIKI.
GLI EROI DI TELEMARK – NORVEGIA, la vera storia
di Carlo GATTI - 13.10.2011
https://www.marenostrumrapallo.it/eroi/
Carlo GATTI
Rapallo, 2 Maggio 2023
LE FESTE DI LUGLIO A RAPALLO - La tradizione dei fuochi
LE FESTE DI LUGLIO A RAPALLO

AL SESTIERE CERISOLA TOCCHERA' L'ONERE E L'ONORE DI ORGANIZZARE E REALIZZARE IL PANEGIRICO 2023
La tradizione delle "sparate e dei fuochi d'artificio"
Fede, tradizione, folklore, spettacolo, un senso di appartenenza che rende l’evento davvero speciale, unico. Rapallo rinnova l’appuntamento con le Feste di Luglio, tre giorni di festeggiamenti, l’1, 2 e 3 luglio, in onore di N.S. di Montallegro nel 466° anniversario dell’Apparizione al contadino Giovanni Chichizola, il 2 luglio 1557.

La festa, pur nel radicale trasformarsi della città, il frenetico mutare dei tempi (e delle normative) conserva intatti elementi preziosi del folclore locale d’aspetti di una religiosità semplice, ma spontanea, radicati ad una antica e salda tradizione che non teme minimamente la critica di chi, trapiantato da fuori, stenta a comprendere alcune espressioni di esaltazione popolare caratterizzate anche da una certa fragorosità.
La nostra “sagra” nasce negli anni immediatamente successivi all’Apparizione e fin dalle prime edizioni essa ebbe nel fuoco, nelle luci fiammeggianti, nello schioppiettio dei falò, la sua principale caratteristica.
UN PASSO INDIETRO NELLA STORIA…..
Nella deliberazione assunta dalla Magnifica Comunità Rapallese il 26 agosto 1657 per ringraziare la Madonna di essere stata preservata dalla peste, si legge testualmente: “…di perpetuamente santificare, siccome da cent’anni in qua si è osservato, il giorno di detta Santissima Vergine…”
Un documento datato 9 agosto 1617 attesta che si pagano a “… Ger. Bontempo lire tre e soldi sei per pretio di due arbori venduti alla comunità uno in honore di Maria S.ma del Monte, l’altro per il falò solito di S. Giovanni Battista”; un altro del 31 ottobre 1625 registra invece l’acquisto di “60 fascetti, ch’ha comandato il signor Capitano si comprino pere far fochi in publica piazza ad honore di Nostra Signora”.
Le sparate non tardano ad apparire, come si deduce dalla lettura di un atto dell’11 ottobre 1619. In questo giorno il commissario Gio. Andrea Gentile ordina agli Agenti di Rapallo “…che non si potessero fare salve alcun se non per i giorni del Sabato Santo, del Corpus Domini, di S. Giovanni Battista e per le solennità di luglio, e le salve dovessero essere fatte con mascoli e non con altro…”
Nel registro della Masseria, alla data del 21 giugno 1635, si segnano lire diciannove “… per condurre sei mascoli a Nostra Signora per le solennità” e alla data del 7 luglio successivo altre 10,3 lire per spesa fatta di una sfera per le solennità di Nostra Signora”. Una deliberazione del primo luglio 1639 approva la spesa di lire 12 per “…polvere per sparare tanti mascoli ad honore di Nostra Signora conforme il solito”.
Alle spese partecipavano tutti i sestieri allora compresi nel Capitaneato di Rapallo: Borgo, Borzoli, Amandolesi, Pescino, Olivastro d’Oltremonte.
IL PANEGIRICO DI RAPALLO
Il Panegirico nella Storia significava: “Adunanza di tutto il popolo”
In origine, nell'antica Grecia, discorso a carattere encomiastico o suasorio che si pronunciava nelle adunanze festive del popolo; presso gli antichi Romani, discorso celebrativo in onore di un personaggio illustre. Il genere fu inaugurato nel VI secolo a.C. da Gorgia con i suoi scritti a Olimpia e a Delfi e conobbe la sua fioritura dal V secolo a.C. in poi. Il panegirico greco ha tratti comuni con l’encomio e l’epitaffio ma agli elogi può a volte unire critiche.
Con la letteratura latina, il panigirico assume solo il carattere di laudatio di uomini di potere ed in particolare degli imperatori. Nel linguaggio comune indica un discorso di encomio enfatico, talvolta esagerato.
In epoca moderna passa ad indicare un discorso in lode di un Santo o di un altro personaggio del culto cristiano:
Il PANEGIRICO DI RAPALLO
SI RIFERISCE
AL CULTO E AL SALUTO ALLA VERGINE DI MONTALLEGRO
Il 2 Luglio, anniversario dell'apparizione, a mezzogiorno il sestiere di turno organizza il cosiddetto "Panegirico". Sulla pedonale del lungomare Vittorio Veneto si posizionano un gran numero di mortaletti che giunti all'altezza del monumento a Cristoforo Colombo, nella zona del Lido verso la foce del torrente Boate, un gran fragore (a Rapallo è detto u ramadan) accompagna lo spettacolo finale.
Viene appunto acceso ai rintocchi delle dodici, ogni due luglio, con attenzione maniacale al rispetto del suo orario storico – tradizionale. Di norma, l’organizzazione spetta ciclicamente a tutti i Sestieri, secondo il turno dei Reciammi: di anno in anno, l’onere e l’onore organizzativo interessa San Michele, Seglio, Borzoli, Cerisola, Cappelletta, Costaguta e… così via, ricominciando da San Michele.
Un commerciante di Palermo, nel XVI secolo fece conoscere ai rapallesi i fuochi artificiali ed i mortaretti originari della Sicilia. Da quel momento nacque e si diffuse la tradizione delle “sparate”, in occasione delle feste patronali. Usanza che, nel nostro comprensorio, è tuttora vivissima.
Protagonista indiscusso è l’antico mortaletto ligure, un artificio metallico avente forma tronco-conica, cava al centro, alto circa 12- 1 5 cm e dal peso di circa 2 kg. Alla sua base è presente un piccolo foro detto “aggugin”. Anticamente realizzato in ghisa attualmente, per rispettare le vigenti norme, viene prodotto per tornitura o per fusione in ferro. Viene caricato con una piccola quantità di polvere nera e segatura, pressata manualmente mediante l’utilizzo di appositi pestelli d’alluminio o legno, chiamati in gergo “stie’. L’utilizzo di questi materiali, evita in fase di caricamento, eventuali accensioni accidentali.

La stesura della riga
Della medesima forma del mortaletto, ma di più grandi dimensioni, è il cannone, oggetto funzionalmente identico che può raggiungere un peso superiore a 200 chilogrammi.
La sparata dei mortaletti è composta schematicamente in due parti: " la riga e il ramadan”. La riga è una successione di mortaletti, collegati insieme da una striscia di polvere nera che con la sua combustione porta il fuoco negli aggugini con il conseguente innesco della polvere, realizzando una ritmica cadenza.

Il “ramadan” costituisce invece la parte finale della sparata. Nella sua forma classica prevede che i mortaletti siano disposti a triangolo allungato in cui le nuove righe esterne, i lati del triangolo, vengono progressivamente affiancate da nuove righe all’interno man mano che si procede verso la base ed il triangolo si allarga. Questo posizionamento, composto da una grande quantità di mortaletti messi l’uno vicino all’altro, bruciando genera un fragoroso crescendo che si conclude con lo sparo di uno o più cannoni.
Durante la sua accensione la sparata è seguita dal massaro che porta con sé un “buttun”. Questo è un bastone che ha alla sua estremità una palla di ferro rovente, fatta scaldare per alcune ore: lo scopo di questo attrezzo è quello di riaccendere la sparata in caso si spegnesse.
PER L’EDIZIONE 2023
L'ONERE
DI ONORARE
LA NOSTRA SIGNORA DI MONTALLEGRO
spetterà al Sestiere CERISOLA

Non dimentichiamoci il rito dell’“Andare a turno”, cioè raccogliere le offerte. È una delle ritualità più antiche legate alla festa e coinvolge tutti i volontari dai più giovani agli anziani che, a partire dal 23 maggio al 3 Luglio, si recano casa per casa con la “sacchetta” per chiedere un obolo per i fuochi.
PUBBLICHIAMO ALCUNE IMMAGINI DEL SITO FINALE DEL PANEGIRICO (RAMADAM) CHE MOSTRANO LA BELLEZZA CHE SA ESPRIMERE L’ARTE DI STRADA QUANDO PARTE DAL CUORE SEMPLICE DEL POPOLO LEGATO ALLE TRADIZIONI






MAURA ARATA E' LA STORICA PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SESTIERI RAPALLESI QUI SOTTO RAPPRESENTATI CON I LORO COLORI IDENTITARI


E IL GONFALONE CHE ACCOMUNA I SESTIERI

SESTIERE BORZOLI


SESTIERE CAPPELLETTA


SESTIERE CERISOLA


SESTIERE COSTAGUTA


SESTIERE SEGLIO


SESTIERE SAN MICHELE


Anno 2023
PANEGIRICO
E’ IL TURNO DEL SESTIERE CERISOLA
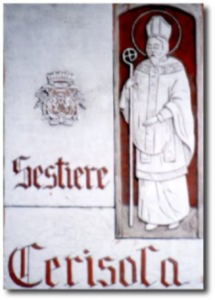
«…Il toponimo “Cerisola” compare per denominare due cappelle rurali site nel cuore dell’attuale Sestiere…
…Erano sicuramente zone destinate alla coltura dei ciliegi in un borgo dall’economia diversificata, ma basata essenzialmente sull’agricoltura.
Nel successivo evolversi della città, il nome “Cerisola” va a denominare uno dei Sestieri nati dalla divisione del più antico Quartiere Amandolesi (XII secolo N.D.R.)…» (tratto dal libro “In burgo Rapalli” di Antonella Ballardini da Maura Arata, massara del Sestiere Cerisola)
L’odierno Sestiere Cerisola comprende la parte centro occidentale del centro storico rapallese, con monumenti quali la Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio e gli Oratori detti Dei Bianchi e Dei Neri, quest’ultimo dominato dalla medioevale Torre Civica.
La zona rurale di Cerisola si sviluppa sulla ridente collina di San’Agostino, ove risiede l’omonima chiesetta, centro religioso del Sestiere; Sestiere che, tuttavia, ha come patrono tradizionale San Giuseppe.
Il giorno 2 Luglio IL SESTIERE CERISOLA saluterà
CON IL SUO PANEGIRICO
L'APPARIZIONE DELLA VERGINE MARIA
dalla Spiaggia dei Bagni Lido con i secenteschi mortaletti liguri
Da questo sito, che sempre rimane nel cuore e… nella progettualità dei suoi massari, il Sestiere tradizionalmente lancerà anche i suoi fuochi colorati, oggi preparati su chiatta galleggiante.
I fuochisti che hanno sparato per Cerisola negli ultimi anni sono: Albano & Russo di Melito (NA), Ferreccio di Avegno (GE) e La Rosa di Bagheria (PA) ed in epoca meno recente Perfetto di Sant’Antimo (NA).
Il Panegirico del Sestiere Cerisola sfilerà lungo la passeggiata a mare e terminerà col tradizionale e fragoroso Ramadan ai piedi della Statua di Cristoforo Colombo, presso i Bagni Lido e quindi entro i confini del Sestiere.
UN PO’ DI TECNICA ….
Origini dell’antico mortaletto ligure

L’antico mortaletto ligure, una sorta di cinquecentesco cannoncino ad avancarica, assurge ad attualissimo e vivo richiamo all’archeologia del fuoco a festa, rapallese e non solo.
Estinto nella gran parte del mondo, resiste infatti al tempo (almeno, per quanto ad oggi sappiamo) nella sola zona di Rapallo, Recco e comuni limitrofi. Lo si trova in antiche stampe francesi (che per ora non possiamo ritrarre per ragioni di copyright) ed in alcune tradizioni orali italiane, legate all’ambiente dei fuochi: “I mortaletti furono importati dalla Sicilia, si dice, da un certo Signor Pescia, commerciante di cereali che trasportava a mezzo di velieri da Palermo a Rapallo grano, avena, fave, vino, agrumi ecc… …Questo signore portò anche in Parrocchia il culto di S. Rosalia e S. Lucia che nel XVII secolo furono proclamate compatrone dell’attuale basilica…”
Questo è quanto troviamo negli appunti del nostro coordinatore Comm. Antonio Scazzola, scomparso in veneranda età nel 1994. Una tesi molto interessante, soprattutto alla luce di quanto si tramanda presso altre scuole di tecnica del fuoco, venute in contatto con la nostra soltanto in epoca recentissima. Ci riferiamo alla tradizione orale di alcune storiche aziende pirotecniche, protagoniste ieri ed oggi dei fuochi rapallesi moderni: tradizione la quale, pur non conferendo piena validità alla tesi di Scazzola, ne conferma comunque una forte verosimiglianza. Abbiamo appunto notizia, da fuochisti del Centro e del Sud Italia, di sparate siciliane analoghe alle nostre, estintesi nell’Isola soltanto alcuni decenni or sono! Dunque il mortaletto, oggi ligure per definizione, fu quasi certamente, ieri, un prodotto noto anche fuori Regione: alcuni turisti lombardi, notando i nostri mortaletti, hanno riconosciuto in essi quei “botti” – in Lombardia ormai “degradati” a fermacarte – che un tempo venivano accesi e ricaricati dalle singole famiglie in occasione delle feste.
In effetti, un’interessante e locale teoria “extra pirotecnica” indica un’ampia universalità dell’antica conoscenza del mortaletto presso i popoli europei: non mancano ad esempio massari i quali, pur anche attraverso supposizioni confortate da semplici indizi storici, individuano nel protagonista della nostra pirotecnica tradizionale il frutto dell’evoluzione antica di peculiari parti di secentesche armi da fuoco… e tali armi erano, come si sa, ben conosciute quantomeno nel Vecchio Continente. Secondo questa teoria, il mortaletto nasceva per essere caricato prima della battaglia, predisposto com’era ad essere fissato ad una canna di colubrina o spingarda prive di culatta. L’artigliere d’una fortezza, in questo modo, poteva disporre di parecchie munizioni, scomode e pesanti se vogliamo, sicuramente non portatili, ma già pronte al fuoco. Confermerebbe l’ipotizzata genesi bellica del mortaletto il suo attuale ed antico sinonimo: mascolo. Mascolo, dal momento che il pezzo così inteso avrebbe costituito il cosiddetto “maschio” nell’accoppiamento meccanico “protomunizione” – canna. Troviamo in effetti disegni d’epoca ritraenti sparate, di mortaletti praticamente identici ai nostri, muniti tuttavia di piccole maniglie (oggi scomparse) e sagomature in questo senso “sospette”. Ovviamente, sopra la carica del “mortaletto bellico” avrebbe trovato posto una palla, o la mitraglia.
Superfluo sottolineare quanto i mortaletti da festa non siano costruttivamente predisposti a simili nefasti impieghi…! Il nostro breve excursus storico sulla genesi del mortaletto è qui concluso; teniamo dunque a ricordare e sottolineare che ogni indizio, pur aprendo interessantissime discussioni sulla base del probabile, non costituisce prova del vero storico: saremmo pertanto lieti ed onorati nel ricevere interessanti conferme o smentite da parte dei nostri lettori.
…nel remoto 1619, i mortaletti erano già conosciuti in Rapallo ed utilizzati nel culto “piro – popolare” della Madonna di Montallegro.
Un po’ di tecnica del "massaro"

Protagonista ludico – popolare delle Feste di Luglio, il mortaletto si presenta come un piccolo cannone antico, a canna cortissima, costruito e dimensionato per il solo utilizzo a salve. Antica è anche la sua carica: polvere nera, il primo esplosivo prodotto dall’uomo. Lo stesso che, più di quattrocento anni fa, armava le galee genovesi ed i temibili vascelli del pirata Dragut, flagello delle popolazioni costiere.
Per caricare il mortaletto ligure, si versa semplice polvere nera nella canna, quindi la s’intasa con materiale leggero ed inerte (ad esempio segatura) in modo da ottenere, all’accensione, un colpo a salve, “impreziosito” da spettacolari quanto innocue vampe e fumo denso, di sapore antico.
Proprio tutto s’ottiene dall’antico miscuglio di zolfo, salnitro e carbone, nell’antica arte dei massari: caricati i mortaletti, gli stessi si aguginano: s’innescano cioè versando nel foro d’accensione (agugino) polvere nera finissima. Disposti a terra, i mortaletti sono poi collegati da strisce, ancora della medesima polvere, granulare questa volta: strisce che bruciano più o meno lentamente a seconda della direzione dominante della brezza di mare… Ecco quindi l’abilità del massaro il quale, per intuito ed esperienza, sa quando, come e dove posizionare i mortaletti, grossi o piccoli, in modo da salutare con giusto ritmo la Santa Patrona.
Come in tutte le arti, infatti, solo pochi posseggono in armonioso connubio esperienza ed innato dono nel saper disporre al meglio la sparata, che per riuscir veramente gradita deve attagliarsi, secondo Tradizione, ad ogni singola tipologia d’evento celebrativo. La pirotecnica antica tradizionale di Rapallo va oltre alle ben note celebrazioni dell’1,2,3 luglio, che danno il nome al presente sito.
Il mortaletto segna infatti il modus vivendi del rapallino verace (che non sempre coincide col rapallese), scandendone la vita pubblica e privata. Col mortaletto si cresce, ascoltando i colpi rituali dell’1,2,3 luglio o delle Feste Frazionali; si celebra il matrimonio di amici e parenti, preparando brevi ed allegre sparate; si saluta questo o quell’altro evento, sacro o profano; si dà l’estremo saluto ad un caro estinto disponendo un’austera sparata di 21 colpi, lenti e cadenzati: gli stessi ventuno che, con diverso spirito, ogni mattina di Novena accompagnano con sacralità l’Elevazione del Santissimo al Santuario di Montallegro.
La sparata è dunque… nel D.N.A. del rapallino, apprezzata com’è durante l’intero corso dell’anno ed, in particolare, nei Giorni Mariani dell’1,2,3 luglio: gli stessi giorni che vedono protagonisti delle celebrazioni “piro – popolari” rapallesi i rituali dei Saluti alla Madonna, dei Reciammi e del Panegirico, consolidatisi nell’ultimo secolo sulla base d’una tradizione sicuramente meno codificata dell’attuale, ma comunque perpetuata da quattro secoli quantomeno nei suoi aspetti, è il caso di dirlo, piro – tecnici. Infatti i gesti, tecnici appunto, che compiono oggi le abili mani dei massari sui ferruginosi mortaletti, nei greti dei torrenti e sulle spiagge, non differiscono dal fare dei nostri avi. Solo nei dove e nei come, la Tradizione d’oggi differisce da quella di ieri, ciò non inficiando tuttavia, a nostro parere, lo status di museo a cielo aperto di viva pirotecnica antica che amiamo attribuire alla nostra Città.

Si spari dalla chiatta

Quando il MASCOLO era usato per avvisare l’avvistamento dei leudi di ritorno dalla campagna delle acciughe dall’Isola della Gorgona.

Parata di moderni mascoli in acciaio pronti al caricamento, soffiati e disostruiti; in secondo piano sacchi e “cuffe” di segatura per i tappi.

Il mortaletto ligure usato nelle feste patronali di Rapallo
Il mascolo rituale utilizzato nel Levante genovese ed espressamente realizzato per le sparate è nella sua forma più ricorrente un cilindro metallico svasato alla base, anche se a volte ha forma troncoconica. Pesa circa 1,5–2 kg, è alto circa 12–15 cm, ha un diametro esterno di circa 6–7 cm al fusto e 8–9 cm alla base. Il calibro è ordinariamente compreso fra 1,5 e 2 cm. A circa 1,5 cm dalla base e parallelamente ad essa è praticato il focone ("l'agguggino") dal diametro di qualche mm, usualmente con l'imboccatura conica di base 3–4 mm e profonda circa 2–3 mm.
Il mascolo moderno è prodotto in acciaio in quanto la regolamentazione vigente proibisce l'uso di ghise ed ottoni, che hanno una minore resistenza ai fenomeni di frattura e possono finanche causare l'esplosione dei mascoli con proiezione di frammenti. I mascoli di ghisa subiscono inoltre fenomeni di corrosione importanti (in lingua genovese "camôe") che ne pregiudicano rapidamente la soglia di collasso.
Il mascolo in acciaio può essere prodotto per tornitura o per fusione. Fino a qualche anno addietro l'utilizzo di mascoli di ghisa o di ottone era frequente, questi ultimi più raramente a causa del costo del materiale. Tali erano formati per fusione, avevano dimensioni esterne maggiori di quelli in acciaio, e peso compreso fra i 2 e i 3 kg, pur contenendo lo stesso quantitativo di polvere. Notevoli per estetica sono i mascoli di ghisa realizzati fino alla prima metà del Novecento, ottenuti da stampi le cui forme elaborate presentavano spesso il nome o l'emblema del comitato di appartenenza riportato in rilievo sulla canna.
Più grande del mascolo è il cannone (in alcune località di Levante chiamato bomba), oggetto funzionalmente identico, la cui taglia può andare dal cannoncino (alcuni chilogrammi, per una lunghezza di 20 cm ed un calibro di 2–3 cm) al grande cannone (anche più di 100 kg per 40–50 mm di calibro, ma non mancano esempi di cannoni da 200 e passa chilogrammi, realizzati in genere in onore di importanti avvenimenti o illustri personaggi). I cannoni più grandi potrebbero contenere fino ad alcuni chilogrammi di polvere nera, ma la regolamentazione vigente vi pone severissime limitazioni per motivi di sicurezza; nella pratica attuale l'uso dei cannoni ha scopo prettamente ornamentale, in quanto caricati con quantità irrisorie di polvere rispetto alla mole dei pezzi. Per tale motivo alcuni dei più grossi cannoni sono stati addirittura messi in "disarmo" ed utilizzati per ornamento.
I cannoni in acciaio sono prodotti quasi sempre per tornitura a partire da grossi cilindri; hanno forma usualmente troncoconica e sono decorati da elaborate cerchiature. Riportano in genere, incisa sulla canna o sulla bocca, una dedica col nome del proprietario o del comitato a cui appartengono, o con la data di un evento gioioso quali un battesimo, un matrimonio o un anniversario. I cannoni di ghisa, oggi desueti, erano ancora più eleganti, provenendo da stampi e quindi potendo assumere forme non legate alle simmetrie cilindriche della tornitura.
I MASSARI ALL'OPERA









Ricerca a cura di Carlo GATTI
(Sestiere CERISOLA)
Rapallo, 20 Aprile 2023
ISOLA DELLE CHIATTE - GENOVA - PORTO ANTICO
ISOLA DELLE CHIATTE
(MAONE)
GENOVA - PORTO ANTICO
Questa ricerca NASCE DA UNA FOTO POSTATA SU F/B DALL’AMICO SERGIO SCHIAFFINO CHE RINGRAZIO
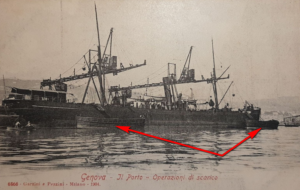
Sergio racconta: Ecco la fine che facevano i leudi in disarmo...Li rinforzavano, tagliavano la “pernaccia” di prua, e la coperta molto arcuata spariva, sostituita da tavolame di recupero, diventando piana (chiatta) nel Porto di Genova.
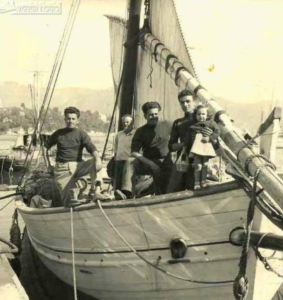
Qui siamo a Santa Margherita... e mio nonno Luigi con il basco blu a bordo del Antonio II con i figli Vittorio, Angelo (mio papa') e Mario, la bimba invece è mia sorella Carla... sono un po' anzi, parecchio geloso dell'opportunità che ha avuto di salire a bordo di un leudo della nostra famiglia...
LE CHIATTE (MAONE) ORMAI SUPERATE DALL’ERA DEI CONTAINER RIVIVONO COME “SOSTEGNO” DEI PONTILI NEL PORTO ANTICO DI GENOVA


Il Bigo con l’ascensore panoramico è situato nell’area del Porto antico, di poppa all’Acquario di Genova. Progettato dall’architetto Renzo Piano, offre una straordinaria prospettiva aerea di uno dei più estesi e ricchi d’arte centri storici d’Europa.
L’idea di utilizzare le Chiatte per creare un’area in mezzo al mare è venuta proprio al famoso architetto genovese Renzo PIANO. Le Chiatte erano vecchie imbarcazioni utilizzata nel porto di Genova fine ‘800 per trasportare merci, potevano fungere anche da estensioni delle banchine stesse, fino a metà del ’900 sono state indispensabili all’interno del porto.
Dal G8 del 2001 l’Isola delle Chiatte regala ai suoi visitatori una rilassante e suggestiva esperienza sensoriale. La piazza creata come una sorta di area galleggiante pubblica, è dotata di panchine e area panoramica per le foto ricordo.


ISOLA DELLE CHIATTE – LUCIANO BERIO 1925 (Oneglia) – 2003 (Roma)
Musicista, Compositore italiano tra i più importanti dell’avanguardia europea, pioniere anche nel campo della musica elettronica
L’Isola delle Chiatte nel Porto Antico di Genova emana un fascino particolare che esala atmosfere magiche tra Antico e Moderno. Ci si arriva costeggiando la struttura dell’ACQUARIO (la NAVE BLU).

Il vero punto di partenza del percorso è la Biosfera, meglio conosciuta come la BOLLA DI RENZO PIANO. (foto sopra)

Ammirata la Bolla, si passeggia sul lungo molo, a destra l’imponente nave dell’Acquario, a sinistra si ammirano le varie imbarcazioni attraccate e sullo sfondo la struttura dei Magazzini del Cotone. (foto sopra)

In primo piano la parte superiore del BIGO
In secondo piano l’ACQUARIO
In terzo piano la FLOTTA Rimorchiatori del porto
In quarto piano la MSC MUSICA
(sopra) - Il pontile proiettato verso il mare)
(sotto) - S’intravedono le MAONE che lo sostengono

In questa immagine è ben visibile la chiatta che sostiene il pontile panoramico

Vista sulla città (sopra e sotto)

L’Oasi circondata dal mare rappresenta un angolo di pace per tutti. Leggere un giornale, guardare le barche che entrano ed escono dal Porto Antico, studiare, oppure anche solo prendere un pochino di sole ad un passo dal mare seduti su una panchina di legno.
La zona più panoramica si trova sul prolungamento del molo dedicato al cantautore Fabrizio De André, che affianca l’ACQUARIO di Genova, nel Porto Antico. Sulla testata del molo è stata realizzata questa struttura galleggiante, che poggia sulle chiatte che un tempo animavano lo scalo trainate da “piccoli e pittoreschi” rimorchiatori fumanti per lo scarico delle navi.
Ho usato la parola “piccoli” perché dovevano essere “maneggevoli” per entrare e manovrare in spazi molto ristretti, ma in verità erano potenti dovendo, come tutti sappiamo, affrontare la tramontana che in giornate particolari raggiunge velocità impressionanti. In queste occasioni, non rare a Genova, ho avuto modo di apprezzare questi valorosi Comandanti risolvere situazioni molto difficili quando la maona, spinta dal vento, prendeva il sopravvento ed il piccolo convoglio andava a “torscio” per le calate….

Punta estrema dell'Acquario, la Tolda della NAVE BLU offre agli ospiti un incredibile panorama a 360° del Porto Antico, del porto e della città abbracciata dalle colline e circondata dalle mura erette nel XVII secolo.
TRAMONTO MAGICO


Senza parole….

GALLERIA D’IMMAGINI
SCOPRIAMO LE CHIATTE


Anche le Chiatte/Maone, come le navi, passarono dalla costruzione in legno a quella in ferro mantenendo le stesse attività operative


Passeggiando su questo pontile a volte si prova l’emozione del “rollio”

Certe immagini ci lasciano senza parole….

Compiuto questo giro esplorativo nel cosiddetto Porto Antico, una vera opera d’ARTE dell’architetto Renzo PIANO, mi sorge un dubbio:
Pur avendo lavorato per oltre 35 anni nel porto di Genova, sono rimasto colpito dall’impiego finale… delle MAONE (così le ho sempre sentite chiamare ) dopo l’avvento del sistema CONTAINER che cambiò la storia dei Trasporti. Ci voleva l’idea ingegnosa, marinara e parsimoniosa di questo strepitoso ARCHITETTO che non poteva che essere GENOVESE….!
UN PO’ DI STORIA …
Con questa premessa ritengo doveroso raccontare, per chi fino ad oggi non conosceva la MAONA, l’interessante storia di questo mezzo nautico che tuttora nei nostri ricordi rappresenta la praticità operativa nell’impiego portuale nave-banchina e viceversa, ma anche il suo lato romantico che voglio rappresentare con questo dipinto di Giuseppe Sacheri, tratto da “L’illustrazione Italiana” numero di Natale e Capo d’Anno 1916-1917.

Fino alla metà dell’Ottocento, l’organizzazione e la struttura del porto di Genova non si era modificata sensibilmente rispetto ai secoli precedenti: prevedeva quindi un limitato accosto delle navi maggiori alle banchine, che erano di lunghezza insufficiente e comunque presentavano fondali poco profondi. Le navi si ancoravano al centro del porto, dove il carico era passato su chiatte di varie dimensioni, che poi erano portate in banchina per lo scarico definitivo. Oppure, se le merci erano destinate a essere reimbarcate su altre navi, quei carichi erano denominati merce di trasbordo e rimanevano anche a lungo stivati sulle chiatte. L’ingegnere inglese Randell, incaricato insieme all’ing. Sarti della stesura di uno studio di fattibilità per l’ammodernamento dello scalo, poteva osservare: “Questo non è un porto...è una rada!”. La ragione principale per cui l’incremento dei traffici del porto di Genova coincise con un sempre maggiore utilizzo delle chiatte.
ALBUM FOTOGRAFICO DI UN’EPOCA ORMAI TRAMONTATA
ANNI ‘20

Le chiatte in Darsena


Questa foto (sopra) descrive nei dettagli l’epoca di convivenza tra Velieri e Vapori. Si notano anche le chiatte a rimorchio ma soprattutto l’intensa attività svolta in uno spazio relativamente piccolo.

I “camalli” e le maone

Maona e Cadrai


Immagini di vita quotidiana delle MAONE

Numerose chiatte al lavoro intorno alla nave passeggeri SKUTARI
Anni '50-'60 del Novecento

Così si presentava il PARCO CHIATTE alla fine degli Anni ’60 del 900.
L’ormeggio delle maone era posizionato su un bassofondo tra il Molo Vecchio e Ponte Parodi. Sulla prima banchina citata sono attraccate le navi da carico della generazione precedente l’Era Container, sulla seconda (Ponte Parodi) sono ormeggiai di punta i rimorchiatori portuali, tra i quali si nota (per le dimensioni) il rimorchiatore d’altura VORTICE ammiraglia della Flotta RR.
Sullo sfondo di questa immagine significativa si scorge: la MICHELANGELO mentre entra in avamporto.

Parco chiatte, ubicata davanti alla Darsena
LA DARSENA
CUORE ANTICO DI GENOVA
Carlo GATTI
https://www.marenostrumrapallo.it/dar/
Parco chiatte davanti alle Calate Interne


Sulla destra del disegno: LE CALATE INTERNE e la Darsena…
Dalle Calate Interne del Porto Vecchio, oggi chiamato Porto Antico, mille anni fa partivano i crociati per la Terrasanta dopo aver alloggiato nella retrostante COMMENDA di S. Giovanni in Pré. Da qui è passata la storia del capoluogo che dura da un millennio, ma questa Genova, “con quellafaccia un po’ così…” conserva ancora la curiosa espressione di chi scopre facce sempre nuove, senza chiedersi se hanno una casa o una nave come casa.

Scorcio sul Porto Vecchio Anni ‘60
Ecco come si presenta oggi il
PORTO ANTICO
dopo la Rivoluzione di Renzo Piano
Il tramonto della maona è legata all’inizio dell’era dei container… E fu tutta un’altra storia…
LA STORIA DEL CONTAINER
L’idea di un contenitore con caratteristiche standard proprie per il trasporto delle merci deriva da una intuizione avuta nel 1956 da Malcolm McLean, un imprenditore americano nel campo dei trasporti.
Si racconta che, un giorno del 1937, McLean sedeva sul suo camion in porto in attesa che la merce fosse portata a bordo della nave. Così andò a prendere le sigarette al distributore automatico ed ebbe l’idea che cambiò il trasporto globale delle merci. Si rese conto che caricare l'intero corpo del camion sulla nave sarebbe stato molto più semplice che stivarne il carico.
All’epoca il carico delle merci su una nave era un procedimento lungo e rischioso: ogni camion andava scaricato e le merci venivano stivate una alla volta a bordo della nave.
McLean osservò i pacchetti di sigarette impilati nel distributore automatico e si rese conto di quanto il contenitore delle sigarette facilitasse il trasporto.
Notò che se la merce fosse stata inserita in un contenitore che si poteva prelevare dal camion per essere trasferito direttamente sulla nave, sarebbe stato tutto molto più veloce.
Era nata l’idea che avrebbe portato allo sviluppo del primo container


Malcolm McLean
Il 26 aprile 1956 dal porto di Newark, una città degli Stati Uniti d’America, salpò la nave merci IDEAL X con 58 container a bordo, ognuno dei quali conteneva quasi 20 tonnellate di merci.
Giunta a Port Houston, McLean verificò che il suo costo per tonnellata era stato 0,16 dollari, a fronte di un costo medio per l’epoca di 5,83 dollari la tonnellata. Di conseguenza l'idea di containerizzare ha avuto un impulso notevole nel campo del trasporto marittimo fin dagli anni sessanta. Il container offriva diversi vantaggi: minor carico danneggiato o manomesso, migliore gestione logistica e maggiore velocità di imbarco e sbarco.
Già agli inizi degli anni ’80, praticamente tutti i paesi erano attrezzati per ricevere le navi cariche di container e per movimentarli sui mezzi di trasporto.
Oggi in qualsiasi porto è usuale la visione di enormi colonne di container pronte ad essere imbarcate per ogni destinazione nel mondo e il container è ancora lo strumento principale per trasportare merci su tutto il pianeta.
MEMORIE DAL MARE
COMANDANTE S.L.C. Ernani ANDREATTA
Cap. 24
I colpi di Timone di Angelo Ravano, finanziere e imprenditore di Lavagna
In quella occasione Caterina Romanengo detta “NININA” moglie dell'armatore Angelo Ravano mi raccontò che quando suo marito, appunto Angelo Ravano, andò negli USA per informarsi sui containers inventati da Malcolm McLean, tornando lo riferì ai Costa Armatori i quali rimasero molto scettici sul futuro di questo nuovo sistema di trasporto e gli dissero:
“Ma Angiulin (Ravano) cöse ti veu fâ con ‘sti “CASSCIUIN” … ).
Trad: - "Ma Angelo cosa vuoi fare con questi cassoni"?
Eppure dopo si convinsero molto rapidamente dell’utilità di questo nuovo sistema di trasporto e ne furono grandi promotori!
SIGNIFICATO DI MAONA
Nautica
-
Maona– termine che indica vari tipi di imbarcazione: un antico bastimento mercantile o da guerra, a tre alberi, in uso nei mari del Levante Mediterraneo e nell'Adriatico fino al XV e XVI secolo; un barcone da trasporto di cabotaggio, un tempo ad una vela, oggi a motore, ancora in uso tra i porticcioli delle isole egee; una chiatta lunga sino a 20 metri sulla quale il rais, ossia il capo della mattanza, comanda gli uomini della tonnara.
(Treccani):
Barcone da rimorchio, usato nei porti per il carico e lo scarico delle merci.
Storia
-
Maona – termine storiografico relativo al Medioevo o all'Età moderna, che indica una associazione di mercanti, volta a gestire, in regime di concessione da una Repubblica Marinara, in condizione di monopolio, o una miniera, come la Maona della Tolfa, o una città, come Ceuta, o un'isola, come Chio
Sociologia
-
Maona – in lingua araba indica un principio di solidarietà, o di comunione di intenti e d'interessi, fatto proprio da un'associazione commerciale, una cooperativa, ma anche da una organizzazione di mutuo soccorso.
Glossario Termini Nautici (Tuttobarche.it)
Maona - Zattera o chiatta, generalmente rimorchiata, utilizzata per il trasporto merci. L'etimologia della parola deriva dal francese Mahon, mahone, dallo spagnolo, mahona; dall'arabo mahun vaso come Vascello da Vaso.
Seguono alcune TESTIMONIANZE
Comandante S.L.C. Mario Terenzio Palombo:
..... nel tuo articolo del venerdì, ho visto le foto delle CHIATTE. Mi sono commosso nel vederle. Ho pensato che, tra quelle chiatte, ci sarà stato probabilmente anche
il veliero NETTUNO di mio padre che era stato venduto e poi trasformato in una chiatta e affondato carico di massi fuori del porto di Genova, come mi raccontò mio padre....
Una piccola GRANDE storia:

La NETTUNO all'Isola del Giglio - 1950

A Camogli mancava l’ultimo veliero che entrava in porto a vele spiegate e che era parte della storia marinara della cittadina. La sua scomparsa segnava la fine di un’ epoca. Il “Nettuno” venne venduto per essere trasformato in una zattera per trasporti portuali. Alcuni anni dopo mio padre mi disse con rammarico che, mentre entrava
con la sua motonave in porto a Genova, aveva visto il “Nettuno” carico di
grossi massi. A causa del mare molto agitato, uno di questi si era mosso
facendolo sbandare fortemente e l’acqua era traboccata in stiva causandone
l’affondamento. Immagino lo stato d’animo di mio padre in quel momento.
La testimonianza di una "operazione salvataggio chiatta" ce l'ha inviata il Com.te Flavio Serafini Direttore Museo Navale Internazionale Imperia:
Con il permesso della Soprintendenza di Genova sono riuscito (2014) a salvare l'ultima CHIATTA disponibile nel porto perché mi ero accorto che conservava ancora in buono stato la scassa dell'albero di un leudo. Ho salvato quindi la sezione maestra, come da immagini allegate.
Aggiungo alcuni altri dettagli dell'"operazione chiatta":
L'avevo notata a secco in una banchina di Genova; chiesi ed ottenni dalla Soprintendenza di poterla valorizzare al Museo. Le spese del rimorchio a bordo di un tir furono a carico della stessa Soprintendenza. Per diversi mesi fu lasciata in banchina nell'attesa che terminassero i primi lavori di ristrutturazione delle due palazzine museo e banchina. In quel periodo ho temuto che qualcuno potesse dar fuoco a quel "rudere" ( così veniva definito) che stonava nell'ambiente. Finalmente decisi di salvare la sezione maestra, cerando anche di recuperare la coperta curvilinea tipica dei leudi. Particolarmente difficile fu l'uso delle motoseghe, (ovunque si trovava chiodagione che in parte ho salvato) e per la consistenza di un legno stagionato che sembrava più duro del marmo. Il tutto doveva essere conservato nella Sezione "Cantieristica" che purtroppo non esiste ancora. Devo ancora pazientare! Impossibile ritrovare il nome originale del leudo. Alcuni reperti del leudo "Angela Prima", frutto della demolizione a Riva Trigoso del 1983, sono comunque al Museo. Altra operazione durata tutta una giornata!




Sulla primitiva coperta arcuata dei leudi venivano sovrapposte delle tavole. In questa foto sotto si possono ancora notare i bagli originali tuttora conservati.

Carlo GATTI
Rapallo, 21 Marzo 2023
16 MARZO 1951 - LA PETROLIERA MONTALLEGRO ESPLODE NEL PORTO DI NAPOLI
16 MARZO 1951 - LA PETROLIERA MONTALLEGRO ESPLODE NEL PORTO DI NAPOLI

Petroliera MONTALLEGRO: Armatore CAMELI
La società “Carlo Cameli & C.” viene fondata nel Luglio 1927 a Genova, si presentava all’inizio del secondo conflitto mondiale forte di una flotta di cinque motocisterne per oltre 13.000 tsl.
Alla fine del secondo conflitto mondiale, la flotta versava in una situazione catastrofica avendo perduto praticamente la totalità del suo tonnellaggio d’anteguerra ma a seguito di un programma di ricostruzione del naviglio sociale efficiente ed ambizioso, già nel 1953, la società poteva contare su un tonnellaggio leggermente superiore a quello dal 1940, circa 13.665 tsl. L’aliquota maggiore del nuovo tonnellaggio societario era rappresentato dalla T2 Montallegro (ex Crater Lake), la quale ebbe una vita molto avventurosa nel secondo dopoguerra, esplosa in due tronconi mentre era sotto discarica nel porto di Napoli nel 1951, venne riparata e continuò a navigare fino al 1965.
Tra le altre società satellite che il Gruppo controllava è opportuno citare la “Navigazione Toscana S.p.A.” che esercitava le linee da e per l’Arcipelago Toscano (Linea 81, 82, 82 bis, 83, 84), anch’essa duramente colpita dagli eventi bellici che la videro perdere il suo intero tonnellaggio ammontante a circa 4000 tsl.
Nel primo dopoguerra si dotò di due ex corvette della U.s. Navy riadattate al servizio passeggeri (PortoAzzurro e Portoferraio) e della motonave Pola, acquistata nel 1953.
Filmato dell’incidente registrato nel porto di Napoli

https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000018848/2/esplosione-petroliera-nel-porto-napoli.html&jsonVal=
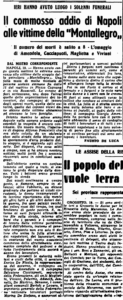
La lettura di questo articolo mi trasmette anche tanta tristezza nel vedere elencati tutti i nomi e cognomi dei “politici” intervenuti alla cerimonia funebre mentre sono stati del tutto ignorati quelli delle vittime. La mia ricerca di quei nomi e cognomi è stata vana quanto inutile!
IL NOME DELLA NAVE
Quando una nave porta il nome: “MONTALLEGRO”, ai RAPALLINI s’illuminano gli occhi, ed il loro sguardo si rivolge al santuario della Madonna di Montallegro che svetta a 612 mt. sul golfo Tigullio e che da almeno cinquecento anni i marinai e non solo loro, si sentono protetti da quel che ritengono uno scudo spirituale celeste testimoniato da centinaia e forse migliaia di ex voto marinari.

Santuario Basilica Nostra Signora di Montallegro (Rapallo)
Il Santuario di Nostra Signora di Montallegro nasce dopo l’Apparizione della Madonna del 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, nativo della vicina San Giacomo di Canevale; da quel giorno ormai lontano il Tempio, tanto caro alla gente tigullina emana, proprio come un FARO MARITTIMO, una forte luce diuturna per migliaia di naviganti che prima o poi lassù salgono in pellegrinaggio per pregare e lasciare una testimonianza di fede alla Madonna: un voto per GRAZIA Ricevuta durante il passaggio di un viaggio nell’inferno di CAPO HORN; ne abbiamo le testimonianze: tre velieri su cinque erano disalberati dai venti ruggenti e urlanti di quelle latitudini e si perdevano nei gelidi abissi dell’emisfero australe.
Tavolette, dipinti rustici, cuori argentati, grucce, vecchi fucili, proiettili, bombe a mano e molti altri attrezzi marinareschi ancora salati: pezzi di salvagente, di cimette e bozzelli che oggi sono scatti fotografici che fermano il tempo e ci rendono partecipi di quei tragici momenti sofferti dalla gente di mare. Testimonianze che nell’assumere valore religioso, esprimono la fede, la speranza di salvezza e di protezione, ma sono anche l’espressione di una gratitudine profonda ed indicibile.
Il sottile filo del tempo corre dalla preistoria fino ai giorni nostri unendo questi figli del mare immersi in tutte le attività ad esso collegate. Marinai che dopo aver affrontato bonacce insidiose e tempeste estremamente pericolose, combattevano spesso a mani nude contro i frequenti attacchi dei pirati barbareschi che li depredavano, li sequestravano e li tenevano prigionieri nelle loro cale barbaresche in attesa del riscatto che veniva concordato con il “Magistrato genovese del riscatto degli schiavi”.
Dalle avventure di tal genere nascono spontanei gli ex voto raccolti a Montallegro e nei santuari mariani della nostra riviera, quale atto di devozione e di gratitudine per lo scampato pericolo, ma anche come manifestazione di religiosità, di quel senso spirituale che ogni uomo ha radicato in sé e che si estrinseca nei momenti difficili della vita.

La petroliera Montallegro stava facendo lavori di manutenzione nel porto di Napoli, era quindi “vacante” (vuota di carico).
Era il 16 marzo 1951. Come visto nel filmato, l’esplosione a poppavia divise la nave in due tronconi, seguita da un pericoloso quanto esteso incendio che costrinse le navi ormeggiate vicino al disastro ad allontanarsi in estrema emergenza.
La parte prodiera rimase a galla. La parte poppiera, contenete il “locale pompe”, caldaie, turbine ed il motore della nave affondò precipitando sul fondale.
A bordo c’erano 150 operai. 6 furono i morti e 51 i feriti.
Tra le vittime c’erano l’Ingegnere di fiducia dell’armatore Cameli e l’Allievo di coperta della Montallegro che, al momento dello scoppio si trovavano vicini alla cisterna esplosa.
Le salme furono trovate fuori bordo a parecchi metri di distanza dalla Montallegro, le altre vittime erano operai del Cantiere.
LA CAUSA
Si seppe in seguito che la cisterna responsabile era la n.9 centrale. Nell’ambiente intanto circolava insistentemente il “rumor” che sul fondo della cisterna c’erano residui del carico precedente che esalavano gas. Un estrattore d’aria, usato per arieggiare la cisterna, era difettoso e aveva prodotto la scintilla di innesco della miscela esplosiva di gas e aria esistente nella cisterna.
Il grande incendio era dovuto all’innesco dei gas ancora presenti in cisterna. Il concetto tecnico che definisce la causa più probabile del disastro sarebbe questo:
“la cisterna non era correttamente GAS FREE”
Sulle petroliere sono stati richiesti sistemi a gas inerte a partire dai regolamenti SOLAS del 1974.
L’Armatore Carlo Cameli, sentiti i periti del RINA (Registro Navale Italiano) e dello ABS (American Bureau of Shipping) decise di recuperare e riparare la nave.
Riporto uno stralcio dell’articolo scritto dall’Allievo di coperta Dino Bolla di Savona, che alla fine degli anni ’60 conobbi come ufficiale sui Rimorchiatori d’Altura di Genova. Una bella persona che raggiunse il Comando e fece una brillante carriera.
“Mentre aspettavamo che il cantiere finisse i lavori, assistevo ai lavori degli operai in coperta, senza disturbarli; io mi tenevo in disparte e non parlavo. Ma, ogni tanto, qualcuno mi diceva, come se non lo sapessi, che il mio predecessore aveva fatto una brutta fine. Ribattevo che con operai a bordo sarei stato molto attento. C’erano anche quelli che mi dicevano che, con mare agitato, le saldature che collegavano i due pezzi di scafo potevano rompersi; ribattevo che i Periti del RINA e del ABS, con i quali ero in buoni rapporti (ed era vero), mi avevano detto che la nave era più robusta di prima, perché avevano fatto aumentare il numero di strisce longitudinali di rinforzo, in acciaio, sulle saldature che univano i due pezzi dello scafo.
…. Venne presto il giorno della partenza. Il primo viaggio fu da Napoli, in zavorra, a Ras Tanura, nel Golfo Persico, per caricare crude oil. Prevista prosecuzione per Swansea, UK, per scaricare. A bordo tutto funzionava come se la MONTALLEGRO fosse nuova.”
Riporto integralmente l’articolo di Dino Bolla perché ritengo sia prezioso per il lettore e, soprattutto per i giovani che si avvicinano oggi alla vita di mare per comprendere meglio l’atmosfera di bordo del dopoguerra in cui lavorarono e vissero i loro nonni.
LA PETROLIERA MONTALLEGRO
https://docplayer.it/docview/40/21087833/#file=/storage/40/21087833/21087833.pdf
LA M/N MONTALLEGRO ERA UN T/2 – USA
UN PO’ DI STORIA
Nel 1946 furono offerte all’Armamento italiano importanti possibilità di rinnovamento e di ricostruzione: il provvedimento del Governo in data 20 Agosto 1946 concedeva in particolare agli Armatori di trattenere la valuta estera introitata perché fosse impiegata nell’acquisto di naviglio usato e lo Ship Act degli Stati Uniti consentiva la vendita all’estero di navi residuate di guerra a condizione di particolare favore. Per facilitare l’acquisto delle navi furono stipulati accordi tra il Governo degli Stati Uniti e quello Italiano, per cui il Governo Italiano provvide a comperare in proprio le navi dalla U.S. Marittime Commission e a rivenderle agli armatori secondo un criterio di preferenza in base alle perdite subite. Il prezzo medio di ogni Liberty si aggirava sui 225.000 $. Il Governo Italiano provvide, inoltre a fornire agli Armatori la valuta per il pagamento immediato del 25% del prezzo e al Governo degli Stati Uniti la garanzia per il pagamento del residuo 75% in 20 anni al tasso del 3,50%. Furono così acquisite alla bandiera italiana in tre lotti successivi 95 navi da carico del tipo “Liberty” o similare, di circa 7.600 t.s.l. e 10.800 t.p.l, 20 navi cisterna del tipo “T/2” di circa 10.400 t.s.l. e 16.600 t.p.l. e otto navi da carico del tipo “N3” di circa 2.000 t.s.l. e 2700 t.p.l.
Navi della Reserve Fleet USA ormeggiate in massima sicurezza
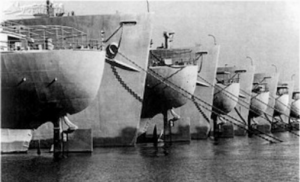
20 dicembre 1972 - Foce del fiume James (nei pressi di Newport News, Virginia).
Mercantili tipo “Victory” in stato di conservazione nell’ancoraggio della National Defence Reserve Fleet. Entro la fine del decennio saranno tutti avviati alla demolizione.
(Foto U.S. Naval Institute)
“Al primo impatto con quella baia ricoperta di centinaia di Liberty ancorati ed affiancati a rovescio, (prora con poppa), ci venne naturale riflettere su quell’immensa produzione bellica ed alla presunzione di chi ci aveva governato per vent’anni e che non aveva minimamente stimato il patrimonio umano, la ricchezza, le capacità tecniche ed organizzative, di quella potenza economica che era l’America di quel tempo. E ci fu subito un’altra sorpresa: ci aspettavamo, dato il basso costo d’acquisto della nave, d’imbarcare s’un residuato bellico quasi da demolire. Al contrario ci trovammo su un Liberty perfettamente funzionante, in ottimo stato di conservazione, perché era visibile, in ogni suo angolo, l’opera di una manutenzione accurata ed eseguita ogni giorno durante la sosta alla fonda. La nave era provvista di frigoriferi, ampie salette, cabine singole per gli ufficiali e doppie per la bassa forza. La strumentazione nautica: girobussola, radiogoniometro, eco-scandaglio, costituiva una novità assoluta per quell’epoca. Devo dire che tutto il materiale a nostra disposizione sul Liberty era all’avanguardia per quei tempi”.
Reserve Fleet: Navi “VIctory” – “T/2” ed altre ormeggiate sull’Hudson River

Petroliera T2

Immagine di una T/2 in versione militarizzata.
The U.S. Type T2-SE-A1 tanker Hat Creek underway at sea on 16 August 1943.
La petroliera T2 è stata una nave costruita per il trasporto di petrolio e suoi derivati, progettata e realizzata negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale.
La T2 standard aveva le seguenti caratteristiche:
Lunghezza totale:152,9 mt.
Larghezza massima: 20,7 m.
Stazza: 8.981 tonnellate
Portata lorda: 16.104 tonnellate.
Dislocamento totale standard di una T2: si aggirava intorno alle 19.141 tonnellate.
Le petroliere T2 avevano per l'epoca delle dimensioni rilevanti, superate solo dalle petroliere T3, che però furono costruite solo in cinque esemplari. 500 furono le T2 costruite tra il 1940 ed il 1945, molte delle quali furono utilizzate per decenni dopo la fine della guerra. Come altre navi realizzate in questo periodo, andarono incontro a problemi di sicurezza: dopo che nel 1952 due T2 - la SS Pendleton e la SS Fort Mercer - andarono perdute a distanza di poche ore spezzandosi in due tronconi (l'equipaggio della Pendleton venne tratto in salvo da una difficilissima e storica operazione condotta dal marinaio Bernard Webber a bordo di una motovedetta CG 36500), lo U.S. COAST GUARDA MARINE BOARD OF INVESTIGATION dichiarò che queste petroliere erano inclini a spezzarsi in acque fredde, pertanto vennero aggiunte alla struttura della nave delle strisce di acciaio. Le inchieste tecniche attribuirono inizialmente la tendenza delle navi a spezzarsi alle scarse tecniche di saldatura. In seguito venne stabilito che, durante la guerra, l'acciaio utilizzato per la loro costruzione aveva un contenuto di zolfo troppo elevato, che lo rendeva fragile alle basse temperature.
LE ALTRE VERSIONI DELLA T2:
Il progetto della T2 venne formalizzato dalla United States Maritime Commission come tipologia di petroliera per la Difesa Nazionale di medie dimensioni. La nave veniva costruita per il servizio commerciale ma in caso di conflitto poteva essere utilizzata come nave militare inserita nella flotta ausiliaria. La Commissione si faceva carico della differenza dei costi aggiuntivi dovuti all'inserimento di tutte le caratteristiche necessarie per l'impiego militare della nave e che andavano oltre i normali standard commerciali.
Il modello T2 venne basato su due navi costruite nel 1938-1939 dai cantieri Bethlehem Steel per la Socony-Vacuum Oil Company. Le due navi, Mobifuel e Mobilube, differivano dalle altre navi Mobil principalmente per l'installazione di un motore più potente che poteva garantire una maggiore velocità.
Le sue turbine a vapore fornivano 8.900 KW (12.000 hp) ed azionavano un’elica singola che poteva spingere la nave fino ad una velocità di 16 nodi.
In totale ne sono state costruite sei utilizzate per l'impiego commerciale presso i cantieri Bethlehem-Sparrows Point Shipyard che avevano sede in Maryland. Subito dopo l'attacco a Pearl Harbor le navi sono state prese in carico dalla U.S. Navy dove vennero riunite nella classe Kennebec.
La T2-A
La società Keystone Tankships ordinò nel 1940 la costruzione di cinque cisterne che vennero realizzate presso i cantieri Sun Shipbuilding & Drydock di Chester, Pennsylvania. Erano basate sul progetto delle T2 ma erano più lunghe ed una maggiore capacità di trasporto. La Commissione designò queste navi come T2-A.
Avevano una lunghezza di 160,3 m ed un dislocamento di 20.361 tonnellate. La stazza era di 9.616 tonnellate con una portata lorda di 14.787 tonnellate. Raggiungevano una velocità di 16,5 nodi e furono tutte requisite dalla Marina durante la guerra. Furono trasformate in petroliere per la flotta come classe Mattaponi.
La T2-SE-A1
Costituiva la tipologia più popolare delle petroliere T2. Questa versione era nata come progetto di una nave destinata all'impiego commerciale. La loro costruzione avvenne a partire dal 1940 presso i cantieri Sun Shipbuilding Company per la Standard Oil Company del New Jersey. Aveva una lunghezza di 159,4 e una larghezza di 20,7 m. La stazza era di 9.478 tonnellate e una portata lorda di 15.071 tonnellate. Il loro sistema di propulsione era turbo-elettrico che forniva 6.000 hp (4.474 kW) all'albero con la potenza massima raggiungibile di 5.400 kW (7.240 hp). La velocità massima era di 15 nodi con una autonomia di 12.600 miglia.
Dopo Pearl Harbor la Commissione ordinò la costruzione in massa di questo modello con il quale rifornire tutte le unità da guerra che allora erano in costruzione.
Ne sono state costruite 481 in un tempo relativamente breve nei cantieri Alabama Drydock and Shipbuilding Company di Mobile, Alabama, i cantieri Swan Island Yard della Kaiser-Company di Portland - Oregon nei cantieri della Marinship Corp di Sausalito - California e nei cantieri Sun Shipbuilding and Drydock Company di Chester-Pennsylvania. Il tempo medio di costruzione di una di queste navi, dalla posa della chiglia al completamento, era di 70 giorni. Il record di velocità di costruzione è stato quello della SS Huntington Hills che era pronta per le prove in mare dopo soli 33 giorni in cantiere.
Le T2-SE-A2
Era una versione costruita solo nei cantieri Marinship di Sausalito. Era una copia quasi identica della T2-SE-A1 dalla quale differiva solo per la potenza del motore che era di 7.500 kW (10.000 hp) invece che di 7.240 hp (5.400 kW).
La T2-SE-A3
era una -A2 costruita però fin dall'inizio come rifornitore di flotta piuttosto che modificata per tale compito come molte altre A2.
T3-S-A1
La versione T3-S-A1, nonostante la sua denominazione che può creare confusione, venne costruita nei cantieri Bethlehem Sparrows Point per la Standard Oil del New Jersey. Erano identiche alle T2 originali, tranne che per la minore potenza del motore che era di 5.742 kW (7.700 hp). Ne vennero ordinate venticinque unità delle quali cinque furono utilizzate dalla Marina che le riunì nella classe Chiwawa.
Come abbiamo già visto, la petroliera MONTALLEGRO fu acquistata dall’Armatore Carlo CAMELI di Genova. Per chi volesse conoscere meglio la storia di questo Armatore propongo il seguente LINK:
https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-cameli_%28Dizionario-Biografico%29/
RIFLESSIONE FINALE
Come da consuetudine, durante i lavori di manutenzione annuali, il personale di bordo viene sbarcato per fine contratto, oppure viene mandato in licenza. Fu soltanto per questo motivo che l’equipaggio della MONTALLEGRO può definirsi salvato “P.G.R.” dalle terribili conseguenze di quell’esplosione del 16 marzo 1951.
Tuttavia, in quel giorno infernale per tutta la città di Napoli, non tutto l’equipaggio si salvò. l’Allievo di coperta era presente a bordo insieme all’Ing. fiduciario dell’Armatore. Chissà per quale misteriosa coincidenza del destino, in quel fatidico “momento”, entrambi si trovavano a poppavia della nave nei pressi della cisterna n.9 che esplose?
Ancora oggi, a distanza di 72 anni, il nostro triste pensiero va comunque a queste due persone che furono le uniche vittime di quell’equipaggio a causa di una fatale coincidenza del destino.
Come non accumunare ad essi le altre maestranze del Cantiere navale che persero la vita nel loro porto, vicino alle loro case e alle loro famiglie.
A noi sembra che la causa sia stata la palese carenza di procedure di “sicurezza” male applicate in ambienti di lavoro estremamente delicati per la presenza di gas velenosi ed anche esplosivi i quali, entrando in contatto con fiamme ossidriche o scintille sprigionate da qualsiasi utensile non regolamentato, diventano bombe micidiali.
Purtroppo, il tragico evento della MONTALLEGRO non fu il primo né l’ultimo nella storia di navi ai lavori di manutenzione. E ci viene sempre in mente quel saggio detto che ancora oggi si sente recitare come un ritornello sui “bordi”… ma anche nelle case di tutto il mondo all’ora dei TG nazionali:
“TUTTI PARLANO DI SICUREZZA E DI SOLIDARIETA’, MA POCHI DI LORO SONO DISPOSTI A PAGARLA”.
Carlo GATTI
Rapallo, 22 Marzo 2023
MUSEO NAVALE INTERNAZIONALE DEL PONENTE LIGURE
MUSEO NAVALE INTERNAZIONALE DEL PONENTE LIGURE
Monumento ai naviganti di Capo Horn alla radice del molo lungo di Porto Maurizio-Imperia

Inaugurato il 23 maggio 1983 in occasione del secondo e ultimo congresso mondiale dei Capitani di Capo Horn (450 membri appartenenti a 13 nazioni)
UN PO’ DI STORIA tormentata…
Museo Navale: una storia infinita, una nuova “incompiuta”?
Ottobre 1978: intuizione storica sul Museo, vedasi “proposta” nel volume “La Città dei Marinai”.
23/8/1978 : Istituzione Museo Navale- Atto della Giunta n.°1469 del Comune di Imperia.
27/8/1978: articolo di Emilio Varaldo: “Perchè la Città non ha un Museo”?
23/10/1979: nasce il Museo Navale in sede” precaria” nelle sale dell' ex Liceo Scientifico”.
12/01/1980: “Finalmente “sì“ ( conferma) della Giunta al Museo Navale”.
8/5/1980: nasce l'Associazione Amici del Museo Navale” (Not. Donato).
19/5/1981: visita del Sen. Taviani che plaude all'iniziativa e fa pervenire al Museo tutti volumi della “Colombiana” del Poligrafico dello Stato.
1984/1985: Museo sulla copertina elenco Telefonico SIP.
1992: il Museo Navale presente all'Expo delle Colombiane.
1992: proposta dall' Associazione A.M. per la nuova sede agli ex Magazzini Generali.
23/1/1992: Ass.Nattero: “Museo Navale presto trasferito nei docks portuali”.
20/12/1998: Consigliere P. Denegri : “Nuova sede tra due anni”.
9/6/1999: approvato il progetto trasloco.
11/6/1999: ottenuta concessione demaniale dell'area (ex Magazzini portuali).
25/3/2002: Il Piano Regolatore Portuale (Regione Liguria) destina il complesso di edifici a sede museale.
19/10/2002 : Assessore Baudena espone il progetto del Planetario da inserire nel Museo.
2003: Sindaco Sappa espone i progetti per il 2003 (Museo Navale e Depuratore).
19/11/2004: Sindaco Sappa espone progetto per Palasport e Museo Navale.
28/5/2005: Ass re.Gaggero presenta la pratica “Museo” alla Conferenza dei Servizi.
19/8/2005: Sindaco Sappa dichiara “appalti e lavori di ristrutturazione palazzine entro l'anno”!
20/5/2008: pagato il restauro di “Luna Rossa” (Sovrintendenza) da conservare nel Museo Navale
luglio 2008: termine 1° lotto lavori.
settembre 2008: prime visite ai locali del futuro Museo durante le Vele d' Epoca (Mostra antiquariato). I giornali parlano arbitrariamente di inaugurazione del Museo Navale!
30/9/2009: piove dentro la nuova sede con tetto nuovo!
17/3/2010: Ass.re Gaggero e P. Strescino: “apertura ancora lontana”.
10/5/2010: Ass.re Baudena: “a settembre taglio del nastro”!
1/8/2010: Flavio Serafini: “Nuova sede già vecchia!”
3/9/2010: Protesta delle Associazioni culturali Imperiesi per i ritardi.
25/11/2010: Strescino: comunica: “un milione di euro per il Planetario”.
giugno 2012: scafo di “Luna Rossa” in completo abbandono sullo spiazzo esterno.
26/4/2012: Strescino: “Il Museo aprirà entro il 2013”.
26/4/2013: prestito cimeli del “Rex” alla Mostra di Genova.
23/11/2013: appalto vetrine di tutta l'area a cura della Sovrintendenza. Inadeguate e fuori misura. quelle dell'area di ponente. Contestazione sul loro collaudo.
13/4/2014: Com.te Serafini: “Luna Rossa”, uno scandalo per tutta la Città. Lo scafo viene ritirato da Prada a seguito della promessa inevasa del Sindaco.
18/4/2014: Ass.re Sara Serafini: ripresa dei lavori 2° lotto.
8/7/2015: Sindaco Strescino: “il Museo del futuro, apertura prevista nel 2016”.
24/4/2016: Ass.re Podestà: “Il Planetario dovrebbe essere completato entro l'anno”.
12/8/2016: inizio trasloco reperti “fai da te” con i mezzi privati della Associazione A.M.
16/9/2016: Serafini: richiesta al Sindaco Capacci per il rifacimento completo del tetto nuovo. Piove nelle sale!
3/1/2017: scadono i termini per l'appalto del Planetario.
31/1/2017: apertura ufficiale ed inaugurazione dell'area di levante. Grazie al lavoro ed ai traslochi dell'Associazione A.M. evitata all'ultimo giorno la restituzione dei fondi assegnati.
23/4/2019: Ass.re Roggero presenta il nuovo progetto della rete museale.
settembre 2019: Ass.re Roggero comunica inizio lavori area di ponente.
ottobre 2020: Ass.re Roggero comunica l'inizio dei lavori area di ponente per 600.000 euro.
15/12/2020: Ass.re Roggero comunica l'imminente inizio dei lavori (nuovo progetto). I 600.000 euro sicuramente non basteranno per l'allestimento della Sezione “Cantieristica”, “Atelier Modellista”, “Padiglione Imbarcazioni storiche” e “Sala Mostre” ,”Sala riunioni “ per il completamento del Museo al piano terra dell' area di ponente. Alla luce dei fatti il “fundraising” non è stato sufficiente, ma va ulteriormente integrato.
febbraio 2021: inizio trasferimento di reperti dal locale interno (Deposito) all'area (storica) di ponente senza il coinvolgimento della Associazione A.M. e loro collocazione disordinata senza un criterio storico scientifico, oltre all'esposizione alla polvere di diversi modellini navali.già protetti da teche.
marzo/aprile 2021: smantellamento reperti (quadrerie e modelli) e mezzi espositivi dell'area di levante ( già operativa da fine gennaio 2017 e che tanti consensi ed ammirazione avevano sollevato dal pubblico) perchè “non in linea” con i mezzi espositivi originali, nonostante il benestare ( febbraio 2017) dei Dirigenti della Regione Liguria. Completa rimozione delle quadrerie in tutti i settori, già selezionate e disposte nel proprio contesto storico, prerogativa che può essere esercitata solo dal Comitato storico/scientifico dell'Associazione.
maggio 2021: arbitrario smantellamento Sala Idrografie/Strumenti meteo/topografici” con rilevazione di alcuni danneggiamenti alla preziosa strumentazione. Si ricordano in proposito gli art. 5 e 20 del Codice dei Beni Culturali di pubblica fruizione ( Decr. Legisl. n.° 42 del 22/1/2004) .
Con dette operazioni di smantellamento viene vanificato il lavoro di due anni ( 2015 e 2016) da parte della Associazione A.M.
giugno 2021: nessuna chiamata per continuare gli allestimenti nell'area storica! Procedono da soli?
L'Associazione A.M. è anche interessata, seppur marginalmente non essendo suo compito specifico, alla sistemazione di bookshop, caffetteria e hall di ingresso, servizi che ritiene fondamentali per una corretta gestione economico/ finanziaria del Museo. Si auspica che almeno in questo settore non vadano disperse risorse preziose.
Luglio 2021: nessuna chiamata. Agosto è passato! Direttore dei lavori, Comune, Soprintendenza si sono sempre negati al telefono!
Dicembre 2021: Museo ancora chiuso da quasi un anno! Non dovevano finire i lavori a giugno?
Praticamente allo stato attuale ed alla data odierna il Museo Navale non esiste più!
Si profila un ennesimo slittamento dell'inaugurazione finale del Museo!!! Sarebbe la quarta e non l'ultima!
20 giugno 2022 : Riapertura Museo Navale ed inaugurazione del Planetario! I locali destinati a bookshop e caffetteria sono ancora vuoti.
Dicembre 2022: Alcuni attendono ancora il trasloco dalla vecchia sede.
Gennaio 2023: il museo resta abortito e mutilato senza le più importanti sezioni legate alla storia della città: Cantieristica, Pesca, Portualistica
31 gennaio 2023: il Consiglio Comunale approva il progetto di gestione della cultura affidato a soggetti privati (partenariato)
A cura di:
Associazione Amici del Museo Navale – Associazione ex Docenti ed Allievi del Nautico IM – Collegio Capitani L.C. e D.M di Imperia – Unione Medaglie Oro L.N. - Radioamatori Imperia.
Hanno espresso la loro solidarietà:
Compartecipi e collaboratori in tutti questi anni con l'“Associazione Amici del Museo Navale” che ha creato una grande struttura culturale che onora Imperia, la Liguria e non solo, esprimiamo la nostra più viva preoccupazione sulla attuale situazione degli allestimenti ed auspichiamo che i creatori del Museo possano continuare ad operare proficuamente come per il passato.
In particolare esprimiamo la nostra solidarietà, fiducia ed incondizionato apprezzamento nell'operato della Associazione A.M. che si è sempre distinta per operosità, professionalità e competenza riconosciute anche a livello internazionale.
Condividiamo le preoccupazioni del Com.te Serafini che sono anche le nostre!
Associazione ex Docenti ed Allievi del Nautico IM – Unione Medaglie d'Oro di L.N. - Vele Storiche Viareggio – Comitato San Maurizio - Il Museo Navigante – Club Artiglio – Cantiere della Memoria SP– APSD Stella Maris IM – “Cumpagnia de l'Urivu” IM - Associazione Amici del Santuario di Montegrazie IM – Lega Navale IM – Confraternita S.S. Trinità - Zacboats - A.D.P. S. Borgo Foce IM – Federazione Italiana Barche Storiche ( FIBAS) – C.V. Ventimiglia - Collegio Naz. Cap. L.C. e D.M. Sez. IM – Fondazione Artiglio Europa – Ass. Amici del Museo della Marineria VR– Il Mare di Carta – Ipersub IM – Euro Sub DM - HDS Italia – Museo Nazionale delle Attività Subacquee RA – Yacht Club SR – “Famiia Sanremasca” SR - Ass.Docenti di Geografia Sez. IM – Museo Marinaro Tommasino Andreatta CH – Corpo Piloti LI – Lega Maestri d'Ascia e Calafati VR – Fondazione Luigi Ferraro GE – Comitato Nazionale C. Colombo GE - Decio Lucano News – ex Soci Osservatorio Astron.co IM – Collegio Nazionale Cap.L.C. e D.M. GE – Gruppo ANMI DM – Nucleo storico Fondatori Museo Navale – Radio Amatori IM – Impresa Portuale Lodovico Maresca IM – Museo del Mare Tortona – Nastro Azzurrro GE – Guardia Costiera Ausiliaria GE – Società Marittima di M. S. IM – Imperia Yacht Service – Marittima Service Group IM – Marina Uno IM – Stella Maris LI – Circolo Filatelico IM – Museo Marinaro GBono Ferrari CA – Accademia di Marina PI – Istituzione Cavalieri di S. Stefano PISA- ANMI GE- Communitas Diani - Associazione Mare Nostrum Rapallo.
La tempesta imperfetta investe il Museo Navale
Chi vuol prendere visione di uno scenario devastante può affacciarsi, sempre che ne ha facoltà, all'interno di quello che per anni è stato un Museo Navale, il primo a sorgere in città (1980) a differenza di altri che musei non sono, ma solo mostre permanenti. L'area moderna, inaugurata in pompa magna ed ufficiale il 31 gennaio 2017, di fatto non c'è più, smantellata con una operazione arbitraria e strisciante che non ha avuto testimoni oculari esterni. Che cosa è successo? Negli ultimi mesi si è ritenuto opportuno modificare, o meglio stravolgere e snaturare, senza neanche coinvolgere o chiedere un parere alla “Associazione Amici del M.N.”, il percorso museologico; praticamente mezzi espositivi e reperti, quadrerie e modelli sono stati ammassati nel Deposito da personale, manodopera generica eufemisticamente definibile non qualificata. I risultati non sono mancati: danneggiamenti di modelli navali, lesioni di vetri nelle quadrerie, ecc. Forse una maggiore accortezza decisionale (nostro avrebbe dovuto essere l'incarico della movimentazione dei reperti dal Deposito) avrebbe evitato uno scempio che lascia esterefatti e sgomenti. Per non parlare del vedere vanificato un lavoro paziente e faticoso durato due anni del Comitato scientifico interno della “Associazione A.M” delegato ad occuparsi delle varie Sezioni nelle quali è articolato il Museo. L'operazione inqualificabile è stata portata a termine solo dopo che l'Associazione è stata privata con scusanti sibilline delle chiavi di accesso al Museo. Pare che il motivo scatenante di tale improvvida iniziativa sia stata la constatazione che alcuni dei nostri mezzi espositivi (moderni e costosi dei quali dobbiamo giustificare il futuro utilizzo) non sono “in linea” con quelli originali in dotazione a nostro giudizio insufficienti per numero alla conservazione. Eravamo aperti alla discussione con proposte migliorative ed anche disponibili a snellire le esposizioni per le quali si era operato in fretta per non far perdere i fondi assegnati, salvati solo per un giorno grazie al nostro lavoro! Ci eravamo regolati anche in base all'esperienza acquisita alla Bocconi ed alla Università di Pisa e proceduto in collaborazione con l'Università e CNR di Genova. Non crediamo a eventuali suggerimenti di cattedratici, accademici o luminari che in questo specifico settore non esistono anche se presi in prestito o a pagamento. E' sufficiente ricordare come l'Amministrazione abbia coinvolto la Promo Spa di Lucca (38.000 euro) o lo Studio Filippini di Genova (24.000 euro) per venirci a raccontare come deve nascere un Museo! In questo scenario desolante rileviamo lo spostamento di alcune vetrine in siti non appropriati e l'eliminazione di tutte le quadrerie dalle pareti (peraltro già accortamente suddivise nei rispettivi settori tematici) dimenticando che le stesse costituiscono l'architrave e la ricchezza delle strutture mueseali, parlano al pubblico ed offrono suggestioni e messaggi. Con l'occasione si ricorda l'ispezione /controllo di due dirigenti della Regione Liguria che hanno avallato gli allestimenti e si sono complimentati (presente l'ing. Enrico), oltre ai commenti lusinghieri a fine visita riportati nel Libro Visitatori da centinaia di persone. In questo contesto colpisce l'assoluta mancanza di trasparenza, l'arbitrio consumato nei riguardi dell'Associazione A.M. che, ricordiamo, fino a quando non sarà ufficializzato un regolare passaggio notarile di proprietà, rimane legalmente responsabile delle collezioni. Appare evidente il tentativo di esautorare l'Associazione senza la collaborazione e presenza continua della quale il Museo non potrà andare da nessuna parte. Quanti hanno creato ed operato in quarant'anni nel Museo sono stati messi alla porta! Inevitabile il contenzioso che coinvolgerà diverse generazioni di Imperiesi e non solo, ma soprattutto le migliaia di donatori anche stranieri che saranno doverosamente presto informati sulla situazione. Anche problemi per gli allestimenti in atto, per la verità fermi da oltre sei mesi, nella zona di ponente (area storica): i reperti sono stati trasferiti con la stessa procedura e spesso fuori contesto ; solo in una occasione in presenza ci è stato concesso di illustrare la natura specifica del reperto ed indicarne la collocazione nella sala e nella vetrina interessata, mentre sarebbe stato più opportuno e logico trasferire con metodo e razionalità i reperti dai depositi e non con una precipitazione ingiustificata. Stravolta inoltre, la collocazione dei reperti nelle Sale Idrografia/Strumentazione/Topografica” e “Viaggi ed Esplorazioni Scientifiche” proprio per la mancanza assoluta di cognizioni storiche e tecniche. Anche in questo settore appaiono rilevanti i danneggiamenti alla preziosa ed unica strumentazione. Ricordiamo che si tratta sempre di reperti soggetti a vincolo e inventariati dalla Soprintendenza. Mentre gli annosi problemi del Museo appaiono tuttora irrisolti (condizionamento, apparecchiature multimediali, illuminotecnica, telecamere esterne ed a circuito chiuso, pc, pavimentazione impresentabile, fabbrica industriale di polvere ( vedere l'esempio del nuovo mercato a Porto Maurizio), si è pensato anche di sindacare sull'importanza della biblioteca, sicuramente tra le più importanti a livello nazionale che non solo è indispensabile agli operatori museali, ma anche a ricercatori, storici, laureandi, ecc.
Mancano sempre gli allestimenti essenziali di due sale (“Portualistica“ e “Pesca”) nell'area disponibile degli ex uffici Salso: una significativa serie di reperti che resta tuttora in Deposito. Con queste premesse si finirà per creare un museo abortito o mutilato. Il mondo, i media devono valutare quanto il mancato rapportarsi all'esperienza ed alla competenza del gruppo di esperti che ha ideato e creato l'Istituzione, possa danneggiare l'immagine della Città e come siano da evitare le decisioni di singoli a scapito di quelle collegiali e condivise su un patrimonio culturale che appartiene a tutta la collettività, alla sua storia e tradizioni.
ENTRIAMO NEL MUSEO
Il museo, nato nel 1980 per iniziativa del comandante Flavio Serafini, si articolava in 14 sezioni che custodiscono un prezioso patrimonio di testimonianze delle tradizioni marinare liguri e nazionali dal XVIII al XX secolo. Vi si trovano una ricca collezione di strumenti di bordo, materiali e attrezzi relativi alla tradizione cantieristica in legno e ai suoi uomini, dipinti marinari, ex-voto, uniformi. Notevole è l'aspetto modellistico, mercantile e militare, arricchito da diorami e dai modelli di Léon Perret, artista e modellista, vissuto tra XIX e XX secolo, al quale è dedicata una sala. Particolare risalto viene dato a materiali e cimeli riguardanti la navigazione velica oceanica e all'impresa più bramata dai navigatori: il doppiaggio di Capo Horn.
Tra gli strumenti esposti, sono da segnalare alcuni cimeli legati alla letteratura e al viaggio quali la bussola del veliero Narcissus su cui fu imbarcato Joseph Conrad, che ad esso dedicò il romanzo "The nigger of the Narcissus", il sestante tascabile di Giacomo Bove, oggetti personali, indumenti polari, diari, documenti di bordo, della "Tenda Rossa" dove trovarono rifugio i membri della sfortunata spedizione polare del Dirigibile "Italia". Una sezione è dedicata ai mezzi e agli strumenti della ricerca archeologica sottomarina e alla palombaristica.
La visita è arricchita da un allestimento multimediale e da un percorso di postazioni didattiche, che garantiscono un'esperienza in prima persona, con simulazioni di navigazione e quattro percorsi tematici: Il lavoro sul mare, Il viaggio per mare, La guerra sul mare, Il mare come evasione.
Il Museo Navale di Imperia svela i segreti della “Città dei Marinai”
Noto anche come la "Città dei Marinai", il museo presenta un'esposizione modernissima che occupa uno spazio di circa 9.000 metri quadri.
Il 30 gennaio 2017 a Borgo Marina di Imperia, in via Scarincio 9, presso gli ex magazzini generali di Calata Anselmi, è stata inaugurata la nuova sede del nuovo Museo Navale, noto anche come “La Città dei Marinai”. L’esposizione modernissima, che va a sostituire i vetusti locali destinati al museo navale, occupa 9.000 metri quadri di spazio in quello che attualmente è un “work in progress”, un museo in divenire del quale si possono intuire pregi odierni e potenzialità future.
Imbarcazioni d’epoca reali o rappresentate in accurati modelli, attrezzature navali, divise, ricostruzioni di ambienti marinari, fotografie e quadri si susseguono nelle sale nuovissime, nelle quali sono presenti anche delle installazioni multimediali interattive che permettono di simulare una navigazione al timone o una battaglia navale al periscopio di un sottomarino.
Una particolare visione è data al passato marinaro di Imperia, in una narrazione del legame complesso fra l’uomo e il mare e delle imprese eroiche vissute. Quattro i percorsi tematici: il lavoro, il viaggio, la guerra sul mare e il mare come evasione.
La visita inizia con la sala dedicata ai dolia, gli imponenti recipienti per il vino utilizzati tra il I° secolo a.C. e il II° secolo d.C., che danno mostra di sé in un ambiente a loro dedicato che rimembra il fondo marino e la scoperta, avvenuta nel 1975 nelle acque prospicienti Diano Marina, ad opera dell’archeologo Nino Lamboglia, fondatore dell’archeologia subacquea.
Al primo piano, veramente affascinanti sono le sezioni dedicate ai palombari e al loro difficile e pericoloso lavoro e a Luigi Ferraro, medaglia d’oro al valor militare e pioniere della subacquea ricreativa italiana, con i primi corsi di immersione e la creazione della Technisub. C’è poi la plancia della motonave Sestriere con la storia dei migranti, la plancia della motonave Doria, la palestra della vela, la sala dedicata al Santuario dei Cetacei e la macchina del vento.
Particolarmente importante per gli appassionati storici è la parte dedicata alla subacquea militare e al famoso sommergibile Scirè, del quale è qui conservato il portello di poppa. Si tratta del mezzo subacqueo italiano più famoso, il terrore della marina inglese nel Mediterraneo durante la Seconda guerra mondiale.
Era il sommergibile d’appoggio degli incursori della Regia Marina, che compirono l’impresa di Alessandria violando il porto egiziano e danneggiando le corazzate britanniche Valiant e Queen Elizabeth, oltre ad una nave cisterna e ad un cacciatorpediniere. Individuato grazie alla decrittazione di Enigma, gli venne preparata un’imboscata davanti al porto, allora britannico, di Haifa, nella quale non sopravvisse alcun marinaio italiano.
All’interno del museo si trova anche un auditorium dotato di maxischermo che ospita eventi di carattere culturale ed è in seguito diventato Teatro del Mare, con un cartellone ricco di serate ed artisti differenti. Il museo navale di Imperia è aperto il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì e sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30.
"Durante la piena stagione estiva, nei mesi di luglio ed agosto, oltre al martedì mattina il museo rimane aperto il giovedì, venerdì e sabato sera dalle 18.30 alle 22.30. Biglietti di ingresso interi 7€, ridotti 3,50€, scuole 3€ con un ingresso gratuito ogni 15 persone. Per informazioni museonavale@comune.imperia.it, tel. 0183 651363".
Paolo Ponga
FOTOGALLERY
IL LATO NORD DEL MUSEO

Un angolo della Battaglia dell'Atlantico con il ricordo dell'unica nave italiana “SESTRIERE” presente in tre convogli.

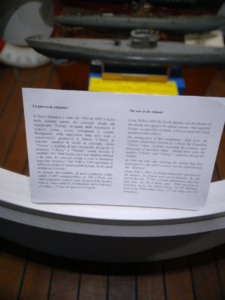
TIMONERIA E SALA RADIO DELLA M/N SESTRIERE


SEZIONE PALOMBARISTICA
NAVE RECUPERI ARTIGLIO
SORIMA
UN ANGOLO DEDICATO ALLE MEDAGLIE D’ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE


LA SEZIONE PALOMBARI



CAMERA DI DECOMPRESSIONE MONO USO


POMPA DI PALOMBARO E GUIDE AL LAVORO

CAMERA DI DECOMPRESSIONE PROFESSIONALE

DUE SCHERMI CON FILM ORIGINALI CHE RICORDANO IL LAVORO DELL’ARTIGLIO

PORTELLO DFI POPPA DEL SOMMERGIBILE SCIRE’ AFFONDATO NELLE ACQUE DI HAIFA

INIZIO DELL’AREA STORICA

LA GALLERIA D’INGRESSO COME SI PRESENTAVA ALL’INIZIO DEGLI ALLESTIMENTI

L’ANGOLO DEI SOMMERGIBILISTI

LA SEZIONE UNIFORMOLOGICA - I PILOTI DELLA MARINA

UNO SCORCIO DELLE VARIE UNIFORMI

SEZIONE MARINA MILITARE

GIACCA BIANCA ORDINARIA ESTIVA DELL’AMMIRAGLIO ANTONIO LEGNANI E MEDAGLIERE

GLI OPERATORI GAMMA DELLA X-MAS CON LE ATTREZZATURE DELLA MEDAGLIA D'ORO LUIGI FERRARO


REPERTI DELLA NAVE PASSEGGERI STOCKHOLM

TELESCRIVENTE E BUSSOLA NORMALE DI CONTROPLANCIA DELLA STOCKHOLM


MODELLO DELLA M/n GIULIO CESARE
SEZIONE TRANSATLANTICI


STOVIGLIERIE DI BORDO

SIMULATORI DI MANOVRA
TELEGRAFO DI MACCHINA
(TIMONERIA M/N SESTRIERE)



SIMULATORE DIDATTICO DI NAVIGAZIONE A VELA


UNO SCORCIO DELL’AREA STORICA LATO PONENTE

SEZIONE CAPO HORN
UN ALBATROS DELLE BASSE LATITUDINI

Sezione "Yachting"
"una parte della raccolta di guidoni di Yacht Club di tutto il mondo"

VARII ASPETTI DELLA SALA DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
(SALA NINO LAMBOGLIA)


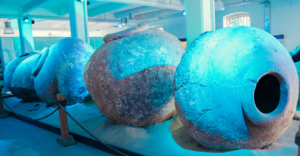





SEZIONE EX VOTO MARINARI

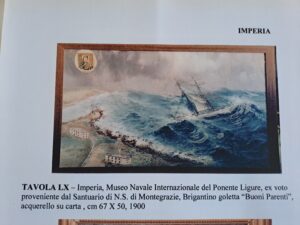
SEZIONE EX VOTO MARINARI

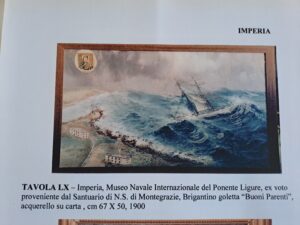
SEZIONE NAVI A PROPULSIONE A PALE

1 - Endeavour 1768 - Realizzata nel 2004 - dimensioni 76 x 31 x 53h;

2 - Savannah - 1819 - dimensioni 98 x 46 x 78h;

3 - Hope - 1864 - Realizzata nel 1995 - dimensioni 110 x 35 x 52h

4 - Stabia -1861 - Realizzata nel 2002 - dimensioni 70 x 27 x 46h;

5 - Gulnara - 1832 - Realizzata nel 1977 - dimensioni 116 x 38 x 70;

6 - Guiscardo - 1842 - Realizzata nel 2001 - dimensioni 83 x 29 x 5h

7 - Cotre - 1815 - Realizzata nel 1974 - dimensioni 106 x 56 x 90h;

8 - Sphinx - 1845 - Realizzata nel 1975 - dimensioni 75 x 25 x 47h;

9 - Mississipi - 1841 - Realizzata nel 1988 - dimensioni 120 x 41 x 74h;

10 - L'Orenoque - 1848 - Realizzata nel 1979 - dimensioni 106 x 31 x 57h;

Ad Imperia l’inizio dell’estate 2022 coincide con la riapertura al pubblico del Museo Navale, completamente rinnovato all’esterno e riorganizzato all’interno e con l’inaugurazione del Planetario.
VARIE TEMATICHE ILLUSTRATE DURANTE ALCUNE VISITE AL PLANETARIO

Per quanto riguarda il Museo Navale gli interventi effettuati hanno permesso l’apertura dell’ala di Ponente, la revisione e la riqualificazione del tetto e della facciata, il completamento funzionale del percorso museale, la realizzazione del nuovo ingresso lato Banchina e la predisposizione del nuovo locale caffetteria-bookshop. Completa l’offerta turistico-museale della struttura il Planetario di Imperia ospitato nella cupola, terzo in Italia per dimensioni e il più tecnologicamente avanzato. Con la sua cupola full dome, 62 posti a sedere, permetterà di viaggiare tra le stelle e conoscere meglio lo spazio con spettacoli in 2D e 3D.
https://www.riviera24.it/2022/06/inaugurato-il-planetario-di-imperia-il-piu-tecnologico-ditalia-766656/

INAUGURAZIONE DEL PLANETARIO DI IMPERIA
PADRINO IL PRIMO ASTRONAUTA ITALIANO
FRANCO MALERBA



L’ATTUALE ORARIO DI APERTURA DEL MUSEO NAVALE E QUELLO DEL PLANETARIO (SU PRENOTAZIONE) E’ IL SEGUENTE:
SABATO E DOMENICA DALLE 17.30 ALLE 21.30
I LIBRI DI FLAVIO SERAFINI
La lista non è completa
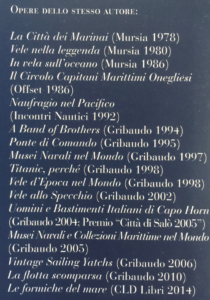
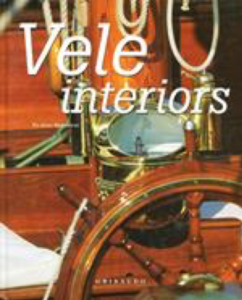


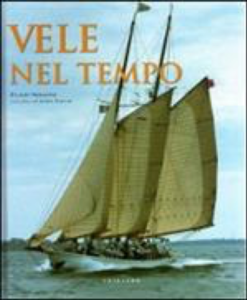


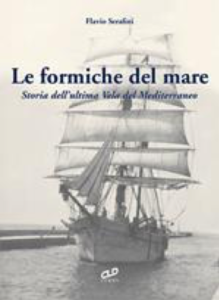

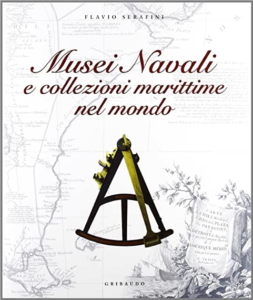
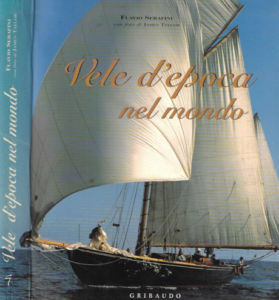
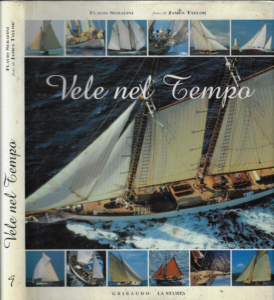

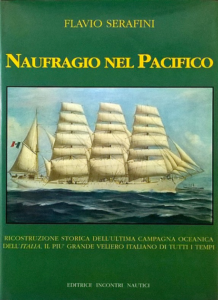
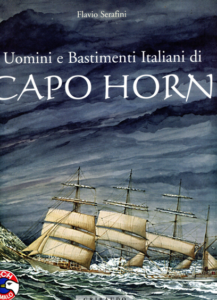
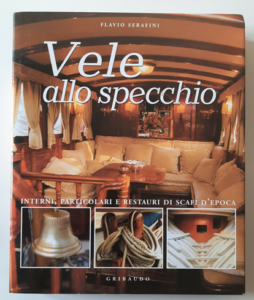
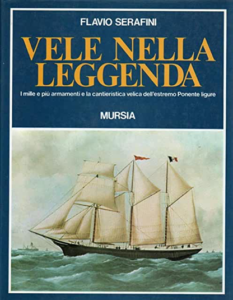
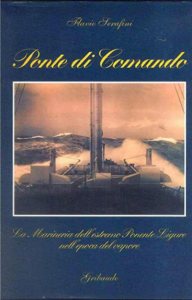
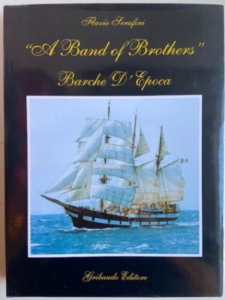
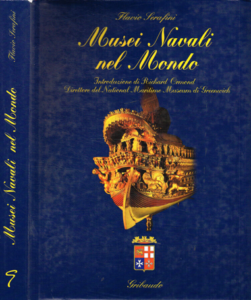
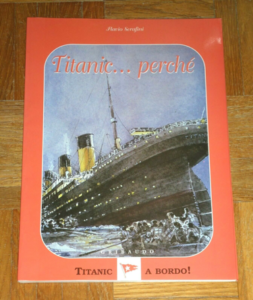
Il Comandante Flavio Serafini presenta il suo ultimo libro
'Il mio Nautico'
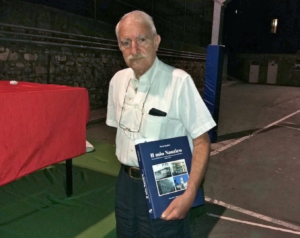
Mi complimento con il mio caro amico Comandante Flavio Serafini per l'IMMENSO lavoro svolto in questi anni con indiscusse capacità manageriali, profondissima passione storica e ammirabile cultura marinara. Lo RINGRAZIO per il materiale che gentilmente ha voluto inviarmi e che qui ho riportato, purtroppo, in modo incompleto e superficiale. Spero in tal modo di stimolare la curiosità di tanti appassionati del MONDO MARINARO affinchè mettano in agenda LA VISITA GUIDATA in questo MUSEO in cui si respira anche una fresca aria di modernità.

MUSEO NAVALE E PLANETARIO DI IMPERIA
Curriculum vitae del Comandante Flavio SERAFINI
Flavio SERAFINI, nato a Rodi (ex Colonia Italiana dell’Egeo) il 4 Novembre 1940
Residente in Corso Roosevelt n° 33 – 18100 Imperia ; tel: 0183/64550 –
cell. + 3356399861
E mail : flavioserafini2017@gmail.com
Diplomato Capitano di Lungo Corso nel 1961 presso l’Istituto Nautico di Imperia. Imbarchi nei periodi estivi su petroliere, navi da carico.
Corsi Accademia Navale Livorno 1961/62/64.
Medaglia di Lunga Navigazione (Argento) per imbarchi su navi mercantili e militari, idrografiche e da pesca, nei vari gradi ed incarichi sino a quello di Comandante.
Capitano di Fregata in Spe della Marina Militare dopo incarichi su vari tipi di navi (motosiluranti, motocannoniere, corvette, ct lanciamissili, fregate, navi logistiche e sedi di Comandi Divisione, navi idrografiche, ecc
Ultimo encomio, a bordo della Nave “Cavezzale” in occasione della ricerca e recupero dell’ “Ercules” inglese inabissatosi nei pressi della Meloria) .
Navigazione a vela in campagna oceanica sulla Nave Scuola A. Vespucci.
Abilitato in Telecomunicazioni, Idrografia e Oceanografia: Capo Reparto, per quattro anni, dopo l’ultimo imbarco sulla Nave Idrografica “Ammiraglio Magnaghi”, della Divisione “Documenti Nautici” presso l’Istituto Idrografico della Marina (GE), con alle dipendenze tecnici, impiegati ed operai civili qualificati, oltre al personale militare.
Iscritto all’A.N.M.I. di Diano Marina e socio aderente del Nastro Azzurro di Imperia
-
Fondatore e Membro della Sezione Imperiese del Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina.
-
Fondatore e Presidente della “Associazione Amici del Museo Navale” di Imperia.
-
Fondatore della Associazione “Amici del Santuario “Marinaro” di Montegrazie”.
-
Fondatore della Associazione “Ex Allievi e Docenti del Nautico di Imperia.
-
Ideatore e Cofondatore della ”Cumpagnia de l'Urivu.”
-
Segretario dal 1986 dell’Unione Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione della Sezione di Imperia.
-
Membro della Commissione di esami per il conseguimento della Patente e Patentino di Capitani di L.C. presso la Direzione Marittima di Genova e del Patentino “radar” presso l’Istituto Guglielmo Marconi di Genova sino al 1983.
-
Articolista su varie Riviste di Storia Marittima.
-
Docente di “Teoria della nave” all’Istituto Nautico di Imperia, a.s. 1983/84
-
Storico della vela e della navigazione, ha scritto volumi che hanno riscosso successo anche all’estero ed alcuni tradotti in varie lingue:
“LA CITTA’ DEI MARINAI” - “ VELE NELLA LEGGENDA” - “PONTE DI COMANDO” -
“IN VELA SULL’OCEANO” - “NAUFRAGIO NEL PACIFICO” - “A BAND OF BROTHERS” – “ VELE D’EPOCA A IMPERIA” - “IL CIRCOLO CAPITANI MARITTIMI ONEGLIESI” - “MUSEI NAVALI NEL MONDO” - “TITANIC, PERCHE’ ?” - “UN SECOLO DI YACHTING” - “VELE D’EPOCA NEL MONDO” - “VELE ALLO SPECCHIO” – “UOMINI E BASTIMENTI ITALIANI DI CAPO HORN” - “MUSEI NAVALI E COLLEZIONI MARITTIME NEL MONDO” - ”VINTAGE SAILING YACHTS” – “LA FLOTTA SCOMPARSA” - “LE FORMICHE DEL MARE” - “ IL MIO NAUTICO”- “ EUGENIO GHERSI UN MEDICO DI MARINA SULLE VIE DEL MONDO”.
Con i primi tre volumi l’autore ha ricostruito la Storia inedita della Marineria Imperiese degli ultimi secoli, creando le premesse per una maggiore conoscenza e visibilità della Città di Imperia nel mondo.
Con alcuni degli ultimi volumi, oggi tradotti in sette lingue, oltre ad aver contribuito alla conoscenza, alla salvaguardia ed alla diffusione della cultura delle “Vele d’Epoca”, ha ulteriormente affermato la sua Città come sede della Manifestazione.
La produzione libraria del Comandante è presente nella Congress Library di Washington, nelle Biblioteche di New York (Brooklyn) e di Londra (Greenwich).
-
Collaboratore esterno dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere di Genova che ha stampato nei suoi Annali il suo saggio “SUGLI ASPETTI STORICI E TECNICI DELLA NAVIGAZIONE VELICA A CAPO HORN”, oltre alla relazione sulla vita dell’Ammiraglio di Squadra Alfredo Viglieri.
-
Fondatore e socio di diversi Sodalizi culturali, è stato ispiratore e fondatore della “Cumpagnia dell’Urivu” , delle Associazioni: “Amici del Museo Navale”, “Associazione Ex Allievi del Nautico” di Imperia (di cui da sempre è Segretario). Socio dell’A.I.D.M.E.N. ( Associazione Italiana di Documentazione Marittima e Navale).
-
Segretario Nazionale per molti anni dell’ “AMICALE INTERNATIONALE DES CAPITANES AU LONG COURS CAP HORNIERS”, rappresentando l’Italia nei vari congressi internazionali.
-
Fondatore (nel 1980) con altri 8 volontari e Direttore del MUSEO NAVALE INTERNAZIONALE del Ponente Ligure (il primo a nascere in Città), il più visitato Museo del Ponente Ligure, contribuendo a salvare un vasto patrimonio di cimeli e memorie che unitamente ai suoi volumi ha contribuito a presentare Imperia in Italia e nel mondo. Inoltre la sua iniziativa ha dato la stura alla nascita di nuovi Musei e collezioni navali e marittime in Italia, come Ravenna, Gaeta, Carmagnola, Augusta, Tortona, Loano, Savona ed ha fondato il Museo della Marineria di Viareggio, di cui ha seguito realizzazione e l’allestimento a titolo completamente gratuito.
Il Com.te Serafini, con pochissimi mezzi ed aiuti esterni, ma tanta dedizione, amore e competenza, e soprattutto tenacia e determinazione, è riuscito a mantenere alti gli standard qualitativi tipici di un moderno museo pur sistemato inizialmente in una sede precaria bisognevole di continui interventi e controlli.
. Fa parte del Comitato Scientifico del “Premio Artiglio” e della Fondazione “Artiglio Europa” di Viareggio.
-
Ideatore e realizzatore del Monumento Mondiale al Navigante di Capo Horn ad Imperia, durante il Congresso Mondiale dei Cape Horners da lui organizzato (maggio 1983), che oggi rappresenta un sito di interesse internazionale. Detto Congresso è stato il primo evento culturale di grande respiro a coinvolgere tutta la Città. Nella stessa occasione ha inaugurato la stele a ricordo delle Medaglie d’Oro di Lunga Navigazione, Sodalizio di cui tuttora è Segretario.
-
Ha organizzato convegni e manifestazioni con l’Associazione Marinai d’Italia, come i Raduni degli ex equipaggi della R.N. Colleoni, del R.S. Barbarigo, del P.fo Artiglio e dei Mezzi d’Assalto della Marina della X Flottiglia Mas , e la sistemazione di epigrafi marmoree: una nella sede dell’Istituto Nautico di Imperia, a ricordo del Capitano di Vascello (M.O.V.M.) Umberto Novaro, Comandante dell’incrociatore Colleoni, ed una nella Piazza di Cesio, a ricordo del sommergibilista STV Ernesto De Guglielmi, caduto in Atlantico. Fondamentale è stato il suo apporto alla sistemazione di una lapide a ricordo dei Capitani Imperiesi Rossi e Gastaldi, Piloti della Spedizione dei Mille, curata dalla Associazione Ex Allievi e Docenti del Nautico di Imperia.
-
Ha contribuito allo sviluppo del “Raduno biennale delle Vele d’Epoca ” ad Imperia. Nell’ambito della stessa manifestazione ha realizzato diverse mostre tematiche ed ha partecipato a varie regate a bordo di scafi d’epoca.
-
Nessun cittadino si è mai prodigato tanto per la sua Città, sacrificando salute, tempo, interessi famigliari e personali, oltrechè finanziari.
Esperto di Musei, moltissimi dei quali visitati all’estero, in special modo quelli marittimi e navali, ha perfezionato la sua conoscenza e competenza con i seguenti Corsi frequentati:
1989 : “Microclima ed ambiente museale” (Milano)
1993 : “Management dei sistemi museali”( Università Bocconi di Milano);
1994 : “Esporre / comunicare” (Regione Piemonte);
1997 : “Comunicazioni multimediali dei Musei ” (Gradara )
1997 : “European Forum sui Musei” ( Università di Pisa-Cortona)
1998 : “Multimedialità museale” ( Università Roma Tre)
1999 : “Miniature” (Genova)”
1999 : “Un laboratorio per la didattica museale” (Roma)
2000 : “Missione Museo” (Genova)
2001 : “Management dei Musei” (Normale di Pisa)
2001 : “Museum Image” ( Arezzo)
2002 : “Il mestiere del Conservatore” (Accademia dei Fisiocratici – Siena)
2005 : “Sistemi museali “(Lucca)
Ha partecipato a decine di convegni sulla cultura navale e marittima, l’ultimo dei quali, in ordine di tempo, presso la Scuola Politecnica dell’Università di Genova ( 19/20 giugno 2014).
Nel campo della cultura marinara ha organizzato varie mostre tematiche (ex voto marinari, modellismo, “Titanic, perché?”, “carrette”,“ palombaristica”, “ cantieristica navale”, “ le navi ospedale”, sulle “polene” e sugli “uomini e bastimenti di Capo Horn” ecc.) e tenuto decine di conferenze sui temi storici, marittimi e navali in varie Città d’Italia ( e.g. 1992, Roma – Relatore al Convegno Europeo sui Musei del Mare).- Relatore al Convegno sui Musei Marittimi del Mediterraneo (Genova 2007).
Ha collaborato con il Museo Navale Internazionale di Imperia a diverse Mostre Nazionali (tra cui “Cristoforo Colombo, la Nave e il Mare” Genova 1992, Tenda e Milano) ed Internazionali e ha organizzato la famosa mostra “Memorie dall’Abisso” a Viareggio. E’ stato inoltre presente, come autore ospite, a diverse edizioni della Rassegna del Libro di Liguria a Peagna.
Sta ultimando alcuni volumi di fondamentale interesse storico, frutto di anni di ricerca e di lavoro:
“NAVI MUSEO NEL MONDO” - “LOANO SULL’OCEANO”(Nascita e morte di una grande Marineria) - “L’ULTIMA MARINA DI MUSSOLINI” - “SOS – S/S MAFALDA” - “GLI STRUMENTI DI MARINA” - “GUIDA AL MUSEO NAVALE INTERNAZIONALE DI IMPERIA” (con la dott.ssa Sara Serafini) – “EX VOTO MARINARI SULLE COSTE D’ITALIA”-
“ SESTRIERE, STORIA DI UNA NAVE FAMOSA.”
E, di interesse locale, sono in preparazione: “ STORIA DEI CANTIERI NAVALI TERRIZZANO” – “BARTOLOMEO BOSSI, IL NAVIGATORE DEI MARI DEL SUD”.
Ha sempre curato le “Public Relations”, la programmazione e l’organizzazione del lavoro, perseguendo tenacemente i propri obiettivi nel pieno rispetto delle capacità individuali dei collaboratori.
Appassionato bibliofilo (la sua biblioteca conta oltre 10.000 volumi), sposato con la Prof.ssa Liliana Lupi, ha una figlia, Sara, docente di Storia dell’arte, con laurea a Pisa e Dottorato di Ricerca presso l’Università di Genova.
.
Dal 1980 è stato socio del Rotary Club di Imperia , dove ha ricoperto vari incarichi (Consigliere, Segretario). Presidente per l’anno rotariano 2003/2004. Assegnata la Paul Harris Fellow. nel 2004.
Associato nel 2004 all’Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa.
Ha ricevuto nel corso del 2004 l’incarico di Consulente per la realizzazione del Museo del Mare di Viareggio di cui è stato il fondatore e l’organizzatore. E’ stato ultimamente contattato per la nascita di un similare Museo nella Città di Varazze e per il Museo delle Tecnologie portuali di Livorno.
Insignito nel maggio 1985 della “Medaille pour le Mèrite Maritime” dalla Marina Mercantile Francese.
Fra i vari riconoscimenti si ricordano:
1972 : “Targa Città di Imperia”
1980 : Premio “Amico del Mare” della L.N.I. di Imperia
1990 : Premio “Parasio” per la Cultura
1997 : Benemerenza della Città di Pietra Ligure
1997 : 9° Premio del Mare “Città di Fiumicino”
2001 : Targa delle M.O.L.N. di Viareggio come interprete della Cultura
Marinara
2004 : Casinò di Sanremo: menzione speciale Premio “Libro del mare”
2005 : Premio “Città di Salò” per la saggistica
2005 : Premio Regione Liguria per la Cultura
2005 : Finalista al Concorso “Il libro del mare” Casinò di Sanremo
2006 : Premio “Gente di Mare 2005”- Sez.ne Cultura
2011 : Premio Giornalistico/letterario “Carlo Marincovich”al Circolo Ufficiali di Marina di Roma
2011 : Targa speciale de “La Nazione”2011 (24 settembre)
2011 : Premio “Gente di Mare “ di Viareggio per il volume “La Flotta scomparsa”
2014 : Premio “Una vita dedicata al mare” (Accademia di Marina, Pisa)
2022 : Premio “Fondazione Artiglio Europa”(Viareggio)
2022 : Targa del Comune di Viareggio
In sintesi:
Profondamente innamorato della sua professione e del “ mondo della nave”, ha speso tutta una vita (a bordo ed a terra) per la salvaguardia del patrimonio marittimo nazionale, sollecitando enti pubblici e privati alla conservazione ed alla valorizzazione di documenti e reperti navali e marittimi di ogni epoca.
Ritenuto uno dei più conosciuti studiosi di Marineria, la Rivista Marittima (dicembre 2001) in un articolo sul Museo Navale Internazionale di Imperia, l’Ammiraglio Francesco Pascazio così si esprimeva:
“… Non è merito da poco per Flavio Serafini, che ha reso ciò possibile con un’opera diuturna e appassionata, contribuendo, dopo una vita spesa in mare, anche con i suoi libri e la sua attività alla diffusione della cultura marinara nel nostro Paese.”
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Imperia, novembre 2022
A cura di Carlo GATTI
Rapallo, 14 Marzo 2023
BRUNO DI LORENZI - EROE RAPALLESE
BRUNO DI LORENZI
EROE RAPALLESE



Targa commemorativa posta all’ingresso del molo al centro della passeggiata a mare che ricorda
BRUNO DI LORENZI
Un grande Rapallino marinaio e palombaro (inserito in un nucleo speciale di nuotatori d’assalto
denominato GRUPPO GAMMA, che durante la seconda guerra mondiale si distinse al punto da
essere decorato con Medaglia d’argento al valore militare per le sue azioni di
sabotaggio ed affondamento di navi nemiche nel porto di Gibilterra.
“OPERATORI GAMMA TUTTI RIENTRATI – MISSIONE COMPIUTA”
STORIA > II GUERRA MONDIALE

La trasmissione cifrata giunge, attesissima, la mattina del 14 luglio 1941, al comando supremo della Xª Flottiglia MAS: la base navale inglese di Gibilterra era stata violata!
L’Operazione "GG1", questo il nome in codice dell'ardita missione, parte da lontano, dato che per eludere l'agguerrito spionaggio inglese e la possibile fuga di informazioni da parte di Supermarina, il comando della Xª MAS prepara la nuova ambiziosa missione in modo perfetto, depistando tutte le possibili fonti di delazione.
Si sta preparando, infatti, un nuovo e rivoluzionario metodo di attacco, addirittura differente da quelli già micidiali ed irridenti ai quali l’Italia ha fatto amaramente “abituare”, ob torto collo, i furenti comandi inglesi.
Una nuova unità della Flottiglia, denominata “Gruppo Gamma” e formata da atleti incredibili che univano allo spiccatissimo animo patriottico, un fisico e temperamento eccezionali, secondi unicamente al proprio insuperabile coraggio, era pronta ad assestare un nuovo - durissimo - colpo, al prestigio ed al morale della potente marina reale britannica.
Il 14 giugno 1941, tra i 60 sottufficiali e marinai inviati, come da routine, alla base sommergibili atlantica BETASOM di Bordeaux, si infiltrano una parte degli operatori Gamma, destinati all’Operazione GG1. Dopo alcuni giorni, il 23 giugno, questi senza farsi notare ed indossati abiti borghesi, si dileguano dalla base, raggiungendo dopo qualche giorno e con una perfetta operazione di infiltrazione segreta, durante la quale percorsero anche lunghissime tratte a piedi, in pieno territorio spagnolo, la meta di partenza dell’ardita ed ambiziosa missione.
La distanza dell’obiettivo della rada di Gibilterra dalla base segreta ricavata nelle stive di Nave Olterra, internata ed ormeggiata in territorio spagnolo, era notevole anche per le eccezionali capacità atletiche degli operatori Gamma, cosicché si decise di preparare un piano di attacco alternativo.
Un paio di mesi prima, una coppia di italiani – i coniugi Ramognino - che avevano lasciato intendere agli spagnoli di aver voglia di scampare alla guerra, aveva preso in affitto una casa sulla costa, proprio nei pressi di Gibilterra: Villa Carmela.
Le squadre di attacco del "Gruppo Gamma", i cui operatori provenivano da varie direzioni, alcuni dopo aver sostato a Cadice, altri a Madrid e dopo un breve passaggio dalle segrete stive dell’Olterra, giunsero finalmente in località La Linea. Qui, si nascosero proprio a Villa Carmela, ove nel frattempo i servizi logistici della Flottiglia avevano fatto giungere, in gran segreto, le semplici ma micidiali attrezzature d’attacco.
Beh! Raccontata così sembra già difficile, per non dire impossibile, figuriamoci compierla una missione così articolata! Siamo certi che lo scrittore britannico Fleming, per le avventurose storie inventate per il suo famoso "007", abbia attinto a piene mani dalle straordinarie operazioni sotto copertura dei micidiali uomini della Decima MAS. Con una sola differenza: quelle di James Bond erano frutto di pura fantasia; le altre, invece, sono Storia divenuta meravigliosa Leggenda.
Al calar delle tenebre della sera del 13 luglio, inizia tra mille incognite la delicata fase dell’attacco.
La nuova e rivoluzionaria squadra di assalto italiana, composta da ben 12 straordinari marinai appartenenti al Gruppo "GAMMA", nuova arma segreta della più micidiale unità di assalto subacquea di tutti i tempi - la Xª Flottiglia MAS - eludono, a nuoto, tutte le difese e le ostruzioni disseminate attorno alla super protetta e strategica base navale inglese.
Nuotando faticosamente tra le fortissime correnti provenienti dall'oceano, per interminabili ore, con durissime fasi di devastante apnea, armeggiano con somma perizia sotto le chiglie dei mercantili Alleati, carichi di preziosi rifornimenti. Evitando, magistralmente, le decine di sentinelle che pattugliano la rada e le numerosissime esplosioni procurate dalle micidiali bombe di profondità, portano infine a compimento una missione perfetta.
L’esito dell’Operazione GG1 è, infatti, semplicemente straordinario.
E' da poco sorta l'alba, nella desolante ed incendiata baia di Gibilterra. La "Decima" ha appena inferto agli inglesi un duro colpo, mostrandogli un nuovo ed incredibile metodo di attacco, danneggiando pesantemente i preziosi carichi imbarcati e costringendo all'incaglio addirittura 4 navi, per un totale di ben 9.465 tonnellate.
Dalle garitte in subbuglio ed in allarme del porto inglese, più di un ufficiale britannico osserva, sconsolato e con lo sguardo perso nel vuoto, la vastità di quel mare che cela le storie e l'identità di un pugno di eroi, verso i quali risulta proprio impossibile non nutrire, misto certamente ad astio e timore, una profonda e sconfinata ammirazione.
Quella notte, tutti i 12 meravigliosi "Uomini Gamma" che si infiltrarono nelle acque molto vigilate e pattugliate antistanti la base inglese, nuotando con assurda fatica dal confinante territorio spagnolo, riuscirono addirittura anche ad esfiltrare, a missione compiuta, senza subire perdita alcuna!
Per questa eccezionale azione, tutti i magnifici 12 Uomini Gamma furono decorati di Medaglia d'Argento al Valor Militare.
Ecco, ad imperitura memoria di sommo coraggio e puro patriottismo, i loro nomi:
Agostino STRAULINO
Giorgio BAUCER
Alfredo SCHIAVONI
Alessandro BIANCHINI
Carlo DA VALLE
Giuseppe FEROLDI
Vago GIARI
Evidio BOSCOLO
Bruno DI LORENZO
Rodolfo LUGANO
Giovanni LUCCHETTI
Carlo BUCOVAZ
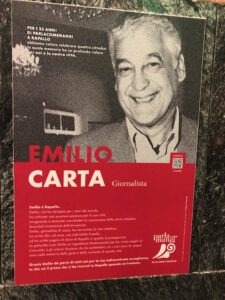
Per conoscere meglio l'eroe BRUNO DI LORENZI abbiamo scelto un altro GRANDE "rapallino" EMILIO CARTA il quale, nella PRIMA PUBBLICAZIONE (2002) di Mare Nostrum Rapallo, scelse Bruno De Lorenzi come EMBLEMA del coraggio e delle capacità natatorie della gente del TIGULLIO.

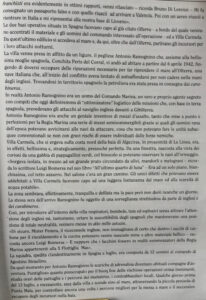
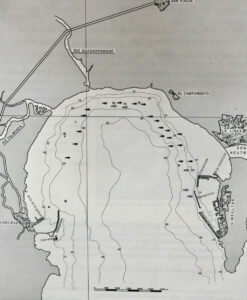

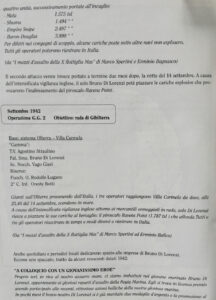

Carlo GATTI
il quale desidera aggiungere ancora alcune riflessioni e ricordi di gioventù:
Bruno de Lorenzi nacque nel 1920, compì una doppia impresa a Gibilterra nel 1943, come abbiamo appena scritto, e solo nel 2002, ultimo di una schiera di "eroi nazionali" ancora in vita, ebbe l’onore di presenziare ad una cerimonia importante come Testimonial.
Il suo essere umile “marinaio” delle NAGGE per tutta la vita lo confinò nella sua spiaggia preferita circondato soltanto dai suoi AMICI fraterni, marinai come lui, tenendosi ben distante dai riflettori della storia. Lo ricordo verso la metà degli anni ’50, ancora in gran forma, nuotare come uno squalo ed avventarsi sul pallone che poi scagliava con una forza notevole nella porta di pallanuoto (Bagni Tigullio) presidiata dal sottoscritto… Bruno era un duro! Non era facile al sorriso. Il suo sguardo non era minaccioso, ma penetrante come una lama, non era alto ma sembrava scolpito nell’acciaio.
Le persone di poche parole e di grande temperamento non hanno bisogno della pubblicità perchè non la amano proprio!
E’ stato un grande onore conoscerlo!
Rapallo 2 Marzo 2023
LAURA BASSI - ORGOGLIO ITALIANO
LAURA BASSI
ORGOGLIO ITALIANO


Grande giornata per la LAURA BASSI - la nave rompighiaccio dell’OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che nel corso della 38ª spedizione italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide - PNRA, ha toccato la Baia delle Balene: il punto più a sud mai raggiunto da una nave.
Partita da Trieste lo scorso 17 dicembre, ha solcato i mari per quaranta giorni alla volta della Nuova Zelanda ed ora del Mare di Ross. *
Complimenti a tutto l’equipaggio, che ha tagliato un altro grande traguardo per il nostro Paese.
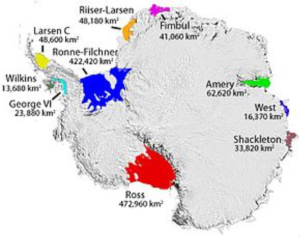
* - La baia delle Balene (in inglese Bay of Whales) è una baia antartica della dipendenza di Ross. Localizzata ad una latitudine di 78° 30' sud e ad una longitudine di 164°20' ovest, la baia si trova al limite della barriera di Ross, lungo la costa settentrionale dell'Isola Roosevelt.
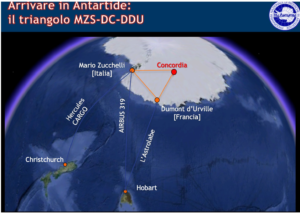

La nave rompighiaccio a metà dicembre è salpata per una missione che la condurrà nelle acque del Polo Sud, ma la campagna scientifica inizierà dal mese di Gennaio 2020, ha precisato Paola Rivaro, oceanografa dell’università di Genova e responsabile scientifica della spedizione e ha poi dichiarato: uno degli obiettivi della Spedizione è quello di studiare le acque in relazione ai cambiamenti climatici, monitorare la superficie del ghiaccio, la fusione della calotta polare e la contaminazione ambientale.

IL CHIAVARESE
RICCARDO SCIPINOTTI
Uno dei CAPI SCIENTIFICI che si sono alternati sulla nave rompighiaccio
LAURA BASSI

Riccardo Scipinotti
Also published under: R. Scipinotti
Affiliation
ENEA (Italian Agency for New Technologies Energy and Sustainable Economic Development) Research Center of Bologna, Bologna, Italy.
Publication Topics
Beverages, food safety, bioMEMS, biological techniques, chromatography, contamination, food products, hydrogen, insulation, lab-on-a-chip, microactuators, microchannel flow, microfabrication, optoelectronic devices, photodiodes, portable instruments, quality control, silicon, thermal conductivity, toxicology, photodetectors, amorphous semiconductors, elemental semiconductors, thin film sensors, DNA
Biography
Riccardo Scipinotti received the master’s degree and the Ph.D. degree in electronic engineering from the Sapienza University of Rome, Rome, Italy, in 2005 and 2009, respectively. His Ph.D. dissertation focused on the study and fabrication of a lab-on glass system for the detection and analysis of biomolecules by using thin-film technologies. He is currently a Researcher with ENEA, Italian Agency for New Technologies Energy and Sustainable Economic Development, Bologna, Italy. He is also with the Information and Communication Technologies Group, Antarctic Technical Unit, ENEA, where he is in charge to actuate the scientific research programs in the annual Italian Antarctic expedition.(Based on document published on 26 April 2018).
YOU TUBE: Interviste a Riccardo Scipinotti Capo Scientifico della Spedizione in Antartico
https://www.facebook.com/watch/?v=447454506432749
https://www.facebook.com/watch/?v=165000028143800
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2023 il SECOLO XIX
Intitolava
Due liguri a bordo della nave arrivata nel punto più a Sud mai toccato:
“Siamo nella storia”
L’emozione del chiavarese Alessio Andreani, ufficiale di navigazione. “Ho festeggiato il record con una telefonata a mia mamma"
“NOI LIGURI A DUE PASSI DAL POLO, MAMMA, SIAMO NELLA STORIA”
Da sinistra, il comandante Franco Sedmak con i liguri Diego De Nardi (al centro) e l’ufficiale chiavarese Alessio Andreani
LAURA BASSI
salpa verso l'Antartide
05/01/2023
Laura Bassi, foto di Riccardo Scipinotti PNRA
COMUNICATO STAMPA – Consiglio Nazionale DELLE RICERCHE
05/01/2023
La nave rompighiaccio italiana Laura Bassi ha lasciato il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, facendo rotta verso l’Antartide.
Inizia così la missione prevista per la 38° campagna in Antartide finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA per la pianificazione logistica e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la programmazione scientifica.
Quest’anno le attività a bordo della nave Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, si svolgeranno nell’arco di due mesi, nel corso dei quali saranno realizzate due diverse campagne oceanografiche. Durante le due tratte nel Mare di Ross, 28 tra ricercatrici e ricercatori si alterneranno per portare avanti le attività di ricerca previste nell’ambito di 8 progetti finanziati dal PNRA oltre alle attività in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare.
Il viaggio della Laura Bassi è iniziato lo scorso 17 novembre quando ha lasciato Trieste per raggiungere il porto di Ravenna e da qui, dopo aver caricato personale e materiali, ha intrapreso una navigazione di circa 40 giorni, non priva di imprevisti. Il 20 novembre la nave ha, infatti, tratto in salvo 94 migranti intercettati su un’imbarcazione alla deriva a largo delle coste greche.
A fine dicembre è approdata a Lyttelton per le attività di carico di materiale e carburante e per imbarcare il personale scientifico, in parte destinato alla Base italiana in Antartide Mario Zucchelli (MZS): più precisamente 18 containers, circa 300 mc di carburante (ISO Tanks e Bulk), un mezzo antincendio dei vigili del fuoco, 34 tecnici e ricercatori del PNRA oltre a 24 membri dell’equipaggio della nave.
Chiuse le operazioni di carico, il 5 gennaio la nave è partita dal porto di Lyttelton alla volta del Mare di Ross dove svolgerà le prime attività scientifiche fino al 15 gennaio 2023, quando la rompighiaccio arriverà alla Stazione Mario Zucchelli per lo scarico del materiale, operazioni che dureranno circa 4 giorni.
La campagna navale nell’emisfero australe prevede quest’anno una sola rotazione tra la Nuova Zelanda e l’Antartide. Le attività svolte sono state raggruppate, in base alla zona di lavoro e alla tipologia di ricerche, in due campagne oceanografiche di pari durata che hanno come punto di contatto la Stazione Mario Zucchelli (MZS).
Una pianificazione dettata dalla volontà di massimizzare i giorni di attività scientifica nel Mare di Ross, ottimizzando i consumi di carburante.
La prima campagna oceanografica (5 gennaio 2023 - 4 febbraio 2023) sarà dedicata a sette diversi progetti che prevedono: attività di lancio e recupero di boe (floating e drifter) per lo studio della circolazione marina; recupero e messa a mare dei “mooring”, ovvero sistemi di misura ancorati al fondo del mare utilizzati per lo studio di caratteristiche fisico e chimiche della colonna d’acqua; carotaggi tramite “multicorer” o “box corer” e carotaggi per lo studio geologico del fondale marino. Inoltre, ci saranno attività di pesca scientifica oltre a indagini di laboratorio biologico e chimico fisico. Verrà effettuata anche un'attività specifica legata alla mappatura del fondale marino per la realizzazione di mappe di aree ancora non cartografate. Il 4 febbraio 2023 la nave farà ritorno alla Stazione MZS per effettuare il cambio del personale scientifico, sbarcando quello che ha ultimato il suo periodo a bordo e imbarcando quello che dovrà partecipare alla seconda campagna oceanografica. Inoltre, verranno eseguite le operazioni di carico dei container da riportare in Nuova Zelanda e in Italia.
Il 6 febbraio 2023 verrà imbarcato il personale PNRA, logistico e scientifico, che opererà a bordo fino al 28 febbraio 2023 e la nave partirà per l’esecuzione della seconda campagna oceanografica nel Mare di Ross, portando a completamento le attività avviate nel corso della prima campagna ed effettuando ulteriori indagini geofisiche di sismica a riflessione.
Il rientro al porto di Lyttelton in Nuova Zelanda è previsto per il 6 marzo 2023, dopo circa 6 giorni di navigazione, mentre quello in Italia è atteso nella seconda metà di aprile 2023.
Oltre 78° gradi di latitudine Sud. E’ il record raggiunto dalla nave rompighiaccio Laura Bassi. L’equipaggio italiano in missione di ricerca in Antartide si è spinto là dove nessuno era mai arrivato a bordo di un’imbarcazione.
UN PO’ DI STORIA

M/n ITALICA
Prima della Laura Bassi, in servizio per l’Antartide vi fu una nave da carico convertita in rompighiaccio. Questa nave si chiamava ITALICA, ed è stata venduta per la demolizione nel 2017. A differenza della Laura Bassi, questa nave non nacque con l’obbiettivo di essere una nave da “supporto polare”, ma era una semplice nave da carico dotata di una prora speciale in grado di scivolare sulle banchise e di romperle con il proprio peso (vedi foto sopra).
PRIMA ANCORA….
POLAR QUEEN

23 dicembre 1985 - la nave Polar Queen raggiunge il punto prescelto per la prima base italiana in Antartide: Baia Terra Nova, propaggine estrema della Terra Vittoria. Protagonisti dell’impresa sono 42 tra ricercatori, equipaggio nave e Stato Maggiore. Tra loro Carlo Stocchino, coordinatore scientifico del CNR, Celio Vallone, capo del Progetto Antartide dell’ENEA e il generale Ezio Sterpone, responsabile della prima Spedizione nazionale.
Una penna nera tra i ghiacci e l'Italia scoprì l'Antartide
La prima spedizione italiana in Antartide partì da Genova il 27 ottobre 1985. Portò all'individuazione del sito idoneo alla realizzazione di una Base permanente a Baia Terra Nova (BTN) e all' impostazione delle prime ricerche scientifiche. Come nave appoggio e per il trasporto del personale venne usata la nave Polar Queen.
(Chi scrive ricorda d’averla messa in partenza dal Molo Vecchio Porto-Genova)
I risultati raggiunti portarono all'ammissione dell'Italia nel gruppo dei Membri Consultivi del Trattato Antartico nel corso della riunione ordinaria dell'ottobre 1987 a Rio de Janeiro. La spedizione era comandata dal generale degli Alpini Ezio Sterpone (nato a Genova il 16 febbraio 1933, tra l'altro ha comandato la Brigata Alpina «Taurinense», la Scuola Militare Alpina di Aosta e il 19° Comando Operativo Territoriale di Genova, ora Comando Reclutamento e Forze di Completamento regionale "Liguria" comandato oggi dal generale di brigata Piercorrado Meano), vi facevano parte il tenente colonnello Mauro Spreafico, l' ufficiale medico Enzo Giacomin e la guida, il maresciallo Lorenzo Boi. Responsabile Scientifico ne fu il professor Carlo Stocchino.


La nave rompighiaccio Laura Bassi
La N/R Laura Bassi è la prima nave da ricerca “rompighiaccio”. Dal 2019 è registrata e certificata in Italia per navigare nei mari polari. Da quella data, il PNRA può contare sulla disponibilità dell’unica nave italiana utilizzata per la ricerca oceanografica e il trasporto di materiali e persone in Antartide. È una rompighiaccio categoria A classe PC5 ed è stata concepita come una nave speciale combinando in maniera ottimale sia capacità cargo sia di ricerca scientifica. Ha una stazza di 4028 tonnellate, è lunga 80 metri e larga 17 metri, ha un sistema di posizionamento dinamico che le garantisce un’elevata manovrabilità e un’accuratezza di stazionamento in un prefissato punto dell’ordine di 1 metro. La struttura del fasciame, particolarmente robusta, le permette di operare in mari coperti da ghiaccio senza temere danni strutturali.
In realtà la LAURA BASSI fu costruita in Norvegia per una compagnia di navigazione norvegese. Passò di proprietà britannica e successivamente italiana. Pur essendo passata di mano due volte, è considerata una nave ancora nuova.
L’acquisto

“Ernest Shackleton”
Smantellata nel 2017 la nave Italica, nel maggio 2019, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale acquistò per 12 milioni di euro, la nave “Ernest Shackleton” della compagnia di navigazione norvegese Rieber Shipping, grazie a un finanziamento ricevuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ribattezzata “Laura Bassi”, la nave è oggi al servizio di tutta la comunità scientifica nazionale, grazie a un accordo tra i principali Enti nazionali che studiano le aree polari e ne gestiscono le infrastrutture.
CARATTERISTICHE
La nave rompighiaccio Laura Bassi vanta di essere l’unica unità italiana che rispetta le nuove regole internazionali dettate dal ‘Polar Code’ sul design, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi e sulla formazione dell’equipaggio, per la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell’ambiente.

Sala controllo
Caratteristiche tecniche· Anno di costruzione: 1995· Conforme al Polar Code· Lunghezza 80 m· Larghezza 17 m· Stazza: 4028 t· Tipo: Rompighiaccio: ICE 05 E0 – Special Purpose Ship· Posizionamento dinamico secondo livello (DP2)· Potenza installata: 5.100 kW· Velocità di crociera: 12 nodi· Combustibile: gasolio marino a bassissima percentuale di zolfo nelle casse nave e gasolio per aviazione
|
Capacità di carico e trasporto· Gru da 50 t a 10 m· Stiva da 3000 m3· Ponte di volo per elicotteri |

Gru telescopica e gru cargo
Alloggi:
-
37 cabine (da 1,2,3,4 posti)
-
22 posti per equipaggio
50 posti per personale scientifico

Le cabine
Capacità di ricerca:
-
laboratorio umido e asciutto (90m2totali)
-
ampia area di operazioni a poppa
-
gru telescopica di poppa per la messa a mare, portata 10 t
-
gru cargo su ponte di coperta, portata 5 t a 10 m
Alloggiamento per container-laboratorio con collegamento diretto all’area operazioni di poppa

Laboratorio secco
Tempo libero
-
Mensa
-
Zone ricreative
-
Lavanderia
-
Sauna
-
Palestra
-
Spogliatoi dedicati

Sala ricreativa

Infermeria


La nave fu chiamata Laura Bassi in onore della scienziata italiana che nel 1700 divenne la prima donna al mondo a ottenere una cattedra universitaria.
CHI ERA LAURA BASSI ?

Laura Bassi, nata a Bologna il 29 ottobre 1711, fu la seconda laureata d'Europa. Versata in moltissime materie (biologia, matematica, logica, filosofia, latino, greco e francese, studiate a casa), fu accolta nel 1732 all'Accademia delle scienze. Lo stesso anno discusse all'università bolognese due tesi, ottenendo una cattedra onoraria di filosofia per 500 lire annue – ma poteva insegnare solo in certe occasioni.
Famosa in tutta Europa, intraprese studi di fisica sperimentale e matematica con il medico Giuseppe Veratti, che sposò nel 1738. Con lui ebbe 8 figli e organizzò in casa un laboratorio di fisica sperimentale newtoniana e un salotto culturale, e qui dal 1749 iniziò a insegnare la disciplina a universitari, aggirando il divieto di insegnamento per le donne; l'ateneo comunque le raddoppiò lo stipendio.
Ogni anno la Bassi teneva dissertazioni all'Accademia delle Scienze sugli argomenti più svariati. Grazie alla sua autorevolezza scientifica nel 1776 le venne assegnato il posto di professore di fisica sperimentale nell'Istituto delle scienze dell'Università di Bologna.
La figura di Laura Bassi è davvero importante perché nonostante i limiti posti al suo insegnamento dalle regole dell'Università di Bologna e dal comune pensiero accademico del tempo che quasi escludeva le donne dall'insegnamento, riuscì a costruirsi una notevole carriera accademica. Ma non solo: le sue ricerche nel campo della fisica newtoniana e le sue sperimentazioni nella dinamica dei fluidi, nell'ottica e nell'elettricità, erano all'avanguardia.
Tra i suoi primi allievi ci fu Lazzaro Spallanzani, suo lontano parente: grazie all'influenza di Laura Bassi, Spallanzani abbandonò gli studi di giurisprudenza e si avvicinò prima alla fisica e poi alle scienze naturali.
La coppia Bassi-Veratti come detto animò un salotto culturale ricco di incontri e scambi filosofici e scientifici sull'onda della cultura illuministica che si stava affermando in tutta Europa. La loro casa, oltre a essere un laboratorio e a ospitare lezioni, divenne così un centro di cultura scientifico frequentato da scienziati e studenti italiani e stranieri. Grazie a questi scambi Bassi entrò in contatto con i più importanti studiosi del suo tempo, da Volta a Voltaire.
La mattina del 20 febbraio 1778 Laura Bassi morì improvvisamente. Fu onorata con solenni esequie e seppellita, rivestita con le insegne dottorali.
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Record mondiale per la nave rompighiaccio Laura Bassi

Nave Laura Bassi in Baia delle balene (Mare di Ross - Antartide) - foto Scipinotti/Ferriani©PNRA
31/01/2023
Nave Laura Bassi in Baia delle balene (Mare di Ross - Antartide) - foto Scipinotti/Ferriani©PNRA
Record mondiale assoluto per la nave rompighiaccio italiana Laura Bassi, che ha toccato il punto più a sud mai raggiunto da una nave, nel corso della campagna oceanografica della 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra).
I ricercatori e i tecnici a bordo hanno raggiunto, all’interno della Baia delle Balene, un sito ad oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280’ S, il punto più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in Antartide, per effettuare importanti campionamenti previsti nell'ambito del progetto "BIOCLEVER" (Biophysical coupling structuring the larval and juvenile fish community of the Ross Sea continental shelf: a multidisciplinary approach) coordinato dall'Istituto di scienze polari (Cnr-Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie anche alla collaborazione dell’osservatorio marino MORSea (Università Parthenope).
Le condizioni del mare, straordinariamente libero dai ghiacci, hanno consentito di effettuare una profilatura CTD e attività di pesca scientifica a ridosso del Ross Ice SHelf - RIS che in questa posizione è particolarmente basso (circa 8 metri di altezza). I primi risultati dello studio dei parametri fisici dell’acqua marina (dalla superficie fino alla profondità prossima al fondale di 216m) hanno evidenziato la presenza di acqua particolarmente fredda e si confermano di grande importanza per lo studio della dinamica delle correnti nel Mare di Ross. Inoltre, una prima analisi del materiale prelevato dai ricercatori ha evidenziato un’elevata densità di stadi larvali e giovanili di specie ittiche, evidenziando la presenza di alcune varietà raramente osservate nel Mare di Ross oltre la presenza di elevate masse di alghe unicellulari che denotano un’elevata produzione primaria e incoraggiano ulteriori ricerche.
Il viaggio della Laura Bassi è iniziato lo scorso 17 novembre quando ha lasciato Trieste per raggiungere il porto di Ravenna e da qui, dopo aver caricato personale e materiali, ha intrapreso una navigazione di circa 40 giorni, verso la Nuova Zelanda. Il 5 gennaio ha lasciato il porto di Lyttelton alla volta della Stazione Mario Zucchelli e del Mare di Ross. La nave è, infatti, attualmente impegnata nella 38° campagna in Antartide finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra), gestito dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) per la pianificazione logistica e dal Consiglio nazionale delle ricerche per la programmazione scientifica.
Quest’anno le attività a bordo della nave Laura Bassi, di proprietà dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), sono state organizzate dall’Unità Tecnica Antartide di Enea in un’unica rotazione suddividendo la campagna in due campagne oceanografiche nel Mare di Ross, intervallate dalla sosta presso la stazione Mario Zucchelli, nel corso delle quali 46 tra ricercatrici, ricercatori e tecnici complessivamente si alterneranno per portare avanti le attività di ricerca previste nell’ambito di 8 progetti finanziati dal PNRA oltre alle attività in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare.
Il record è stato raggiunto nel corso della prima campagna oceanografica dedicata a sette diversi progetti che prevedevano: attività di il lancio e recupero di boe (floating e drifter) per lo studio della circolazione marina; recupero e messa a mare dei “mooring”, ovvero sistemi di misura ancorati al fondo del mare utilizzati per lo studio di caratteristiche fisico e chimiche della colonna d’acqua; carotaggi tramite “multicorer” o “box corer” e carotaggi per lo studio geologico del fondale marino, attività di pesca scientifica e indagini di laboratorio biologico e chimico fisico. È stata anche condotta un'attività specifica legata alla mappatura del fondale marino per la realizzazione di mappe di aree ancora non cartografate in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana.
La prima campagna oceanografica si avvicina alla conclusione con il cambio di personale scientifico presso la stazione Mario Zucchelli il 4 Febbraio. Dopo le operazioni di carico del materiale e dei campioni scientifici provenienti dalle stazioni di Mario Zucchelli e Concordia, la Laura Bassi ripartirà il 7 Febbraio per la sua seconda campagna oceanografica.
Il rientro al porto di Lyttelton in Nuova Zelanda è previsto per il 6 marzo 2023, mentre quello in Italia è atteso per la seconda metà di aprile 2023.

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)
foto Lorenzo Facchin©PNRA
Ho scelto e riporto integralmente per i nostri lettori il reportage dell’inviato speciale di MONDOINTASCA essendo una meravigliosa IMMERSIONE in un clima freddo che, tuttavia, ci permette di percepire il “calore umano” e la professionalità dei nostri connazionali impegnati in una fantastica e storica avventura… che ha per obiettivo tanto lavoro di ricerca per dare risposte anche al fenomeno naturale che stiamo vivendo:
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO!

30 Gennaio 2023 alle 16:39
In Antartide con la spedizione scientifica italiana
La 38ª spedizione del Programma di ricerche in Antartide gestito da Enea e CNR è salpata dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda il 6 gennaio. A bordo della rompighiaccio Laura Bassi anche un Reporter di Mondointasca per raccontare la missione.
di Stefano Valentino
Ritorniamo dopo sei anni ai confini del mondo. Mondointasca vi porta di nuovo in Antartide per mostrarvi il lavoro degli scienziati italiani che studiano i cambiamenti climatici. Il nostro reporter, Stefano Valentino, si è imbarcato in Nuova Zelanda a bordo della rompighiaccio Laura Bassi dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste. La missione Antartide i nostri lettori la possono seguire attraverso la sezione dedicata ANTARTIDE che mostra in diretta il percorso e le tappe.
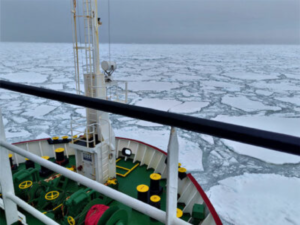
Particolare della nave italiana rompighiaccio Laura Bassi (ph. s. valentino © mondointasca.it)
È passato quasi un mese dalla nostra partenza (il 6 gennaio) dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda. Ma abbiamo smesso di contare i giorni. Nell’estate australe il sole non tramonta mai. Il viaggio della missione Antartide prosegue lungo interminabili coste imbiancate, dandoci l’impressione di restare inerti nel tempo e nello spazio. A scandire il flusso della quotidianità sono solo i pasti e le attività di ricerca. Queste ultime condotte dagli scienziati e i tecnici a bordo secondo orari concordati dal comandante Franco Sedmak, il capo spedizione Riccardo Scipinotti e Pasquale Castagno, coordinatore scientifico della campagna oceanografica.

La sconfinata banchina di ghiaccio frantumato (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Si tratta della 38a spedizione organizzata nell’ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), gestito da ENEA e CNR. Le distese di ghiaccio che ci circondano, quelle in mare e quelle sul continente, rappresentano un’incantevole immensità. I ricercatori li scompongono in elementi da studiare per cercare di capire l’evoluzione del clima terrestre. Scienza e meraviglia si fondono a ogni tappa del viaggio. La prima fermata è stata alla stazione italiana Mario Zucchelli. Seconda tappa al ghiacciaio Campbell fino a Cape Washington, non distante dalla base; poi attraverso una sterminata banchisa verso sud e infine al Ross Ice Shelf (RIS), il ghiacciaio più grande del mondo.
Missione Antartide: i fantasmi degli antichi ghiacciai
Muraglie di ghiaccio (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Come molti altri ghiacciai antartici, il RIS scende giù dal continente. Nella parte terminale si appoggia sul mare, creando una monumentale muraglia alta oltra 30 metri. La costeggiamo per giorni, inseguendo con lo sguardo a destra e sinistra la tortuosa sagoma. Vediamo che si allunga, assottiglia e opacizza fino al punto in cui l’occhio umano non riesce più a vedere. I fronti glaciali si estendevano ben oltre l’area in cui navighiamo. Dove ora c’è il blu, in epoche passate c’era solo bianco. Di fatto, attraversiamo i fantasmi degli antichi ghiacciai. Studiare la loro evoluzione è fondamentale per capire qual è stato l’impatto delle temperature. Ma anche per valutare in che misura l’effetto del riscaldamento globale potrebbe contribuire alla loro ulteriore fusione.
Missione Antatide: i cambiamenti dei fronti glaciali

Tecnici preparano gli strumenti da mettere in mare (ph. s. valentino © mondointasca.it)
“È fondamentale formulare modelli predittivi che anticipano l’entità di future fusioni glaciali″, spiega Luca Gasperini, ricercatore dell’Istituto di Scienze marine del CNR. Durante la navigazione dirige il progetto Disgeli scandagliando i fondali per individuare segni di arretramento o avanzamento delle lingue glaciali sottomarine negli ultimi 10mila anni; In pratica il periodo intercorso dall’ultima glaciazione. L’obiettivo è confrontare la variazione nel tempo dei fronti glaciali con quella dell’atmosfera intrappolata nelle carote di ghiaccio estratte sul continente col progetto Beyond Epica. Le carote di ghiaccio quest’anno saranno trasportate per la prima volta con la nave in Italia per l’avvio delle analisi.


Sonda in fase d’immersione (ph. s. valentino © mondointasca.it)
″Il raffronto ci permette di prefigurare le condizioni di CO2, e quindi di temperatura, che potrebbero innescare una fusione della calotta glaciale antartica. Fenomeno che innalzando il livello dei mari, sommergerebbe le zone costiere″, conclude Gasperini. Per determinare la variazione dei fronti glaciali vengono raccolti campioni di sedimenti che si sono depositati sui fondali marini. La raccolta avviene nei punti in cui i ghiacciai erano ancorati alla base rocciosa. Innanzitutto vengono identificati i sedimenti con un particolare strumento acustico, chiamato Topas, dopodichè la nave si arresta sopra ogni punto e con un carotiere calato in profondità vengono estratte appunto carote di sedimento, intrappolati in lunghi tubi, che vengono trasportate in Italia per essere analizzate.
Missione Antartide: il fondamentale ruolo dei venti

Ponte della nave e cabina comandi (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Le conversazioni con gli scienziati, che siano in laboratorio o nelle sale di ricreazione a prua, ci aiutano a osservare il ghiaccio con occhi diversi. Impariamo che l’Antartide non è un unico conglomerato ghiacciato che si estende dal continente al mare, ma che il ghiaccio continentale (formato dalle precipitazioni nevose) e diverso dalla banchisa galleggiante che e frutto del congelamento del mare. Comprendiamo le interazioni del ghiaccio marino con gli altri due elementi freddi, l’aria e l’acqua, che mantengono l’Antartide nel suo stato di mistica e aliena immobilità.

Stefano Valentino sulla nave rompighiaccio con la sua attrezzatura (ph. © mondointasca.it)
Mentre siamo appostati sui ballatoi esterni del ponte di comando per fotografare gli spazi metafisici che ci circondano, le nostre dita vengono spesso morse dagli artigli freddi dei cosiddetti venti catabatici. Questi venti non soffiano da nessun luogo. Semplicemente precipitano dalle alture del continente a causa della loro bassa temperatura che li rende particolarmente pesanti. Svolgono un ruolo importantissimo. Non solamente raffreddano la superficie del mare, facilitandone il congelamento, ma spazzano a largo il ghiaccio marino già formatosi, sgomberando ampie porzioni di mare dove puo creare un’ulteriore quantità di ghiaccio.
Circolazione oceanica e clima terrestre

Nave rompighiaccio Laura Bassi (ph. s. valentino © mondointasca.it)
″La formazione del ghiaccio marino e un fattore capace di influenzare il clima terrestre. Infatti, ghiacciando, l’acqua rilascia sale nelle masse d’acqua sottostanti che diventando dense e pesanti, sprofondano e fluiscono verso nord; mentre quelle calde dall’Equatore si dirigono verso i poli″, spiega Pasquale Castagno, ricercatore all’Università di Messina. A bordo è responsabile del progetto MORSea dell’Università Parthenope di Napoli”.
Aggiunge: ″queste correnti che fluiscono in direzioni opposte innescano la circolazione oceanica globale che garantisce un’equa distribuzione del calore sul globo terrestre, mantenendo le condizioni ottimali per la vita come la conosciamo″.
È stupefacente guardare il manto di ghiaccio tagliato e frantumato dalla chiglia della nave. Si percepisce mentalmente il freddo ostile delle acque sottostanti capaci di porre fine alla vita di un essere umano in pochi istante; al tempo stesso va considerato che tutto questo gelo mette in moto un meccanismo che è fonte di vita nelle zone temperate da cui proveniamo.
Missione Antartide: effetti contrapposti del ghiaccio

Montagne nel ghiaccio (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Sulla Laura Bassi, impariamo che il clima è una cosa complessa. “Il ghiaccio marino ha effetti paradossalmente contrapposti. Da una parte col suo colore bianco riflette la luce e quindi l’energia solare, impedendo il surriscaldamento del mare, dall’altra, proteggendo lo stesso mare dai venti freddi, impedisce il congelamento delle acque”, commenta il paleoclimatologo dell’Istituto di Scienze Polari del CNR. Aggiunge: “e quindi importante analizzare quest’insieme di retroazioni, come ci prefiggiamo di fare col nostro progetto Greta, al fine di comprendere in quale modo la formazione del ghiaccio marino e delle acque dense, generate dal rilascio di sale, è evoluta in passato per anticipare le dinamiche future”.

Candidi panorami ghiacciati (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Gli esploratori del passato si precipitavano in Antartide per conquistare la frontiera meridionale del mondo, il continente più irraggiungibile; l’unica terra dove la civiltà umana non ha messo radici, per poi tornarsene a casa con il loro trofeo per non pensarci più. Oggi i ricercatori vengono regolarmente qui per spiegare come il ghiaccio dell’Antartide non sia solo un affascinante archetipo della terra di nessuno, ma sia soprattutto un anello fondamentale del sistema ambientale in cui l’Uomo ha sempre vissuto.
Missione Antartide: odissea tra gli iceberg

Famiglia di Pinguini (ph. s. valentino © mondointasca.it)
Durante la nostra odissea tra gli iceberg, continuiamo ad ammirare l’Antartide dal di fuori, non ne violeremo le distese abitate, non ne raggiungeremo il cuore ambito dagli avventurieri di tutti i tempi. Noi ci accontenteremo di farne ritratti da lontano, facendo volare la nostra fantasia, accontentandoci di condividere brevi istanti a tu per tu con foche e pinguini adagiati sulle loro zattere di ghiaccio vaganti nel Mare di Ross. Siamo venuti qui a capire i misteri scientifici che si celano nelle sue acque e a portarci con noi in Italia le poche risposte ottenute dai ricercatori che, in quanto tali, offrono, il pretesto per tornare nuovamente in questi luoghi remoti in fondo alla curvatura terrestre.
Dominare la complessità dei fenomeni climatici imperniati sui ghiacci antartici sarà molto più difficile che piantare la bandierina come fecero Amundsen e Scott durante la loro eroica corsa al Polo Sud.
Info utili:
Seguite il diario di viaggio, realizzato in partnership con Green&Blue di Repubblica.it (link https://mondointasca.it/Antartide)
La spedizione giornalistica in Antartide e stata realizzata grazie all’invito del PNRA che ha ospitato Stefano Valentino a bordo della nave Laura Bassi e si e avvalsa della collaborazione con Morgana Production. Attrezzature e supporto sono state fornite da Avventure nel mondo, Telespazio, Canon e Huawei.
RINGRAZIAMENTI:
Nell'articolo ho citato le fonti ufficiali. La DIVULGAZIONE della STORIA DEL MARE è lo scopo principale della nostra ASSOCIAZIONE che non persegue scopi di lucro.
RINGRAZIO SENTITAMENTE TUTTE LE FONTI ALLE QUALI MI SONO ANCORATO....
Carlo GATTI
Rapallo, 23 Febbraio 2023
MUSEO NAVALE ROMANO - ALBENGA , LA CITTA’ DELLE 100 TORRI
MUSEO NAVALE ROMANO
ALBENGA
LA CITTA’ DELLE 100 TORRI



MUSEO DELLA NAVE ROMANA DI ALBENGA
“ ... nessuno ricorda che l’Italia ha bisogno di risorse esterne e che la vita del popolo romano è esposta ogni giorno alle incertezze del mare e delle tempeste!”
(Tacito-Ann-III,2.52)
Con queste parole risentite Tiberio fustigava in senato i lussi e gli sperperi di Roma, ricordando che invano si sarebbero cercate in patria le risorse necessarie alla sopravvivenza dei cittadini se gli alimenti di base non fossero arrivati d’oltremare. Difficilmente si potrebbe esporre meglio la dipendenza alimentare di Roma dai suoi rifornimenti via mare già nell’alto impero.
PREMESSA
Non essendo il sottoscritto un archeologo e neppure un esperto della materia, ma soltanto un appassionato di archeologia marina, in questo articolo divulgativo ho ritenuto più saggio lasciare quasi tutto lo spazio disponibile agli specialisti della materia perché ritengo che soltanto loro possano attirare nuovi proseliti verso questa affascinante disciplina. Questo almeno è quanto mi è successo molti anni fa...
Navigare il Mediterraneo però non era una passeggiata. Nonostante il Mediterraneo appaia come un bacino chiuso, il Sahara a sud e l’Oceano Atlantico a ovest provocano nei periodi di cambio stagionale variazioni meteomarine abbastanza veloci e non prevedibili senza moderni equipaggiamenti; i navigatori antichi si potevano affidare soltanto all’esperienza per prevedere il cambiamento delle condizioni atmosferiche. Tutta la navigazione si basava su un sapere tramandato di generazione in generazione; per esempio, tra le nozioni apprese dagli antichi naviganti vi era la conoscenza di venti e brezze stagionali che, insieme alle correnti, permettevano di utilizzare diverse rotte a seconda del periodo dell’anno. Il periodo meno favorevole alla navigazione era l’inverno, detto in antico “periodo del mare clausum”, quando le condizioni metereologiche erano più complicate. La grande esperienza dell’equipaggio era necessaria per navigare in buone condizioni di vento e senza copertura nuvolosa notturna che impediva di vedere le stelle utilizzate per orientarsi di notte.
Il museo, oltre al carico di anfore vinarie, provviste e attrezzature provenienti dai resti anfora di una nave romana affondata nel secolo I a.C. davanti alla costa, espone reperti archeologici di area ingauna e una collezione di vasi da farmacia dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia.

Isola Gallinara
L'isola Gallinara o isola Gallinaria (A Gainâa in ligure, Insula Gallinaria o Gailiata in latino ) è un'isola situata nei pressi della costa ligure, nella Riviera di Ponente, di fronte al comune di Albenga al quale appartiene. L'isola dista 1,5 km dalla costa, dalla quale è separata da un canale profondo in media 12 m; essa costituisce la Riserva naturale regionale dell’Isola Riserva naturale regionale dell’isola di Gallinara.
La raccolta completa del museo conserva, oltre ai ritrovamenti della nave romana, anche materiali sottomarini rinvenuti dalle diverse esplorazioni subacquee, dal 1957 in poi, nei fondali circostanti l'isola Gallinara. Nella sala detta "degli affreschi", caratterizzata dalla presenza di portali in ardesia del XVI secolo e un camino, è stata allestita la raccolta dei vasi da farmacia provenienti dall'ospedale di Albenga; la collezione comprende all'incirca un centinaio di pezzi in ceramica bianca e blu, databili tra il XVI e XIX secolo, di fabbricazione savonese e albissolese.
NINO LAMBOGLIA

Nino Lamboglia è considerato il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea, nel 1958 fondò il Centro sperimentale di archeologia marina, invitò studiosi da tutto il mondo, organizzò congressi e seminari e lavorò alla carta archeologica dei fondali, seguendo poi, tutti i ritrovamenti subacquei, dell'intera costa italiana.
La scoperta del relitto della nave romana di Albenga
Il primo scavo subacqueo in Italia
E' stata oggetto di tredici campagne di scavo subacqueo che hanno consentito di documentare gradualmente gli elementi del carico e le caratteristiche costruttive dello scafo. E' stato pure accertato che si tratta della più grande nave oneraria (nave da carico) romana conosciuta a tutt'oggi nel Mediterraneo, con un carico superiore alle 10.000 anfore, e quindi con una portata netta di 450/500 tonnellate. Le anfore contenevano vino proveniente dalla Campania destinato ai mercati della Francia meridionale e della Spagna. Insieme al vino veniva esportata la ceramica a vernice nera e altri tipi di vasellame.
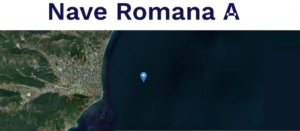
Il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa
NAVE ROMANA DI ALBENGA
La nave da carico era di grandi dimensioni, 40 metri di lunghezza.
Era il 1925 quando un pescatore del luogo, Antonio Bignone, trovò tra le sue reti alcune anfore. La scoperta destò interesse da subito, ma fu necessario attendere sino al febbraio 1950 per un primo tentativo di recupero, in quanto il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa.
Lo scavo permise altresì di individuare l’albero maestro che aveva un diametro di circa 50 cm. seguito dei risultati dello scavo fu accertato che la nave Romana d’Albenga era lunga circa 40 m., larga almeno 10 m. e le anfore trasportate dovevano essere almeno 10.000. Teniamo conto che le anfore pesano (vuote) kg 21.5, che il loro contenuto era di 26 litri, ogni anfora pesava all’incirca 45 kg., quindi la nave aveva una portata di 450 tonnellate.

Anfora del tipo Lamboglia 2
Per il tipo di anfore rinvenute sul relitto (Dressel 1b e poche anfore di forma Lamboglia 2), ed il tipo e la forma delle ceramiche rinvenute si è potuto collocare il relitto nel primo decennio del secolo I a.C.
Tra i materiali del carico sono stati recuperati 8 elmi bronzei, che potrebbero indicare la presenza di una scorta armata a bordo.
E’ ormai diventata famosa la “ruota di manovra” in piombo (del quale non ho trovato la foto) scoperta dai palombari dell’Artiglio, ancora oggi di dubbia interpretazione, ed il corno in piombo che secondo Lamboglia avrebbe fatto parte della testa di un animale che doveva decorare la prua di questa magnifica nave.

https://www.albengacorsara.it/corsara/
“La dotazione di bordo comprendeva, oltre alle stoviglie, tutto l’occorrente per provvedere alle improvvise necessità che potevano verificarsi durante la traversata. Ad esempio vi era un crogiolo in quarzo, adatto a fondere il piombo in modo da poter provvedere alle urgenti saldature e riparazioni.
Per fabbricare funi a bordo era stato installato un meccanismo che prevedeva una ruota di piombo infissa, per mezzo di un foro centrale a sezione quadrata, su una struttura lignea che ne permetteva la rotazione. Disposti a croce rispetto al foro appena citato, ve ne erano altri quattro, all’interno dei quali passavano i singoli cavi che, grazie al movimento della ruota, si attorcigliavano vicendevolmente in modo da formare cime consistenti (le ipotesi di uso riguardanti la “ruota di manovra” sono molteplici, quella illustrata è la più accreditata da parte di chi scrive).
La pirateria era molto diffusa lungo i mari italiani e il Mar Ligure gode di un’efferata fama corsara all’interno delle fonti antiche. Al fine di una difesa in caso di attacchi, vennero caricati a bordo alcuni elmi, facenti parte dell’attrezzatura per una difesa estemporanea e improvvisata, certamente non attribuibili ad una vera scorta armata militare. Per scongiurare tali infausti eventi, era parte dell’arredamento un corno in piombo, con chiaro intento apotropaico, che doveva allontanare malocchi e malefici.
Purtroppo il corno non fu sufficiente, perché la nave, salpata dalla Campania, incontrò una violenta tempesta nei pressi di un centro abitato denominato Albingaunum. Nonostante il vicino riparo del porto e un agevole approdo sull’isola Gallinara, la nave, sospinta dal vento e dal mare, si inclinò a tribordo e si inabissò. Il carico scivolò verso il lato destro e il grande peso delle anfore, circa 45kg l’una da piene, sommato all’urto contro il fondale provocò la rottura dello scafo all’altezza del ginocchio (punto di raccordo fra il fondo della nave e la murata)”.
Le anfore
Sulle navi lo stivaggio delle anfore avveniva impilandole le une sulle altre con un sistema “a scacchiera”, in modo che quelle dello strato superiore si inserissero fra tre colli delle anfore sottostanti. I contenitori si adeguavano alla forma della carena e venivano fissati e protetti dagli urti con ramaglie di ginepro, di erica, giunchi, paglia ed altro.
Le anfore venivano fabbricate nelle regioni di produzione delle merci, con forme diverse a seconda della provenienza, della cronologia e del contenuto. In età romana circolavano in tutto il Mediterraneo, spingendosi fino alla Britannia e al Bosforo, testimoniando l’unificazione commerciale, oltre che politica, dell’impero.
Il primo a comprendere l’importanza di questi oggetti per la ricostruzione dei traffici commerciali fu Heinrich Dressel, che alla fine dell’Ottocento studiò la relazione tra le diverse forme di anfore e le iscrizioni conservate su di esse. Così Dressel gettava un ponte tra archeologia, epigrafia e storia economica. Di qui si è sviluppata una solida tradizione di studi.
Oggi si è in grado di attribuire le anfore a grandi blocchi di produzioni (italiche, galliche, iberiche, africane e orientali) e, all’interno di questi, a sempre più specifici ambiti di provenienza, riuscendo a “tracciare” i rapporti commerciali dei popoli del Mediterraneo.
SCOPRI ALBENGA.IT

Esposizione di importanti reperti recuperati dal relitto della nave oneraria romana rinvenuta nei fondali dell’Isola Gallinara: vasellame, attrezzature navali, pedine da gioco, piccoli arnesi in piombo per la pesca oltre ad un centinaio di anfore vinarie, disposte come lo erano originariamente sulla loro nave, in un’apposita rastrelliera in legno che ne riproduce il “ventre”.
A differenza delle navi da guerra, i mercantili o navi onerarie avevano uno scafo tondeggiante e robusto, adatto sia per la navigazione di cabotaggio, sia per la navigazione in mare aperto, necessaria al fine di attraversare più velocemente determinate zone nel Mediterraneo. La propulsione era unicamente a vela (sempre di tipo quadra che, opportunamente ridotta ad una forma triangolare, permetteva di risalire il vento) e nelle onerarie di maggiori dimensioni poteva essere presente un secondo albero a prua, di dimensioni minori.
Le dimensioni degli scafi potevano variare a seconda delle tipologie di trasporto in cui erano impiegate. Si distinguono: navi di piccolo tonnellaggio (inferiori ai 15 m di lunghezza) adatte alle navigazioni di breve durata, navi di medio tonnellaggio (tra 15 e 30 m) impiegate sia per le rotte lungo costa che per tratti in mare aperto e navi di grande tonnellaggio (sopra i 30 m di lunghezza) che facevano parte della flotta dell’Annona e rifornivano principalmente la capitale.
Nota da ROMANO IMPERO:
ANNONA: Prese il nome di Annona il raccolto di grano di un'annata (annus), poi, gradualmente, ogni altra derrata prodotta da un territorio in un anno.
In seguito si intese con questo nome l'insieme dei prodotti agricoli raccolti in un anno per l'approvvigionamento di una città o di uno Stato.
Vi si aggiunse poi anche il magazzino adibito al deposito dei prodotti e l'ufficio che vi sovrintendeva.
I mercantili possedevano un ponte su cui si muoveva l’equipaggio e potevano trasportare passeggeri (non esistevano navi da trasporto passeggeri per lunghi tratti, ma si viaggiava insieme alle merci). Al di sotto del ponte era presente una stiva in cui venivano sistemati i carichi che potevano essere eterogenei o omogenei (nel caso di navi usate solo per il trasporto di grano o olio). Il principale contenitore da trasporto erano le anfore, ma si potevano utilizzare anche i dolia di grandi dimensioni per il vino, sacchi per il grano, cassette lignee e altro.

DOLIA
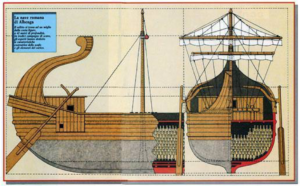
NAVE ROMANA DI ALBENGA

Anfora tipo Dressel 1B
La stiva veniva colmata con anfore vinarie di produzione italica-campana, le Dressel 1B, alte poco più di un metro e caratterizzate per un orlo ripiegato esternamente per formare un colletto leggermente sfasato verso il basso, impostato sul collo, di lunghezza variabile, che termina in una spalla un po’ spigolosa. La pancia poteva essere pronunciata o longilinea. All’estremità inferiore delle anfore si trova un alto puntale, necessario per permettere l’impilamento. All’interno della nave ne furono caricate fino a dieci mila, disposte su cinque strati sovrapposti, con il puntale dell’anfora superiore trattenuto tra i colli delle inferiori. Sfruttando tali incastri il mercante era certo che, anche in presenza di turbolenze, i contenitori non si sarebbero rovesciati e infranti, spargendo il loro prezioso contenuto. Ulteriore accorgimento per evitare la dispersione del vino era costituito dalla chiusura ermetica dell’imboccatura dell’anfora. Il collo veniva sigillato incastrandovi un tappo di sughero, spesso ben 7 cm, bloccato da uno strato di malta e calce. L’estrema sigillatura del collo era data dall’inserimento di una pigna verde che, con il passare del tempo, si sarebbe seccata e aperta a ventaglio. Quest’ultimo espediente poteva avere una duplice funzione, la prima era quella di aromatizzare il contenuto dell’anfora, e la seconda, più pratica, di facilitare la rimozione del tappo. La pigna infatti, grazie alle sue asperità, avrebbe creato dei luoghi di appiglio per incastrarvi due leve che permettessero di applicare la forza necessaria a rimuovere l’intero tappo. Invece, per preservare le proprietà organolettiche del contenuto da commistioni esterne, l’intera superficie porosa dell’anfora fu ricoperta di uno spesso strato di resina o pece.


Legato al nome dell’illustre archeologo e studioso di storia romana e medievale Nino Lamboglia, il prestigioso Museo Navale Romano, sito all’interno di Palazzo Peloso Cepolla espone gli importanti reperti recuperati dal relitto della nave oneraria romana rinvenuta nei fondali dell’Isola Gallinara: vasellame, attrezzature navali, pedine da gioco, piccoli arnesi in piombo per la pesca oltre ad un centinaio di anfore vinarie, disposte come lo erano originariamente sulla loro nave, in un’apposita rastrelliera in legno che ne riproduce il “ventre”.

Diversamente dagli alimenti solidi, come il grano, il trasporto delle derrate liquide o semiliquide come il vino, l’olio e le salse di pesce (garum), è affidato a contenitori in terracotta, in particolare alle anfore (dal termine greco amphìphèro, porto da entrambe le parti, riferito alle due anse dei contenitori). Questo genere di recipienti rappresenta il mezzo più efficace per garantire la conservazione e la spedizione di grandi quantitativi di merci per via marittima o fluviale.
Nelle navi lo stivaggio delle anfore avveniva impilandole le une sulle altre con un sistema “a scacchiera”, in modo che quelle dello strato superiore si inserissero fra tre colli delle anfore sottostanti. I contenitori si adeguavano alla forma della carena e venivano fissati e protetti dagli urti con ramaglie di ginepro, di erica, giunchi, paglia ed altro.
Le anfore venivano fabbricate nelle regioni di produzione delle merci, con forme diverse a seconda della provenienza, della cronologia e del contenuto. In età romana circolavano in tutto il Mediterraneo, spingendosi fino alla Britannia e al Bosforo, testimoniando l’unificazione commerciale, oltre che politica, dell’impero.
Il primo a comprendere l’importanza di questi oggetti per la ricostruzione dei traffici commerciali fu Heinrich Dressel, che alla fine dell’Ottocento studiò la relazione tra le diverse forme di anfore e le iscrizioni conservate su di esse. Così Dressel gettava un ponte tra archeologia, epigrafia e storia economica. Di qui si è sviluppata una solida tradizione di studi.
Oggi siamo in grado di attribuire le anfore a grandi blocchi di produzioni (italiche, galliche, iberiche, africane e orientali) e, all’interno di questi, a sempre più specifici ambiti di provenienza, riuscendo a “tracciare” i rapporti commerciali dei popoli del Mediterraneo.


Sono stati pure recuperati oggetti di uso personale dell'equipaggio e della scorta armata di bordo (elmi), quest'ultima necessaria per difendersi dai pirati che infestavano soprattutto le coste liguri. Tutti gli elementi raccolti permettono di datare il naufragio della Nave Romana di Albenga tra il 100 e il 90 a.C., momento che coincide con la concessione del diritto latino alle popolazioni liguri, con la romanizzazione della regione e con il conseguente sviluppo delle città.
RECUPERO DEL RELITTO
STORIA BREVE
Albenga. Ancora oggi costituisce uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane oggi conosciute nel mediterraneo. E’ la nave romana adagiata sui fondali di Albenga. Venne scoperta casualmente da un pescatore nel 1925. Nelle sue reti finirono tre anfore risalenti all’età romana. La nave “riposa” a circa un miglio dalla costa ad una quarantina di metri di profondità. Solo 25 anni dopo, la SORIMA, (società specializzata che recuperò l’oro sul relitto Egypt,) effettuò un primo intervento di scavo e recupero del relitto. In particolare furono recuperate circa 1.000 anfore, in gran parte danneggiate nella parte superiore per le reti a strascico, ma anche per la pesante benna di recupero dell’Artiglio.
Soltanto nel 1957, con la creazione del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina Albenga, si iniziarono i primi rilevamenti del relitto.
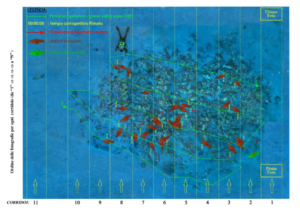
Nel 1961 si affrontò il rilevamento ufficiale della nave adottando il sistema di quadri di rilievo in tubi rigidi formanti una rete di copertura sul relitto, a maglie di cm 150×150, che attraverso un sistema di ingrandimento fotografico in scala di tutti i quadrati (192 per l’esattezza) e il loro fotomontaggio diede le misure reali del cumulo di anfore emergente dal fondo: 26 Mt. di lunghezza e 7.5 di larghezza. Lo scavo iniziò subito dopo al rilevamento e lo stesso permise di accertare che vi era stato subito dopo il naufragio della nave un rapido insabbiamento del fondale e un riempimento di fango proveniente dal fiume Centa che fino agli inizi del Trecento sboccava di rimpetto al relitto.
I risultati più importanti furono raggiunti durante le campagne degli anni 1970 – 1971. Durante queste campagne si poterono costatare che gli strati di anfore erano come minimo quattro, la scoperta di tre ordinate (larghe 14 – 15 cm e alte 12 cm) distanti 10 cm tra di loro nonché la scoperta della lamina di piombo con le chiodatura in rame che fasciava il fasciame esterno, la scoperta della ceramica a vernice nera facente parte del carico impilata negli spazi vuoti tra le anfore la ceramica probabilmente era imballata con materiali leggeri (paglia o altro) e attorno ad essa frammenti di pietra pomice anch’essa come le anfore e le ceramiche di provenienza campana. Lo scavo permise altresì di individuare l’albero maestro che aveva un diametro di circa 50 cm.
A seguito dei risultati dello scavo si accertò che la nave Romana d’Albenga era lunga circa 50 m. larga almeno 10 m.t. e le anfore trasportate dovevano essere almeno 10.000.
Si tenga conto che le anfore pesano vuote kg 21.5, che il loro contenuto era di 26 litri ogni anfora pesava all’incirca 45 kg. – quindi la nave aveva una portata di 450 tonnellate.
Trattandosi di un record, ripetiamo ancora una volta che questa nave costituisce, ad oggi, uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane oggi conosciute nel mediterraneo.
Per il tipo di anfore rinvenute sul relitto (Dressel 1b e poche anfore di forma Lamboglia 2), il tipo e la forma delle ceramiche rinvenute si è potuto collocare il relitto nel primo decennio del secolo 1 a.C.
Tra i materiali del carico sono stati recuperati 8 elmi bronzei, che potrebbero indicare la presenza di una scorta armata a bordo.
E’ ormai diventata famosa la “ruota di manovra” in piombo trovata dai palombari dell’Artiglio, ancora oggi di dubbia interpretazione e il corno in piombo che secondo il Lamboglia come facente parte della testa di un animale che doveva decorare la prua di questa magnifica nave.






Il professor Nino Lamboglia, a bordo della nave "Artiglio" (foto sopra) riuscì a recuperare in poco meno di un mese oltre 700 anfore, dando il via ad una campagna di scavi sommersi condotta in modo sistematico, la moderna "archeologia subacquea". Purtroppo all'inizio furono utilizzati strumenti inadeguati, tra cui una benna meccanica, che arrecarono dei danni irreparabili al carico della nave. Le ricerche che si sono susseguite negli anni hanno permesso di ampliare le conoscenze sulla nave ed il recupero di molto materiale tra cui elmi in bronzo ed oggetti di uso personale dell'equipaggio. Il carico, infatti, è ricchissimo ed in perfetto stato di conservazione nonostante la datazione delle anfore risale intorno al 100 a.C. Le anfore erano stivate con il tipico sistema delle navi onerarie romane e l'aspetto sorprendente è che le anfore pesino vuote circa 21 kg e che il loro contenuto era di 26 litri, per un peso complessivo di circa 45 kg. La nave aveva una portata di oltre 450 tonnellate ed è, ancora oggi, uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane conosciute nel mar Mediterraneo.

Il sistema di sollevamento dei resti per mezzo della benna







Per il recupero dei relitti venivano impiegati scafandri rigidi e articolati, forniti di gambe e braccia terminanti con artigli metallici in grado di afferrare utensili. Il palombaro attraverso degli oblò poteva osservare l’esterno e comunicava con la superficie attraverso un cavo telefonico. Quaglia credette così tanto in questo progetto che nel 1927 acquistò in esclusiva gli scafandri rigidi tedeschi Neufeldt und Kuhnke.
LA NAVE
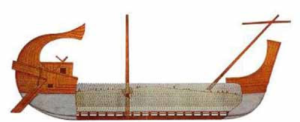
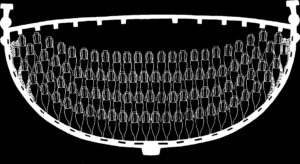
Ce lo spiega molto bene una descrizione tratta da www.antika.it/008704_nave-romana-di-albenga.html e qui riassunta: la nave oneraria di epoca romana rinvenuta ad Albenga (Savona – Liguria), era un’imbarcazione impiegata per il trasporto di merci, lunga 40 m e larga 12 m; essa poteva trasportare intorno alle 11.000/13.000 anfore vinarie e vari tipi di ceramica, tra i quali ve ne erano alcuni che erano stati realizzati in Campania per essere poi esportati in Francia meridionale e in Spagna.
Nel 1950 il professore Giovanni Lamboglia tentò il primo recupero dei reperti con l’aiuto della nave Artiglio, mentre nel 1961 furono realizzati i primi rilievi del relitto.
IL CARICO DELLA NAVE
La nave trasportava per la maggior parte anfore, alcune delle quali furono ritrovate integre, altre soltanto in frammenti costituiti da fondi e colli; il numero delle anfore e la capacità del relitto hanno portato a sostenere che la nave contenesse 13.000 pezzi.
Esse contenevano per la maggioranza vino, ma sono stati rinvenuti anche anfore con residui di noccioline. Le anfore erano chiuse con tappi di sughero, sigillati con la malta, alcune di esse presentavano sotto il tappo una pigna incastrata nel collo, con lo scopo di mantenere l’aroma del vino. Le anfore facenti parte del carico sono le Dressel 1; tre olearie Lamboglia 2 e alcuni frammenti di Dressel 27. Per quanto riguarda la ceramica, essa è presente nella campana A e C e d’imitazione; vasi a vernice rossa interna; urnette; olle; olpi e grandi boccali.
Tra i vari resti sono stati trovati anche due elmi in frammenti; un corno di ariete; una ruota di manovra; tubi; un mortaio; lamine; un tubetto in piombo e piccoli strumenti difficili da identificare. Per il tipo di anfore rinvenute (Dressel 1 B e Lamboglia 2) e il tipo e le forme della ceramica (Campana A, forme 5 e 31) e per gli altri vasi (Campana C, imitazione campana, vasi a vernice rossa interna, vasi a patina cenerognola e vasi comuni) la nave di Albenga è stata datata primo decennio del I a.C.
A cura di A. Eusebio
Nel 1925 il pescatore Antonio Biglione recuperò dal mare tre anfore di epoca romana, la cui posizione era di circa 1 miglio dalla costa e a 40 m di profondità. Nel 1948 l’avvocato Giovanni Quaglia, con lo scopo di verificare la presenza della nave, propose una prima campagna di indagini ed il Ministero della Pubblica Istruzione approvò tale richiesta. Fu stipulato un accordo secondo il quale i reperti recuperati sarebbero stati custoditi nel Museo Civico di Albenga.
LA PRIMA CAMPAGNA DI SCAVO
La campagna iniziò il mattino dell’8 febbraio del 1950 e fu il professor Giovanni Lamboglia a descriverla, vivendola in prima persona:
“Guidammo l’Artiglio, alle 8 del mattino dell’8 febbraio 1950, sulla località delle anfore, con la barca dello stesso pescatore Antonio Bignone e col geom. Fortunato Canepa, del comune di Albenga, pure appassionato pescatore. Fissati gli ormeggi, il palombaro Petrucci si calò per primo sul fondale, entro la torretta di osservazione che costituisce uno degli strumenti più preziosi dell’Artiglio; e, alla profondità di m. 40, telefonò subito che si vedevano anfore a centinaia, sparse in ogni direzione, su una linea di circa 30 metri di lunghezza e circa 10 metri di larghezza, formante una massa affusolata alta circa due metri sul fondale melmoso circostante”.
In seguito a questi rinvenimenti i ricercatori stabilirono di iniziare il recupero delle anfore e di constatare le condizioni della nave:
“Il giorno dopo, 9 febbraio furono issate a bordo le prime anfore, e l’interesse della stampa e del pubblico diventò immediatamente spasmodico, creando seri intralci al lavoro. Fu, ciò nondimeno, un’impressione indimenticabile veder salire a bordo le anfore intatte, a grappoli di cinque o sei, legate a doppio nodo con una fune dai palombari che lavoravano sul fondo, coperte dai colori vivissimi della fauna marina, che al sole si estinguono dopo pochi minuti, di alghe, incrostazioni calcaree e molluschi secolari”.
Dello scafo della nave non emersero resti, perciò si ipotizzò o che la nave fosse stata ricoperta dalla sabbia, oppure che lo scheletro del relitto, a causa del forte peso del carico e all’opera delle correnti marine, si fosse squarciato aprendosi sui due lati, lasciando intatte solo le anfore e probabilmente la chiglia.
Nei giorni successivi venne perfezionato il metodo utilizzato per sollevare le anfore, infatti fu impiegata una rete invece del sistema della legatura ad una fune, che riduceva le anfore in frammenti. Non era stato ancora risolto il dubbio della reale esistenza della nave, della sua posizione e delle sue condizioni di conservazione; perciò le ricerche furono rivolte verso l’estremità del relitto orientata verso il mare aperto.
Il 13 febbraio le ricerche ripresero per mezzo della benna, che aveva la capacità di sollevare una quantità maggiore di anfore e di raggiungere più velocemente la chiglia ed il 17 furono estratti i primi resti della nave. Il 18 lo scavo fu approfondito fino a 2 m, dalla buca furono estratte anfore prive di incrostazioni, ciò fu chiaro indice della vicinanza della chiglia. La campagna fu sospesa il 21 su decisione di Lamboglia e del prof. Pietro Romanelli (ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione).

Nel 1960 la “Daino”, protagonista di questa storia, trasformata in nave ricerche archeologiche sottomarine, assumendo la sigla NATO “A 5308”.
Nel 1962 una seconda esplorazione del relitto fu effettuata dalla nave DAINO così come altre spedizioni sottomarine negli anni seguenti su incarico e a cura del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina che proprio ad Albenga ha la sua sede nazionale.
Nave Romana A
Sito Centro Subacqueo Idea Blu
https://www.youtube.com/watch?v=9p2hJ0gZBQA&t=18s
https://www.centrosubideablu.com/13-immersioni/54-nave-romana-a
IMMAGINI DELL’IMMERSIONE DEL 2 AGOSTO 2014




IMMERSIONE SULLA NAVE ROMANA
DEEP DIVING ACADEMY
L’immersione sulla “Nave Romana di Albenga”, pur non presentando particolarità o difficoltà che la rendono eccezionale, ha tuttavia un fascino al quale è difficile rimanere indifferenti.
Una montagna di anfore poggia su un fondale sabbioso a poco più di 40 metri di profondità, intorno il nulla o quasi. Il 2 agosto 2014 alcuni pesci luna accompagnavano i sub.
Una oasi di storia e di vita accoglie il subacqueo che visita in sito, ogni anfora è diventata la casa o il rifugio di animali marini e così da luogo di memoria è diventato un ambiente di trasformazione, una culla dove nuova vita sorge tra i reperti di quella passata.

Villa san Giovanni in Tuscia - STORIA
Micaela Merlino

CHI ERA NINO LAMBOGLIA?
Nino Lamboglia è stato il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea
Tra le figure di grandi studiosi di archeologia e di storia, l’Italia vanta Nino Lamboglia il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea, che purtroppo, però, è poco conosciuto dal grande pubblico.
Nato a Porto Maurizio in provincia di Imperia il 7 Agosto 1912, già dagli anni dell’Università si interessò alla storia dell’Ingaunia, antica zona della Liguria di ponente.
Nel 1933, nello stesso anno in cui si laureò all’Università di Genova, fondò ad Albenga la “Società Storico Archeologica Ingauna”, quindi dal 1934 al 1937 fu Direttore della “Biblioteca Civica” di Albenga, facendola risorgere dopo un periodo di crisi. Fu poi nominato Commissario straordinario del “Museo Biknell” di Bodighera, fondato nel 1888 dall’inglese Clarence Biknell (1842-1918) che, tra l’altro, aveva scoperto e studiato le incisioni rupestri del Monte Bego. Il Museo raccoglieva le sue collezioni di botanica, ornitologia, archeologia e mineralogia.
In quegli stessi anni il Lamboglia conobbe il famoso archeologo genovese Luigi Bernabò Brea (1910-1999), dal 1939 al 1941 Soprintendente alle Antichità della Liguria, con il quale iniziò a collaborare in ricerche archeologiche nella Riviera di Ponente. Il Bernabò Brea fu il precursore in Italia dello scavo archeologico stratigrafico, che applicò nello scavo della grotta delle Arene Candide presso Finale Ligure, un sito di età Neolitica, e successivamente nello scavo dell’acropoli di Lipari in Sicilia quando fu Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale.
Sempre animato da grande passione per le antichità e da grande energia, nel 1942 Nino Lamboglia fondò a Bordighera l’“Istituto Internazionale di Studi Liguri”, rivestendo la carica di Direttore per trentacinque anni, istituendo successivamente anche altre sezioni in diverse città della Liguria. Né va dimenticato che collaborò attivamente con la Soprintendenza alle Antichità della Liguria come Ispettore aggiunto, in molte ed importanti ricerche di archeologia locale.
La sua benemerita attività si segnalò anche in occasione della Seconda Guerra Mondiale, quando fu Direttore della “Biblioteca Civica Aprosiana” a Ventimiglia, la prima biblioteca pubblica aperta in Liguria e una delle più antiche d’Italia, fondata nel 1648 da Angelico Aprosio (1607-1681) monaco agostiniano e letterato, riconosciuta ufficialmente nel 1653 da Papa Innocenzo X, poi dagli inizi del XIX secolo amministrata dal Comune di Ventimiglia.
La biblioteca possedeva preziosi volumi, incunaboli e manoscritti, e già nel periodo della dominazione napoleonica in Italia aveva subìto furti e dispersione, ma dai primi decenni del XX secolo conobbe una rinascita e ciò grazie all’opera intelligente e zelante di alcuni bibliotecari, tra cui lo stesso Lamboglia, che paventando possibili danni al patrimonio librario e archivistico a causa degli eventi bellici, si attivò per garantirne la conservazione.
I rapporti tra Nino Lamboglia e Luigi Bernabò Brea continuarono ad essere proficui anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo il Bernabò Brea fondò in Sicilia il “Museo Archeologico di Lipari” insieme all’archeologa Madeleine Cavalier, sua infaticabile collaboratrice. Una seria e preparata studiosa che anche il Lamboglia stimò ed apprezzò affidandole nel 1948 le cariche di Segretaria e Vice Presidente della “Section Languadocienne” dell’ “Istituto Internazionale di Studi Liguri”, che mantenne fino al 1952.
Nel 1950 Nino Lamboglia su incarico della Soprintendenza alle Antichità di Siracusa assunse la direzione degli scavi di Tindari, in provincia di Messina, e si dedicò anche allo scavo archeologico sottomarino della nave di Albenga, poi nel 1958 fondò il “Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina”, una struttura tecnico-scientifica deputata alle ricerche di archeologia subacquea.
In quello stesso anno ad Albenga si svolse il “II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina”, e grazie al contributo del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Difesa Marina al Centro Sperimentale fondato dal Lamboglia fu affidata la nave “Daino” appositamente adattata per le ricerche archeologiche in mare. Dal 1959 al 1963 furono condotte campagne di scavo sottomarino a Baia, a Spargi (relitto di nave romana), a Punta Scaletta presso l’Isola di Giannutri nel 1963 (relitto di nave di età repubblicana), e nuove campagne di scavo ad Albenga (relitto di nave romana).
Poi il “Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina” si dotò di una propria nave denominata “Cycnus”, impegnandosi in importanti ricerche lungo le coste tirreniche. Archeologo sempre attento alla salvaguardia dei Beni Culturali, il Lambolgia si battè con decisione per salvare Villa Hanbury presso il promontorio di Capo Mortola a pochi chilometri dal confine con la Francia.
La villa possedeva un meraviglioso giardino botanico allestito dal 1867 dall’inglese sir Thomas Hanbury, coltivando specie vegetali di tutto il mondo, e diventando ben presto conosciuto ed apprezzato a livello internazionale.
Sir Hanbury morì nel 1907, ma il figlio Cecil e sua moglie Dorothy continuarono a prendersi cura della villa e del giardino, che però furono abbandonati nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Fu allora che il giardino rischiò di essere lottizzato, ma appunto il Lamboglia con grande tenacia nel 1960 riuscì a farlo acquistare dallo Stato Italiano, e nel 1962 il complesso fu dato in gestione all’ “Istituto Internazionale di Studi Liguri”.
Tra gli altri meriti del Lamboglia c’è quello di essere stato il primo archeologo italiano ad aver ricoperto nel 1974 la cattedra di “Archeologia medievale” nell’Università di Genova, nello stesso anno in cui fu fondata la rivista “Archeologia Medievale” diretta dall’ archeologo Riccardo Francovich (1946-2007). Sembra incredibile che il padre dell’archeologia subacquea italiana abbia trovato la morte proprio in mare, non durante una ricerca archeologica sottomarina ma a causa di un incidente.
La sera del 10 Gennaio 1977 mentre era alla guida del suo autoveicolo in compagnia del collaboratore Giacomo Martini, fatalmente tratto in inganno dalla folta nebbia e dall’oscurità che impedivano una corretta visibilità, durante le manovre per salire sulla rampa di accesso di un traghetto sbagliò direzione, precipitando nelle gelide acque del mare. La morte tragica e prematura del grande archeologo, e del suo collaboratore, lasciò sconcertati e addolorati i suoi colleghi studiosi, i suoi studenti e quanti avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo.
Per ricordarlo, sull’Isola della Maddalena in Sardegna gli è stato dedicato un Museo, perché nei pressi dell’isola di Spargi Lamboglia aveva recuperato alcuni reperti. In occasione del quarantennale della tragica morte, la “Sezione di Imperia” dell’ “Istituto Internazione di Studi Liguri” il 10 Gennaio scorso ha reso omaggio all’illustre studioso con una cerimonia svoltasi presso la sua tomba, nel cimitero di Porto Maurizio.
L’eredità che Nino Lamboglia ha lasciato, non solo agli studiosi di archeologia, è di grande importanza: la ricerca ha sempre bisogno di coraggiosi “iniziatori” di nuovi metodi di indagine, proprio come lui è stato; per ricostruire in modo esauriente la storia di una civiltà e del territorio nel quale si è formata, e trasformata, occorre avere attenzione non solo per le “fasi classiche” ma anche per i periodi preistorici, e similmente per quelli tardo-antichi e medievali, e il Lamboglia non ha mai prediletto una fase storica rispetto ad un’altra ma tutte ha trattato e studiato con uguale interesse e rigore scientifico.
Una seria ricerca archeologica non si accontenta delle indagini nel terreno, ma scruta con lo stesso impegno gli abissi marini, poiché terra e mare allo stesso modo conservano tracce cospicue dell’uomo, della sua storia, della sua cultura, e il contributo da lui dato all’archeologia subacquea italiana è stato di importanza fondamentale.
L’archeologo non può limitarsi allo studio dei contesti che intende indagare, perché non è né uno “scavatore” nè un intellettuale avulso dalla sua società e dalle urgenze contingenti del momento storico e culturale in cui vive, ma ha il dovere di vigilare con amore, e di far sentire la sua voce con fermezza tutte le volte che qualcuno, o qualcosa, minacciano l’integrità, la sopravvivenza e la trasmissione alle generazioni future dei Beni Culturali, sottraendosi alla logica della speculazione, del guadagno di pochi, dell’indifferenza o della rassegnazione, proprio come ha fatto lui.
L’archeologia per Nino Lamboglia non fu una disciplina a cui dedicare tempo ed energie, ma una scienza che ha performato ed “invaso” tutta la sua vita, identificandosi con essa e andando anche oltre, grazie alla preziosa eredità che ha lasciato.
Micaela Merlino

ANFORE
Aspetti generali
Struttura dell'anfora
Le classificazioni delle anfore
La tebella Dressel
La tabella Lamboglia - Benoit
Esempi: le anfore cananee
Esempi: le anfore greco - arcaiche
Esempi: le anfore greco - italiche
Esempi: le anfore fenicie e puniche
Esempi: le anfore Etrusche
Esempi: le anfore imperiali
La più antica e famosa classificazione di questi vasi biansati senz'altro quella data dall'archeologo tedesco Henry Dressel, che visse molti anni a Roma e nel 1899 studi i marchi delle anfore del Monte Testaccio.
Questo monte, vicino a Porta Portese (Roma), d un'idea del grande uso che veniva fatto di questi recipienti in epoca romana; non altro infatti che una discarica di cocci d'anfora alta 30 metri.
La tabella Dressel (da Corpus Inscriptionum Latinarum) una classificazione tipologica delle anfore romane e, nonostante l'opinione contraria di molti archeologi, anche una tabella cronologica, seppure con molte lacune. Viene universalmente adottata, perchè il punto di partenza delle classificazioni posteriori; si legge a righe successive: la prima si riferisce alle forme repubblicane (II e I secolo a.C.), le altre a forme imperiali (I-III secolo a.C.).
Il compianto professor Nino Lamboglia, assieme al collega francese Fernand Benoit, ha rivisto e rielaborato la primitiva tabella Dressel con una nuova tabella, riordinando le varie forme, con una maggiore attendibilità cronologica.
La più completa e documentata classificazione a cui mi riferisco riguardo alle anfore quella pubblicata dall'archeologo francese Jean Pierre Joncheray nel 1976, con il titolo "Nouvelle classification des anphores dcouvertes lors de fouilles sousmarines".
Si tratta della descrizione tipologica e cronologica delle anfore recuperate lungo i litorali francesi; l'autore un appassionato archeologo oltre che un ottimo sommozzatore. I francesi hanno fatto maggiori progressi e sono a un livello superiore al nostro nella ricerca e nello studio dell'archeologia subacquea.
Lorenzo Mari tratto da 'Speciale Archeosub' supp.to n. 79 di Sub - 6/91
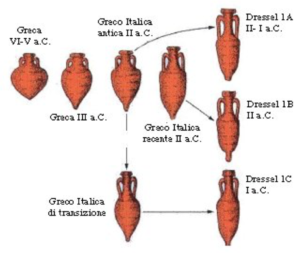
FONTI: Museo della Nave Romana di Albenga
BIBLIOGRAFIA
-
Lamboglia, Diario di scavo a bordo dell’ “Artiglio”, in “Rivista Ingauna e Intemelia”, V, 1, gennaio-marzo 1950, pp. 1-8.
N. Lamboglia, La nave romana di Albenga, in “Rivista di Studi Liguri”, XVIII, 3-4, luglio-dicembre 1952, pp. 131-203.
N. Lamboglia, Il primo saggio di scavo sulla nave romana di Albenga, in “Rivista Ingauna e Intemelia”, XVII, 1-4, gennaio-dicembre 1962, pp. 73-75.
F. Pallarés, Nino Lamboglia e l’archeologia subacquea, in “Rivista di Studi Liguri”, LXIII-LXIV, gennaio-dicembre 1997-1998, pp. 21-56.