UNO SGUARDO SU GENOVA NEL MEDIOEVO - 2024
UNO SGUARDO SU GENOVA NEL MEDIOEVO
2024

Cristoforo Grassi "Veduta di Genova nel 1481"
La Repubblica di Genova (Repúbrica de Zêna, /ɾe'pybɾika de 'ze:na/ in ligure, Res publica Genuensis o Ianuensis in latino; ufficialmente fino al 1528 Compagna Communis Ianuensis e dal 1580 Serenissima Repubblica di Genova) è stata una repubblica marinara, esistente dal 1099 al 1797.


GENOVA NEL MEDIOEVO - 2024
INTRODUZIONE
Il progetto "Ianua – Genova nel Medioevo" si propone di riscoprire e divulgare la storia medievale di Genova durante l'anno 2024, seguendo le linee guida del Piano Strategico della Cultura. Questo programma annuale mira a valorizzare l'eredità medievale della città, richiamando l'attenzione su come la Genova del Rinascimento e del Barocco affondi le sue radici in un periodo di straordinario sviluppo e trasformazione, che si estende dal X al XV secolo.
Numerose associazioni culturali locali hanno profuso impegno e risorse nel recupero di opere d'arte significative, nel restauro di chiese storiche e delle celebri case dei ROLLI, nonché nella realizzazione di ricerche storiche volte a chiarire le origini e le leggende che circondano la storia genovese. Questo lavoro di recupero ha messo in luce molteplici aspetti della vita medievale e il ruolo di Genova come un importante centro commerciale e culturale del Mediterraneo.
Il progetto comprende una vasta gamma di iniziative, tra cui l'apertura di siti storici e aree d'interesse, come chiese, torri e edifici storici, che saranno accessibili al pubblico. Si terranno incontri tematici, mostre, eventi teatrali, concerti e altri eventi culturali, tutti progettati per narrare la complessità della vita genovese medievale e illustrare il contributo significativo di Genova come porto commerciale d'Europa. Ogni iniziativa avrà l'obiettivo di coinvolgere i cittadini e i turisti, creando un dialogo interattivo con la storia.
In particolare, si porranno i riflettori su figure iconiche come Guglielmo Embriaco e Cristoforo Colombo e su eventi chiave che hanno segnato la storia della città, rendendo la narrazione accessibile e affascinante. Durante l'anno, verranno organizzati convegni e seminari per approfondire temi storici, archeologici e artistici, spesso in collaborazione con università e istituzioni locali, permettendo così una condivisione delle conoscenze tra esperti e pubblico.
Le iniziative includeranno visite guidate e seminari, con l’intento di offrire momenti di immersione nella storia genovese. È prevista la creazione di un calendario ricco di appuntamenti, che vedrà la partecipazione di enti e associazioni locali unite in un progetto condiviso. In particolare, si svolgeranno attività accessibili a tutti, con visite dedicate alle persone con disabilità e traduzione simultanea in lingua dei segni italiana, per garantire una fruizione inclusiva del patrimonio culturale.
Questo sforzo collettivo non solo celebra la storia medievale di Genova, ma contribuisce anche a rafforzare la sua identità culturale contemporanea, ponendo solide basi per uno sviluppo economico sostenibile attraverso il turismo. Attraverso il progetto "Ianua", la città avrà l'opportunità di mostrare al mondo le proprie meraviglie medievali, affascinando e incantando abitanti, turisti e appassionati di storia.
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, sarà disponibile una pagina dedicata sul sito www.visitgenoa.it - dove sarà possibile consultare il programma delle attività e seguire gli sviluppi dell’iniziativa.
La nostra Associazione Mare Nostrum - Rapallo, grazie alla ricca collezione di articoli e ricerche dedicate alla storia e alla cultura di Genova e della Liguria, può con orgoglio affermare di essere parte integrante di questa nobile civiltà repubblicana e democratica, simbolizzata dalla 'LANTERNA'.
Insieme alle altre tre Repubbliche Marinare Italiane: Venezia, Pisa e Amalfi, Genova ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dell'Europa e del mondo occidentale.
Carlo GATTI
Past President - Mare Nostrum Rapallo
Per l’occasione, Vi segnalo una parte soltanto della lunga serie di filmati YouTube curati in gran parte dall’ Emittente Televisivo genovese PRIMO CANALE al quale potrete attingere molte altre fonti di notevole interesse.
https://www.primocanale.it/
Una Giornata nel Medioevo:
https://www.youtube.com/watch?v=PCdNU-6g7i8
https://www.youtube.com/watch?v=PurQhLjZ0sE
I Tesori di Sant’Agostino
https://www.youtube.com/watch?v=rn9Fuuym-tU&list=PLde00V2nanIQ4hTMuOyDub-Mhq2wh2IRf&index=2
“Medioevo a Genova” - La Tavola rotonda a Terrazza Colombo
https://www.youtube.com/watch?v=Lge12fmaikI&list=PLde00V2nanIQ4hTMuOyDub-Mhq2wh2IRf&index=4
Alla scoperta dei protagonisti del Medioevo di Genova
I BALESTRIERI DEL MANDRACCIO
4
https://www.youtube.com/watch?v=L1aCMT-D2C8&list=PLde00V2nanIQ4hTMuOyDub-Mhq2wh2IRf&index=4
primocanale.it
In occasione dell’evento Ianua Genova nel Medioevo, Antonio Musarra, curatore del progetto, presenta alcuni preziosi corali miniati che appartengono alla chiesa di Santa Maria di Castello. Il “Corale” è un libro liturgico che si usava nel coro, lo spazio nell’abside della chiesa in cui prendevano posto sacerdoti e monaci. Al centro si trovava un grande leggio su cui venivano collocati uno o più “corali”, orientati in varie direzioni, in modo che ciascuno dal suo posto potesse leggere il testo e la musica dei pezzi che venivano recitati o cantati ➡️ scopri di più su
primocanale.it
Un restauro lungo 4 anni per il Monumento Fieschi ricostruito proprio come un 'puzzle': il Museo Diocesano festeggia il riallestimento di una delle testimonianze più importanti del Medioevo genovese, un monumento funebre che celebra il cardinale Luca Fieschi, genovese del 1270. Qui vi raccontiamo in breve la sua storia ➡️ sul sito @primocanale.it trovate la diretta di approfondimento sui lavori e la storia di quest’opera…
primocanale.it
Il video conclusivo di "Assaggi di Medioevo"!
Viaggio nella cucina del Medioevo genovese
https://m.youtube.com/watch?v=kKpC68Rc5x0
Alessandro BARBERO
"Genova, il suo Medioevo ancora da ..."
https://www.rainews.it/tgr/liguria/video/2024/01/alessandro-barbero-genova-il-suo-medioevo-ancora-da-studiare-i-rolli-la-riscoperta-del-passato-8227e4d5-4336-444d-8237-36cfd913827b.html
"Lezioni di Storia - Teatro Nazionale Genova"
"L'Impero di Genova, quarta parte: il Mar Nero. Conclusioni di ..."
https://www.youtube.com/watch?v=NZiPsYQr2QM
Alessandro Barbero innamorato di Genova: "Sta tornando famosa in tutto il mondo"
https://www.youtube.com/watch?v=yqV3Nfi0S9E
Medioevo marinaro | Intervista ad Antonio Musarra
https://www.youtube.com/watch?v=1ekrTLTtVts
YouTube vi presenta l'incontro tra Alessandro Alfieri e lo studioso genovese Antonio Musarra, professore di Storia medievale all'Università "Sapienza" di Roma, in occasione dell'uscita del suo ultimo volume "Medioevo marinaro. Prendere il mare nell'Italia medievale" edito da Il Mulino.
Il libro ci invita alla scoperta dell’anima marittima del Medioevo; un lavoro accurato, approfondito, risultato di anni di ricerca su fonti non certo ovvie, e che si presenta anche come un lavoro “introduttivo”, nel senso che l’ambizione è quella di avviare o amplificare una nuova visione storica sul Medioevo. Spesso infatti le vicende marittime e il Mediterraneo sono stati marginalizzati rispetto alle vicende dell’Europa continentale; lo spazio geografico si confonde con quello fantastico, dal momento che il peso dell’immaginario restò a lungo preponderante fino alla crescente razionalizzazione della società. Come separare realtà e fantasia? Qual è il confine tra reale e immaginario?
Oltre a rispondere a questi interrogativi, in questo volume Musarra propone anche una ricostruzione dettagliata dello sviluppo tecnico della vita marinara, delle invenzioni, delle strumentazioni di navigazione e delle navi, fino ad arrivare all’attenzione rivolta alla dimensione normativa e giuridica.
La casa di Cristoforo Colombo
Nessun dubbio, Cristoforo Colombo era ligure. L’ultima teoria che arriva dalla Spagna in questi giorni, dopo un esame del dna, lo vuole ebreo sefardita. Ma i documenti dell’epoca parlano chiaro.
GABRIELLA AIRALDI
lunedì 14 ottobre 2024
«Sulla genovesità di Colombo esistono talmente tanti documenti che non può essere messa in discussione»,
sostiene Gabriella Airaldi, specialista di storia delle relazioni internazionali e interculturali dal Medioevo all’età moderna, insignita sabato a Genova della Medaglia Colombiana in quanto“illustre storica di fama internazionale”.
Ecco perché Cristoforo Colombo era genovese
Primocanale.it
https://www.primocanale.it/attualità/46923-ecco-perché-cristoforo-colombo-era-genovese.html
Chi è Cristoforo Colombo? Un eroe, un assassino, un mistico, un templare, il figlio di un papa, un catalano, un portoghese, un corso, un savonese? E’ di origine piacentina, monferrina o è un ebreo come oggi si torna nuovamente a proporre? Conoscere questo personaggio non è facile a cominciare dal fatto che, nonostante i molti ritratti, non ne è nota neppure la fisionomia. Se ne conosce invece bene la storia, per molti versi simile a quella di molti genovesi migrati in varie parti del mondo. Figlio di un lanaiolo, entrato in mare "in giovanissima età" come molti concittadini di ogni fascia sociale, il quattordicenne Cristoforo si forma sulle navi dei guerrieri -mercanti genovesi che da secoli visitano tutto il mondo conosciuto. Ed è attraverso questa via, come afferma egli stesso in una lettera indirizzata ai Re Cattolici, che nasce la sua curiosità e cresce il suo progetto di arrivare ad Oriente passando da Occidente. Infatti -sostiene Colombo- è la navigazione stessa a indurre “chi la segue a desiderare di conoscere i segreti del mondo”.
Nasce dunque da un’esperienza lunga e complessa e da un’inesausta curiosità il desiderio di futuro che porta Colombo a compiere il gesto destinato a cambiare la storia. Un gesto forte che conclude un itinerario umano difficile da cogliere ma che, grazie a una sterminata quantità di testimonianze di mano sua e altrui, a una cospicua serie di fonti diplomatiche e mercantili, consente di essere certi delle sue origini genovesi. Tutto nella sua vita, nei suoi comportamenti, nei suoi legami, nelle protezioni della lobby genovese di cui gode alla Corte castigliana, riconduce a una città dalla quale resterà sempre lontano ma che ricorda nella lettera indirizzata al Banco di san Giorgio nel 1502 con le note parole ‘ Benchè il corpo si unì il cuore è li di continuo’. Una città dove ha amici come l’ambasciatore Niccolò Oderico al quale consegna la copia del Libro dei Privilegi tuttora conservata a Genova. Una città da dove provengono anche i parenti meno fortunati che lo raggiungono in Spagna e che ne godranno la protezione. Una terra dove è noto il legame che unisce lui e la sua famiglia al grande nome dei Fieschi, come testimoniano l’amicizia che lo unisce a Bartolomeo, il comandante della Vizcayna che nel quarto viaggio lo salva dalle tribolazioni della Giamaica e la lettera inviata a fine vita al patriarca Luigi. Il gesto di Colombo ha cambiato la storia e l’immagine del mondo. E’ nato con lui il nuovo Occidente e, come talvolta si sostiene, è con quel gesto che si chiude l’Età medievale e si apre quella moderna. Di fatto il gesto di Colombo è un rito di fondazione. Un rito di fondazione supera la storia ed entra nella sfera del mito ed è forse per questo che si parla dell’uomo che lo ha compiuto e sempre se ne parlerà.
Gabriella Airaldi
Autrice di oltre quattrocento pubblicazioni, tra cui 13 libri e 22 curatele, è specialista di storia mediterranea e di storia delle relazioni internazionali e interculturali per l'età medievale e la prima età moderna. Premio Anthia 2004 per il libro Guerrieri e mercanti.
Uno dei tanti esempi di riqualificazione e recupero di un patrimonio artistico ...
Una gemma del centro storico di Genova, le prime immagini della riapertura della chiesa di Sant'Agostino.

Chiesa e Convento di Sant’Agostino. I monaci agostiniani costruirono il chiostro a forma triangolare ispirandosi al simbolo agostiniano della Santissima Trinità. (n.d.r)
Il complesso di Sant’Agostino, chiesa e convento, ha una storia lunga e complessa.
La chiesa, iniziata probabilmente attorno al 1260 e già in uso nel 1270, è a tre navate con copertura mista, a capriate e a volte. La facciata è a salienti, scandita in tre parti da lesene e presenta un paramento a fasce bianche e nere. Nel corso dei secoli il complesso subì diverse trasformazioni. Una serie di cappelle venne realizzata nel corso del XV secolo sfondando il muro perimetrale sinistro della chiesa, così come erano presenti anche altari e cappelle addossati al perimetrale destro.
Sul coronamento della facciata sono state collocate tre statue (oggi sono calchi, gli originali sono conservati in museo) raffiguranti la Madonna con Bambino, San Pietro e Sant’Agostino e risalenti al XIV secolo.
La torre campanaria richiama nelle forme il campanile di San Giovanni di Pré: insolito per Genova l’uso del mattone e il rivestimento in piastrelle policrome.
In una formella romboidale murata nel campanile si trovò un marmo con iscritto il nome "Pietro Bono, Magister de Antelamo" e la data 1282.
Due sono i chiostri del complesso: il primo, di forma triangolare, non usuale per l’edilizia conventuale genovese, venne costruito contemporaneamente alla chiesa ed è caratterizzato al pianterreno da un loggiato ad arcate ribassate, sostenute da colonne a rocchi di pietra e di marmi bianco e sormontate da capitelli cubici.
Il chiostro quadrato, risalente alla prima metà del Seicento, venne costruito in un’area precedentemente utilizzata come orto. Nel 1798 la chiesa venne sconsacrata e da allora non tornò mai più al culto. Dopo i pesanti danni subiti nel corso della seconda guerra mondiale gli spazi relativi al primo chiostro triangolare e la chiesa vennero ristrutturati, mentre quelli relativi al chiostro rettangolare furono completamente ricostruiti.
(Musei di Genova)
Il primo appuntamento sarà il 30 maggio quando le navate dell'antica chiesa di Sant'Agostino costruita alla fine del XIII secolo e poi sconsacrata, riapriranno i battenti per offrire a turisti e cittadini un assaggio della Genova Medievale. All'interno, infatti, tra le arcate gotiche, troveranno spazio alcuni dei capolavori del museo, a partire dalla statua di Margherita di Brabante, per riportare alla luce quei frammenti della Genova medievale che verranno poi esposti all'interno del museo una volta completati gli interventi di riqualificazione che prendono l'avvio proprio nell'anno che celebra Genova nel medioevo.
"Inizia il percorso per il recupero di Sant'Agostino, una vera e propria gemma del nostro centro storico che racconta gli antichi fasti della Genova medievale - ha detto il sindaco Bucci -. Un complesso unico nel suo genere per bellezza, arte e cultura. Dall'ex Chiesa fino al museo, la città potrà riappropriarsi dell'intero complesso che tornerà completamente rinnovato, dagli spazi fino al percorso espositivo e i servizi per i visitatori". Un intervento particolarmente complesso che prevede interventi architettonici sul chiostro quadrangolare, l'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi architettonici per ampliare gli spazi di accoglienza e di servizio, adeguamento degli impianti, restauro completo della ex chiesa, percorso museografico aggiornato secondo criteri di attualità. "L'obiettivo è di riaprire tutto entro due anni - ha spiegato il vice sindaco Pietro Piciocchi - i costi sono, ovviamente molto consistenti, nell'ordine di una decina di milioni compresa la riqualificazione della chiesa, e le risorse le stiamo trovando".
Andrea Leoni
09 Aprile 2024
Desidero chiudere questa carrellata storica con un Evento simbolo della Storia medievale di Genova.
Antonio Musarra - 1284, la battaglia della Meloria
https://www.youtube.com/watch?v=-T28P2BgAok
Antonio Musarra - presentazione del libro "1284, La Battaglia della Meloria"
3 maggio 2018, ore 18 Sala del Maggior Consiglio
Il 6 agosto del 1284 è la festa di San Sisto: un giorno solitamente fausto per Pisa. Quel giorno, al largo di Livorno, nei pressi delle secche della Meloria, Genovesi e Pisani si affrontarono in una delle più grandi battaglie navali del Medioevo. La causa immediata è la contesa per il controllo della Corsica. In realtà, al centro v’è soprattutto il tentativo di affermare la propria supremazia su tutto il Tirreno al fine di salvaguardiare le rotte per la Sicilia, l’Africa settentrionale e il Levante mediterraneo. In effetti, le due città giunsero allo scontro al culmine di una serie di rivolgimenti – dalla caduta dell’Impero Latino di Costantinopoli all’ascesa della potenza angioina, allo scoppio della guerra del Vespro – che mettevano in discussione gli equilibri raggiunti a fatica. La ricostruzione del volto di questa battaglia e della sua lunga preparazione consente di riportare alla luce, oltre alla brutalità del combattimento sul mare, il profilo di un Medioevo diverso: quello marittimo e navale, dove gli orizzonti improvvisamente si allargano e dove piccole città si rendono protagoniste di rivoluzioni – da quella commerciale a quella nautica, a quella finanziaria – capaci di mutare il corso della storia.
Insieme all’autore intervengono Sandra Origone (Università di Genova), Luca Lo Basso (Università di Genova), e Emilano Beri (Università di Genova).
Edizioni Laterza
A cura di Carlo Gatti
Rapallo, 18 Ottobre 2024
LETTURE PER L'ESTATE 2024 - JEAN SIBELIUS A RAPALLO
PARTE PRIMA
Introduzione
Il MARE è sempre il filo conduttore dei nostri articoli, un elemento costante che lega storie e personaggi anche quando, come in queste Letture per l’Estate, non si parla di navi, ma di uomini e donne che dal mare hanno tratto ispirazione per deliziare l’umanità con ogni forma d’arte possibile. Questa volta, il nostro viaggio ci porta a esplorare la figura di Jean Sibelius, un gigante della musica sinfonica che trovò ispirazione proprio sulle coste della nostra amata Rapallo.
Chi più di noi tigullini può testimoniare questi eventi intrinsecamente legati alla bellezza e all’armonia di una natura che si può definire paradisiaca? Le onde che si infrangono contro le rocce, il profumo salmastro dell'aria, i tramonti che incendiano il cielo e si specchiano nel mare: tutto ciò non è forse un costante invito alla riflessione, alla creatività, alla celebrazione del bello?
In questa trilogia di articoli, esploreremo la connessione profonda tra il mare di Rapallo e l'opera di Sibelius, un legame che si è rivelato fruttuoso per l'umanità intera. Ripercorreremo i momenti salienti della vita e del soggiorno di Sibelius a Rapallo, scoprendo come il nostro mare con la sua natura, sia diventato musa e teatro per le sue composizioni e per la sua anima artistica.
Il suo lascito artistico si trova oggi nelle note dell’ORCHESTRA DI RAPALLO dedicata al grande compositore finlandese, e nella bacchetta magica del suo bravissimo Direttore rapallino Filippo Torre:

In questo Link:
https://www.orchestrasibelius.it/sibelius/index.php/it-it/
HOME
SCRITTORI, POETI, FILOSOFI, ARTISTI E MUSICISTI NEL TIGULLIO
Nella seconda metà dell’Ottocento, tanti scrittori europei e non solo, GRAZIE alle prime navi da crociera, cominciarono a perlustrare il Tigullio alla scoperta d’una natura selvaggia densa di echi mediterranei, dando vita a un turismo d’élite e lasciando un segno indelebile nella nostra cultura.
L’elenco è molto lungo, ed ho pensato di proporvi un significativo articolo della scrittrice Laura Guglielmi che cita molti personaggi illustri tra cui figura il grande musicista finlandese: Jean SIBELIUS che soggiornò a Rapallo, e qui fu ispirato dal paradisiaco paesaggio di allora per iniziare la sua celebre 2° sinfonia.
In giro per il Tigullio con gli scrittori
BY LAURA GUGLIELMI 14/03/2022
https://www.lauraguglielmi.it/genova-e-liguria/in-giro-per-il-tigullio-con-gli-scrittori/
Laura Guglielmi scrive: “Altri artisti stranieri si innamorano del clima e delle bellezze di Rapallo: tra i tanti, il musicista Ian Sibelius …..”
UN PO’ DI STORIA MUSICALE
Nella seconda metà dell’ottocento, nell'ambito di quel periodo denominato "le giovani scuole nazionali", nell'area Scandinava: Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, nacque una corrente musicale legata al folklore nazionale.
Ma cosa sono le scuole nazionali?
Con la rivalutazione del canto popolare e delle identità nazionali i musicisti, che operano nel corso dell’ottocento, rivolgono sempre più la loro attenzione al patrimonio delle tradizioni popolari e utilizzano le risorse espressive tipiche di questo repertorio assimilandolo a quello “colto”. Il nazionalismo romantico dunque, pur conservando la sostanziale struttura musicale di tradizione occidentale, opera un rinnovamento profondo i cui effetti, al volgere del secolo, produrranno dei cambiamenti radicali. Nell’epoca romantica la ricerca e l’espressione dell’identità nazionale esercitano un ruolo determinante nello sviluppo artistico, specialmente in quei Paesi dell’Europa che avevano stabilito dei collegamenti con la cultura musicale italo-franco-tedesca.
Ciò avviene in modo particolare in Russia dove, in seguito alla vittoria sugli eserciti napoleonici, si consolida il patriottismo e la valorizzazione delle tradizioni culturali dei popoli di tradizione slava.
Il risveglio della coscienza nazionale favorisce, di conseguenza, l’emancipazione della musica dalle forme d’importazione occidentale attraverso la rivalutazione del patrimonio popolare e la valorizzazione delle diverse tradizioni storico/musicali. Nel teatro d’opera si manifestano tutti i caratteri nazionali con la scelta di argomenti storico/popolari, epico/leggendari o fantastici. Nella musica strumentale, sinfonica e cameristica vengono inseriti elementi esotici e folkloristici, motivi popolareschi e ritmi di danze popolari. Anche gli arcaismi armonico/modali e i raffinati ed esuberanti effetti orchestrali conferiscono alla musica un particolare “colore locale”. Si crea così uno stile capace di innalzare la musica della nazione e quella del canto popolare a lingua musicale d’arte infondendovi elementi nuovi e un autentico “carattere nazionale”. Tutto ciò avviene però nel rispetto e sulla scia dei modelli formali e stilistici segnati dalla cultura musicale occidentale innestandovi però tutti quegli elementi tipici delle singole realtà e tradizioni popolari.
In Danimarca spicca il musicista Niels Wilhelm Gade (1817-1890), autore della cantata “La figlia del Re degli Elfi” (1854) ricca di temi popolari.
Carl August Nielsen (1865-1931) invece è un autore di musica pianistica, da camera, di concerti e sinfonie che presentano un linguaggio nuovo vicino alle nuove tendenze musicali del novecento europeo.
In Svezia si impone Franz Berwald (1796-1868) autore di quattro sinfonie scritte tra il 1842 e il 1845 che presentano sensibilità per determinati effetti orchestrali.
In Norvegia la personalità più significativa è quella di Edvard Grieg (1843-1907) di formazione musicale tedesca con gli studi presso il Conservatorio di Lipsia, mostra un vivo interesse per il folklore musicale del proprio paese e, in seguito all’incontro con il grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen (1828-1906), scrive le musiche di scena del Peer Gynt.
La sua produzione spazia dai Lieder (150) per pianoforte e voce, numerosi pezzi brevi per pianoforte compresi nelle dieci raccolte dei pezzi lirici (1867-1901).
Caratteristiche: linguaggio ricco di spontaneità melodica, raffinate armonie con l’evidente influsso di melodie popolari e di ritmi di danze norvegesi (vedi le Danze norvegesi op. 72) e il concerto per pianoforte e orchestra in la minore (1868) e sonate per violino e pianoforte.
In Finlandia il maggior esponente musicale di quel periodo è Jean Sibelius (1865-1957). Nelle sue composizioni sono presenti temi popolari nordici e spunti melodici di derivazione popolare. Le composizioni più significative sono i poemi sinfonici come “Una saga” (1892), Karelia (1895), “Finlandia” (1899) e sette sinfonie scritte tra il 1899 e il 1924.
E’ stato scritto:
Sibelius è il grande dimenticato della musica europea. Confinato in un limbo periferico delle Scuole Nazionali, su di lui pende quell'accusa di epigonismo post-romantico che le avanguardie novecentesche (musica dodecafonica) sempre lanciarono contro i difensori dell'Umanesimo. In realtà la musica di Sibelius celebra l'eternità di una natura primigenia dove i cicli delle stagioni si rinnovano oltre ogni dramma della storia, trasceso, più che negato, in un'accettazione del Fato che sa di stoica serenità. In Sibelius la civiltà europea si confronta con le proprie origini nelle energie che modellano i ghiacci, i venti artici capaci di fissare il tempo in armonie perenni, cristalli eternamente fissi nella pietra. L'originalità del Finlandese è sottile, ardua da percorrere, come complesso è il suo linguaggio fatto di risonanze emanate dai basalti della terra, tensioni lontane dalla rassodante razionalità della civilizzazione europea. In un'epoca di transizione quale è la nostra, mentre la pretesa di assoggettare il caos cede in noi alla fascinazione del mito, Sibelius ritorna con i suoi enigmi ad incombere come inquietante profeta. Messaggero alla fine dei tempi, veggente inascoltato, siglò il proprio destino di inattuale distruggendo di propria mano la gigantesca Ottava Sinfonia che doveva coronare uno degli edifici sinfonici più tremendi, nella sua coerenza, che siano mai stati eretti. Isolandosi tra laghi e foreste, nei trent'anni della sua rinuncia a comporre trovò la via di un silenzio che la sua musica, forse, fin dal principio evoca: salvifico ritorno alla natura, divinità benigna.
LA SINFONIA N.2 in re maggiore (0p.43) di Jean SIBELIUS
E' stata composta tra il 1900 e il 1902. La seconda è la più popolare tra le sinfonie di Sibelius ed è quella maggiormente eseguita e registrata.
La composizione è iniziata durante la permanenza del compositore a RAPALLO nel 1900, viaggio finanziato dal barone Axel Carpelan, ed è poi proseguita al suo ritorno in Finlandia. La prima esecuzione, diretta dal compositore stesso, è stata fatta dall’Orchestra filarmonica di Helsinki l'8 marzo 1902. Dopo la prima, Sibelius ha apportato alcune modifiche all'opera, e la versione definitiva è stata eseguita per la prima volta il 10 novembre 1903 a Stoccolma diretta da Armas Järnefelt.
L'orchestrazione è migliore rispetto a quella della prima sinfonia, la forma è più matura e la violenza nordica è sostituita da un tocco più classico e luminosamente mediterraneo. In merito all'origine dei temi impiegati nella sinfonia, si sa che Sibelius ha improvvisato uno dei temi del finale a Ruovesi, nel 1899, in occasione del battesimo di un figlio del pittore Akseli Gallen-Kallela. Sull'origine dei temi impiegati nel primo movimento, Karl Fredrik Wasenius, editore della casa Bis, afferma che Sibelius li avrebbe improvvisati nel suo studio, in occasione di un incontro con una giovane musicista (che allora aveva solo sette anni), Irene Eneri, della quale l'editore volle sottoporgli il talento. Suonando una composizione di costei, un Capriccio Orientale, il compositore iniziò ad improvvisare, affermando di "aver trovato ciò che attendeva da settimane". I temi dell'andante invece sono stati abbozzati da Sibelius durante la sua permanenza a Rapallo, nel febbraio del 1901: nelle sue bozze uno è associato alla figura di Cristo, uno all'incontro tra Don Giovanni (il protagonista dell'omonima opera mozartiana) e la morte. Ma la sinfonia è stata completata dopo oltre un anno di lavoro, e in questo arco di tempo tali intenti programmatici sono stati messi da parte.
Riporto da Wikipedia:
MOVIMENTI
La sinfonia è strutturata in quattro movimenti.
I. Allegretto
Allegretto - Poco allegro - Tranquillo, ma poco a poco ravvivando il tempo all'allegro - Poco largamente - Tempo I - Poco allegro
Il primo movimento comincia con un tema saltellante dei legni in tonalità d'impianto su accordi ribattuti degli archi. Il primo accordo, con il frammento ascendente di tre note, costituisce il motivo portante di tutta la composizione, analogamente al ruolo svolto dall'introduzione dei clarinetti nella prima sinfonia. Segue un'alternanza fra i fiati e i corni, e gli studiosi faticano ad identificare chiaramente un secondo tema come lo si aspetterebbe nella forma sonata. Nello sviluppo il tema iniziale, terminante con una quinta discendente, ritorna sotto varie sembianze, in maniera più drammatica. L'elaborazione di questo sviluppo è molto lunga, al punto che costituisce, in contrasto alle regole classiche, la gran parte del primo movimento. Nella ripresa il materiale musicale viene efficacemente sintetizzato. Dopo momenti di carattere più scuro, il movimento si conclude con lo stesso carattere idilliaco dell'inizio.
II. Tempo andante
I temi dell'andante invece sono stati abbozzati da Sibelius durante la sua permanenza a Rapallo, nel febbraio del 1901: nelle sue bozze uno è associato alla figura di Cristo, uno all'incontro tra Don Giovanni (il protagonista dell'omonima opera mozartiana) e la morte. Ma la sinfonia è stata completata dopo oltre un anno di lavoro, e in questo arco di tempo tali intenti programmatici sono stati messi da parte.
Tempo andante, ma rubato - Poco allegro - Molto largamente - Andante sostenuto - Andante con moto ed energico - Allegro - Poco largamente - Molto largamente - Andante sostenuto - Andante con moto ed energico - Andante - Pesante
L'andante inizia con una lunga sezione di pizzicati dei violoncelli e dei contrabbassi. Il primo tema, quello che era stato concepito come la morte nel castello di Don Giovanni, viene proposto dal fagotto e si sviluppa in un contesto di ansietà crescente. In contrasto vi è il tema associato alla figura del Cristo, molto più celestiale e rassicurante. I due temi si alternano trasformandosi vicendevolmente, con giri complessi di tonalità, come l'episodio in sol bemolle maggiore, quasi a riflettere la lotta fra morte e redenzione, benché la sinfonia non abbia intento programmatico. Poco a poco il melodico secondo tema prende il sopravvento e diventa il protagonista. Il movimento si conclude con due pizzicati.
III. Vivacissimo
Vivacissimo - Lento e soave - Tempo primo - Lento e soave - (attacca)
Il vivacissimo (uno scherzo) è impetuoso, analogamente a quello della sinfonia che lo precede. Il suo primo tema è vorticoso, affidato ai violini; ad esso si contrappone subito il flauto che propone un tema secondo tema più cantabile anche se comunque ritmico, accompagnato da figurazioni molto vivaci degli archi. Il tempo rallenta arrivando al trio, che inizia con otto struggenti ripetizioni della stessa nota da parte del primo oboe, figurazione che ritorna più volte nelle misure seguenti, e porta ad una grande affermazione della stessa. Lo scherzo si ripete. Si ripete anche il trio, ma in forma abbreviata; da qui si genera un passo mosso e il solito motivo ascendente di tre note funge infine da ponte per l'attacco senza fermata del finale.
IV. Finale: Allegro moderato

Tema iniziale della IV sezione
Finale: Allegro moderato - Moderato assai - Meno moderato e poco a poco ravvivando il tempo - Tempo I - Largamente e pesante - Poco largamente - Molto largamente
Anche nel finale ritorna il tema iniziale di tre note ascendenti, in tonalità d'impianto, ma in questo caso la replica è affidata non più ai legni, bensì alle trombe. Segue il vero primo tema, affidato a tutti i violini, espansivo, cantabile, solenne; questo tema è stato ripreso, nella stessa tonalità, da Gigi D’Agostino in “L’amour toujorus”. La sua elaborazione porta al secondo tema. Il motivo introdotto dagli oboi è stato scritto da Sibelius in memoria di Elli Järnefelt, sorella di sua moglie, morta suicida. Il tema si espande poco a poco su tutta l'orchestra (quasi - sebbene assai alla lontana - come un lungo crescendo rossiniano) assume un tono maestoso e porta di nuovo agli squilli di trombe che introducono la ripresa del primo tema. Regolarmente e brevemente si ritorna al secondo tema e al suo crescendo. Che però introduce la sezione finale, sorretta vigorosamente dagli archi, con ampi squilli degli ottoni. A detta del musicologo Erkki SalmenHaara, studioso della musica di Sibelius, un particolare effetto viene ottenuto quando il motivo ascendente di tre note raggiunge finalmente, per la prima volta nella sinfonia, la quarta nota. Con questo clima solare e luminoso la sinfonia si conclude positivamente.
Accoglienza
In Finlandia la popolarità della sinfonia è legata al sentimento nazionalista che viene percepito nella stessa. Il primo e l'ultimo movimento, con il loro eroismo, il loro ottimismo ed il grandioso finale hanno toccato il pubblico finlandese, che vi leggeva un messaggio patriottico per l'indipendenza della Finlandia (l'opera è stata composta nel periodo dell'invasione russa), tanto da farla conoscere come "Sinfonia della liberazione", affermando la fama di Sibelius quale compositore nazionale finlandese. La sinfonia ha riscosso grande successo anche fuori dalla Finlandia. Il direttore finlandese George Schnéevoight associò un programma di argomento patriottico ai movimenti: il primo ritrarrebbe la vita pastorale della Finlandia, il secondo la brutalità dell'occupazione straniera, il terzo l'oppressione dello spirito patriottico e il quarto la speranza gloriosa per la liberazione dalla tirannia.
Registrazioni
La prima registrazione è stata incisa da Robert Kajanus (1857-1933) con la London Symphony Orchestra, per la casa discografica HMV, nel maggio 1930.
Sibelius: 2. Sinfonie ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Susanna Mälkki
YouTube
YouTube·hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony·4 giu 2019
https://www.youtube.com/watch?v=iXU8EXL7a_4
PARTE SECONDA
LA VITA E LE MUSICHE DI JEAN SIBELIUS

Hämeenlinna la città di nascita di Jean Sibelius

Jean Sibelius (1913)

Jean Sibelius (1939)
Jean Sibelius nacque nel 1865 a Hämeenlinna (96 Km a Nord di Helsinki) nel Granducato di Finlandia, sotto il dominio russo. La sua famiglia, per metà svedese*, decise consapevolmente di mandare Jean in un'importante scuola di lingua finlandese. Ciò deve vedersi come parte della più ampia crescita del movimento dei fennomani, un'espressione del nazionalismo romantico che sarebbe diventata una parte cruciale della produzione artistica e delle idee politiche di Sibelius. Morì nel 1957 a causa di un'emorragia cerebrale ed ebbe funerali di Stato.
Studiò ad Helsinki con Wegelius e l’italiano Busoni, poi a Berlino e a Vienna con Goldmark e nuovamente a Helsinki con Kajanus. Nel 1892 il successo ottenuto col poema sinfonico Kullervo ne fece il capo di un gruppo di giovani musicisti impegnati nello sviluppo della musica nazionale. Nello stesso anno divenne insegnante di composizione al conservatorio di Helsinki: nel 1900 una tournée della Filarmonica diretta da Kajanus, fece conoscere le sue musiche in Europa. Da allora, ottenuto dallo Stato uno stipendio annuo, si dedicò esclusivamente alla composizione stabilendosi nel 1904 a Järvenpää, presso la capitale. Nel 1927 cessò praticamente di produrre musica, circondato da un’enorme popolarità e da onori eccezionali, ma inesorabilmente tagliato fuori dai fermenti della nuova musica dodecafonica. Di tutta la sua vasta produzione hanno un certo rilievo le sette sinfonie e i poemi sinfonici ispirati all’antico epos finnico del Kalevala che lo collocano decisamente fra gli epigoni del sinfonismo tedesco tardoromantico ritornato alla luce dagli apporti della musica popolare finnica. Dotato di una sensibilità evocativa che lo accosta al norvegese Edvard Grieg nei vividi squarci di paesaggio nordico, e particolarmente felice nel delineare climi epici, e più incline del norvegese a convogliare la propria ispirazione in strutture compositive di vasto respiro non esenti e non sempre esenti da retorica. Accanto ad alcune sinfonie (terza, quinta e sesta) concepite secondo uno schema formale classico, lineare, misurato nei mezzi espressivi, altre (seconda, settima e i poemi sinfonici Una saga (1901), Finlandia (1899-1900); La figlia di Pohiola (1906); Pan und Echo, (1906-1909); Tapiola (1928) mostrano una costruzione più libera e complessa, basata su un’imponente e mobile elaborazione di motivi germinali alla maniera di Bruckner. E’ in tali composizioni che meglio si esprimono il suo temperamento fantasioso e rapsodico e le sue smaglianti risorse timbriche.
Scrisse ancora: un’opera teatrale: musiche di scena, fra cui quelle di Kuolema (La Morte 1903), dove si trova il celebre Valse triste, e altre come Karelia e Lemminkäinen (in cui vi è il famoso Cigno di Tuonela).
Jean Sibelius compose inoltre vari lavori sinfonici oltre ai citati: un concerto per violino e orchestra, diverse composizioni strumentali da camera (un quintetto, quartetti, trii, suonate ecc… e pianistiche; musiche corali d’ogni genere e molti Lieder.
*UNA NOTA CURIOSA
Per quanto riguarda i cognomi svedesi e nordici in generale, che finiscono in "-ius" come Wallenius, Linnaeus ed altri citati in questo articolo, la questione è interessante. Questi cognomi non sono tipicamente finlandesi, ma hanno spesso origini che possono risalire al latino. Ecco alcuni punti da considerare:
Origine Latina: Alcuni cognomi svedesi con la desinenza "-ius" possono effettivamente avere radici latine. Durante il Rinascimento e nei secoli successivi, era comune per persone colte, specialmente accademici e clero, adottare versioni latinizzate dei loro nomi. Questo fenomeno è avvenuto in molti paesi europei, inclusa la Svezia.
Influenza Finlandese: La Finlandia è stata sotto il dominio svedese per molti secoli e la cultura e i nomi svedesi hanno avuto un impatto significativo. In Finlandia, specialmente tra i finlandesi di lingua svedese, i cognomi latinizzati erano relativamente comuni, e questi potrebbero essere passati anche in Svezia.
Nomi Accademici: Nelle università e tra gli studiosi, era una prassi comune latinizzare i propri nomi. Ad esempio, un nome come "Andersson" potrebbe essere latinizzato in "Andersonius". Questo potrebbe spiegare alcuni cognomi con la desinenza "-ius".
Esempi di Cognomi: Wallenius è un esempio di cognome che può essere trovato sia in Svezia che in Finlandia e, come suggerisce, ha una connotazione latinizzata. Un altro esempio famoso è Linnaeus, il cognome latinizzato del celebre botanico svedese Carl von Linné.
In conclusione, i cognomi svedesi che finiscono in "-ius" spesso hanno radici che possono essere ricondotte a una tradizione di latinizzazione, comune tra studiosi e accademici, e possono anche essere influenzati dalla cultura finlandese-svedese. Questi nomi non sono di origine tipicamente svedese, ma riflettono un'interessante commistione culturale e storica.
PARCO SIBELIUS
Vicino al mare di Helsinki

Per le migliaia di visitatori che entrano nel parco ogni anno, è un posto meraviglioso per trovare un pezzo di natura, pace e cultura nel mezzo della capitale finlandese. Il sito è stato dedicato a "Jean Sibelius" - di gran lunga il più famoso compositore finlandese. In suo onore è stato eretto un monumento speciale di cui proponiamo alcune immagini.
Contesto storico e omonimo del Parco Sibelius
Jean Sibelius, nato come "Johann Julius Christian Sibelius", è una persona profondamente amata dai finlandesi ed è considerato un'icona della musica finlandese. Al musicista patriottico è sempre piaciuto incorporare la natura nelle sue opere. Gli elementi del compositore, il suo modo di vivere e di lavorare dovrebbero riflettersi nel Sibelius Park.
Un monumento come attrazione turistica
Il monumento è stato progettato dallo scultore Eila Hiltunen. Si estende su 8,5 x 10,5 x 6,5 metri ed è fatto di 24 tonnellate di acciaio. I 600 tubi sono saldati insieme in un modello a onda e sono caratterizzati da molti dettagli individuali. Come una canna d'organo sovradimensionata, il monumento si erge imponente nel verde. Accanto c'è una scultura della testa di Jean Sibelius. Secondo i racconti, la musica di Sibelius può essere ascoltata sopra l'organo quando soffia il vento.
Il Bellissimo parco
Il parco stesso è una calamita per molti cercatori di pace e amanti della natura. La sua bellezza è notevole. Una caffetteria proprio accanto all'acqua offre ai visitatori un luogo gradito per soffermarsi con disinvoltura davanti a un caffè e un dolce. Molti dolcetti come i panini alla cannella e la torta di mirtilli sono piatti popolari. L'atmosfera così vicina al mare emana una pace e una bellezza speciali. Il parco è un luogo popolare per gli intenditori d'arte.





Un suggerimento letterario:

Alessandro Zignani
JEAN SIBELIUS
Dei ghiacci e del fuoco. Vita e musica
PARTE TERZA
RAPALLO
CASA GARIBALDA
INTERVISTA A FILIPPO TORRE
DIRETTORE D’ORCHESTRA DEDICATA A JEAN SIBELIUS
Lungomare Vittorio Veneto – Rapallo
“Salotto buono” della città
E’ un punto caratteristico particolarmente suggestivo, dove il visitatore passeggia in riva al mare circondato da palme ed edifici di grande bellezza. Il lungomare è il centro di numerose feste ed eventi, soprattutto nel periodo estivo: da concerti ed eventi sportivi e religiosi. Si trovano qui diversi poli di interesse turistico, come il Chiosco della Musica, le statue monumentali e il castello cinquecentesco. Tra questi vi è anche la Casa Garibalda.
(vista dall’alto foto sotto)



La Casa Garibalda, dalle caratteristiche strisce bianche e grigie, oggetto di un accurato restauro terminato in questi ultimi anni. E’ uno dei palazzi più significativi dell’antico abitato rapallese, classificato anche come monumento nazionale

Nella sua facciata, lato chiosco della musica, lo stemma in marmo dell’ammiraglio Biagio Assereto ne indicherebbe la datazione al XIV secolo, mentre le case retrostanti porticate si debbono ritenere più antiche.
Le colonnine in marmo così come la decorazione a fasce bianche e nere impreziosivano l’edificio che nel XIX secolo e per molti anni seguenti accolse esercizi alberghieri ed anche un night nel giardino pensile. Una lapide all’esterno del complesso ricorda che tra gli ospiti dell’allora “Pensione Suisse” ci fu anche, nel 1901, il compositore Jean Sibelius, che qui compose la sua Seconda Sinfonia op.43. Sul palazzo di fronte, un’altra targa ricorda invece il soggiorno di Friedrich Nietzsche, che nel 1882, compose la prima parte di “Così parlò Zarathustra”.
Alcune immagini del lato di levante della Casa Garibalda



Il compositore finlandese Jean Sibelius soggiornò nel 1901 a Rapallo. Dall'8 al 12 Ottobre a Rapallo
“Finalmente ho trovato un luogo per soggiornare nel Mediterraneo...; un giardino pieno di rose in fiore, camelie, platani, cipressi, palme e mandorli fioriti; arance, limoni, mandarini...”
Così scriveva all'amico Axel Carpelan, annotando le prime impressioni (4 Febbraio 1901).
http://sib150.wix.com/festivalsibelius#!rapallo/cx5i
L'orchestra Sinfonica Jean Sibelius, fondata nel 2010, è intitolata al compositore finlandese Jean Sibelius che soggiornò a Rapallo (GE) nel 1901, componendovi la sua seconda sinfonia.


Il Direttore Musicale: Filippo Torre (nella foto) nasce a Rapallo (GE) il 29 maggio 1967. Intraprende gli studi musicali da giovanissimo, dedicandosi al mandolino e al pianoforte. In seguito, parallelamente agli studi di Fisica, frequenta il corso di Composizione presso la “Civica Scuola di Musica” di Milano. Dal 1992 al 1994 studia inoltre Direzione d’Orchestra con Ludmil Descev (direttore stabile dell’Opera Nazionale di Sofia). Ha successivamente approfondito diversi aspetti del repertorio sinfonico con il direttore polacco Bogusław Dawidow ed è stato assistente del direttore francese Emmanuel Villaume presso la Fenice di Venezia e il Regio di Torino.

Filippo Torre ha diretto l’Orchestra da Camera di Conegliano, l’Accademia Vivaldiana di Venezia, l’Orchestra da Camera di Sofia, la Filarmonica di Ploiesti, la Filarmonica Nazionale Siberiana e l’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius” in Italia, la Sinfonica di Schumen in Bulgaria, la Filarmonica di Tomsk e la Filarmonica della Carelia in Russia, la Filarmonica di Râmnicu Vâlcea in Romania, l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Musica di Basilea in Svizzera, la Sinfonica di Dnepropetrovsk e la Sinfonica di Zaporozhye in Ucraina, la Filarmonica di Opole in Polonia e la Filarmonica Janáček in Repubblica Ceca. Ha diretto inoltre l’Orchestra da Camera di Bruxelles, la Sinfonia Bucarest e la Chopin Chamber Orchestra nell’ambito di tournées italiane. Nel 2004 ha partecipato alla ventiduesima edizione del Festival dell’Arte e dell’Amicizia di Pyongyang dirigendo l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Corea del Nord.
Intervista a Filippo Torre, direttore dell’orchestra Jean Sibelius di Rapallo
di Enrico Tognon
– Nel salotto di casa mia, come tutti i martedì, mi incontro con Filippo Torre per lavorare sulla fisica e la matematica fatta in classe. Oggi però prima della consueta lezione sono curioso e incomincio a fargli qualche domanda sulla sua vita e nello specifico sul suo rapporto con la musica.
Filippo mi racconta che è laureato in fisica, con una grande passione per la musica, parte indissolubile del suo percorso di vita. Vista la disponibilità a parlare, intervengo con domande più specifiche.
Quando ti è venuta l’idea di dedicarti alla musica?
“Fin da piccolo ho avuto l’ispirazione, verso i 10-12 anni ho incominciato a pensare che la musica avrebbe lasciato un segno nella mia vita futura. Non ho deciso, però, subito che la musica sarebbe stata la mia futura professione; i miei studi sono diventati seri (sorride n.d.r.) quando, dopo essermi diplomato al liceo scientifico, e essermi iscritto a Fisica, intorno ai 21 anni ho iniziato a seguire con regolarità corsi propedeutici. In questo ambito ho conosciuto il mio maestro. Quando poi è venuto a mancare, mi sono sentito un po’ spaesato, perso, senza una guida che mi aiutasse nel difficile inizio di carriera; tuttavia non mi è mai mancata la voglia di fare musica, anzi è proprio in questo periodo che ho capito che la direzione d’orchestra sarebbe stata la mia strada. La carriera come del resto la vita è una strada tortuosa; la mia si era interrotta per un periodo, però nel 2008, grazie alla collaborazione con “Rapallo Musica” ho avuto la possibilità di ritrovare un ambiente favorevole, e due anni dopo è nata la prima orchestra sinfonica di Rapallo: “Jean Sibelius”.
La luce soffusa del pomeriggio di inizio primavera crea un’ atmosfera di amicizia, tanto che il manuale di fisica rimane quasi nascosto nell’ombra della finestra. A cuor leggero decido di andare avanti con le domande.
La fisica come ha influenzato la tua carriera musicale?
“Aver studiato fisica mi ha aiutato nel modo di pensare la musica, che è un mondo molto razionale, preciso, tecnico, senza però che questi aspetti condizionassero la mia vena artistica.”
Proprio adesso il campanello suona, è Lorenzo, il mio fido compagno di studio che si appresta a lavorare con noi sull’ottica geometrica, ricordandomi l’imminente verifica, ahimè.
Filippo continua definendosi uno strano esemplare in cui gli aspetti di razionalità e creatività coesistono. “Credo”, aggiunge, “che la fisica sia la scienza che più risponde alle domande che l’uomo si è sempre posto, e sono contento di potere trasmettere quotidianamente ai miei alunni la passione per questa grande scienza”.
Rimpiangi di non avere studiato fin da subito musica?
“Sì, avrei potuto affinare alcune attitudini giovanili, ma non mi preoccupo ormai più: un musicista prima di tutto è una persona con la sua cultura, la sua storia e il suo carattere. Per fare bene il mio mestiere non bisogna aver fatto solo esperienze di carattere musicale, ma essersi confrontati con i diversi ambiti del sapere”.
Quale consiglio dai a dei giovani che si approcciano al mondo “adulto”?
“L’importante credo che sia non disperdere le proprie forze su troppi fronti, però le passioni extrascolastiche ci arricchiscono e specialmente in questo periodo storico, servono per fare le persone più motivate e felici”.
Al termine della nostra chiacchierata io, Filippo e Lorenzo ci guardiamo, lo ringrazio per la disponibilità, e come di consueto il nostro maestro: “Fisica eh? Siete mica sotto verifica?”. Ed è proprio in questo momento che realizzo che devo “mangiare ancora molta pastasciutta”, e ci buttiamo subito nei calcoli dei complicati esercizi.
Biagio ASSERETO
L’AMMIRAGLIO CHE CATTURO’ DUE RE
NATIVO DI RECCO, SUO NONNO VENIVA DA RAPALLO
https://www.marenostrumrapallo.it/biagio/
Carlo Gatti
LA RAPALLO DI ALTRI TEMPI …
LA TAVERNA AZZURRA
https://www.marenostrumrapallo.it/la-rapallo-di-altri-tempi-la-taverna-azzurra/
Carlo Gatti
27 APRILE 1846
LA PRIMA NAVE DA CROCIERA ATTRACCA A RAPALLO
S/S LALLA ROOKH
https://www.marenostrumrapallo.it/27-aprile-1846-la-prima-nave-da-crociera-attracca-a-rapallo-s-s-lalla-rookh/
Carlo Gatti
A cura di
Carlo GATTI
Rapallo, Mercoledì 10 Luglio 2024
IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA -
IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA
LA REPLICA RECA CON SE'
ECHI EVANGELICI DAL MARE DI GALILEA

«È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta». (P.Giordani)

Il 15 marzo 2023 - Papa Francesco ha benedetto la simbolica costruzione, ricevuta in dono dalla famiglia Aponte, armatori di Nlg – Navigazione Libera del Golfo, con la collaborazione e il supporto dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma.

Nella foto, da sinistra a destra, rivolti verso Papa Francesco, i coniugi Aprea, il direttore di NLG Maurizio Aponte e il presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, Paolo Giordani.
Il Papa ha disposto che nei MUSEI VATICANI venga collocata la copia di una imbarcazione di duemila anni fa
La riproduzione perfetta della barca da pesca
L’opera è stata realizzata dagli APREA, storica famiglia di maestri d’ascia della penisola sorrentina, dopo approfonditi studi archeologici con la partecipazione di esperti della marineria antica. In particolare, gli artigiani hanno utilizzato la tecnica dei “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi). Una tecnica importata dall’area mediterranea, operante già dal secondo millennio a.C.
Benedicendo l’imbarcazione prima dell’udienza generale, il Santo Padre ha sottolineato come quella ricevuta sia ‘la barca di tutti’, una frase che attesta la coerenza di un uomo che fin dalla sua elezione ha dimostrato una particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato.
YouTube
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/eventi-e-novita/iniziative/Eventi/2023/barca-di-pietro-approda-nei-musei-vaticani/video-barca-pietro.html
L’imbarcazione è la fedele “replica” - Made in Italy - dell’antico e originale peschereccio di Pietro venuto alla luce nel 1986 dalla melma del lago di Tiberiade in occasione di un improvviso abbassamento delle acque, e custodito nel museo Yigal Allon di Ginosar, luogo indicato dai Vangeli quale sede principale delle predicazioni di Gesù in Galilea di cui ci occuperemo tra breve.

L’imbarcazione è stata sistemata alla base della rampa elicoidale dei musei Vaticani
(come mostra la foto sopra)
La Barca di Pietro accoglie, con la sua forte carica spirituale, pellegrini e turisti di tutto il mondo nella “Casa di tutti”, secondo un’espressione cara a Papa Francesco, Timoniere della Chiesa e instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse.
La Barca di Pietro simboleggia quindi la Chiesa che è guidata dai suoi successori. Gesù invita i discepoli esitanti e dubbiosi a salpare, confidando in Dio. Allo stesso modo, la Chiesa deve misurarsi con le tempeste e le difficoltà del mondo per diffondere l’annuncio del Vangelo della Grazia.
La Barca di Pietro non è più soltanto una metafora
Il dono che la famiglia Aponte, gli armatori di NLG-Navigazione Libera del Golfo ha voluto fare, con la collaborazione dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma, al Santo Padre, “instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse”, come ha spiegato Paolo Giordani, presidente dell’IDI, la cui “particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato” corrisponde pienamente all’”antica legge del mare”. Non per caso il Papa, accettando il dono, l’ha definita “la barca di tutti”.
I Dettagli marinareschi spiegati da APONTE:
L’imbarcazione è una replica perfetta di quella conservata nel museo israeliano come doveva essere ai tempi di Gesù:
scafo: di 8,8 metri x 2,5,
albero: di 8 metri con pennone di 6,
due piccole coperte: a proravia e a poppa
velatura: vela quadra e cavi in fibra di canapa
governo: due timoni
equipaggio, in grado di trasportare fino a quindici persone.
materiale di costruzione: cedro e quercia
tecnica usata: “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi).
Una tecnica importata dall’area mediterranea, in vigore dal secondo millennio a.C. fino all’epoca bizantina esclusa, applicata non su un materiale ligneo unico, ma su materiali misti: cedro, quercia.

Nave EUROPA – graffito
Per le parti andate perdute, gli artigiani sorrentini si sono ispirati ai mosaici del piazzale delle Corporazioni di Ostia, al graffito della nave “Europa” di Pompei, al bassorilievo con veduta del Portus Augusti (collezione Torlonia).
“Desideriamo ringraziare - ha sottolineato Maurizio Aponte, direttore di NLG - Un grazie di cuore va al Governatorato dello Stato Città del Vaticano, che ha mostrato interesse per il progetto e ci ha consentito di realizzarlo, e all’Istituto Diplomatico Internazionale, che ha collaborato nella fase di ideazione e presentazione. Tutti ci auguriamo che il modello della Barca di Pietro possa regalarci nuove emozioni” – ha concluso il direttore di NLG.
“Con questo omaggio al Sommo Pontefice dopo dieci anni di ministero – ha dichiarato P.Giordani – abbiamo voluto dare corpo ad un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La Barca di Pietro che consegniamo oggi non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione. È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta”.
In particolare, viene ricordato l’episodio della tempesta sul lago narrato da Marco (4,38). “Mentre i discepoli erano nel panico perché imbarcavano sempre più acqua, Gesù – dice l’evangelista – se ne stava a poppa e, adagiato sul cuscino, dormiva. Lo svegliarono a furia di grida d’aiuto e lui, destatosi, comandò al mare»: «Taci! Calmati!» (Marco 4,39) «e le acque si placarono» (Luca 8,22-25).
“Sempre il Lago di Tiberiade - rammenta Giordani - fu testimone di un'apparizione pasquale di Gesù risuscitato. Dalla riva suggerì ai discepoli, estenuati per la notte passata senza pescar nulla, di calare la rete dalla parte destra della barca. In questa maniera pescarono una gran quantità di pesci e compresero che lo sconosciuto era il “Messia”. Pietro poi si tuffò per raggiungerlo e Gesù gli disse: «adesso pasci le mie pecorelle». “Questo dialogo è considerato come il momento in cui Gesù affida a Pietro la Chiesa (Giovanni 21,1-19) - commenta il presidente dell’IDI - È da questo testo che fu attinta l’immagine della chiesa come “Barca di Pietro”.
L’apostolo infatti sottolineava che: «se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il secondo timoniere».
Aggiunge Giordani: “Durante la pandemia da Covid-19, rivolgendosi al mondo costretto ad affrontare con dolore e sacrifici un momento storico così drammatico, il Papa, timoniere della Chiesa, ci aveva fatto sentire costantemente la sua vicinanza attraverso la preghiera, dandoci la certezza che ‘Dio non ci lascia in balia della tempesta’. Ebbene, con questo omaggio al Sommo Pontefice, dopo dieci anni di ministero, abbiamo voluto dare corpo a un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La ‘Barca di Pietro’ che consegniamo non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione”.
Il Papa ha risposto con un sorriso: “La barca di tutti…” e sarà meta di pellegrinaggio, di “nuovi pesci da portare sulla riva del Signore”.







Lago Tiberiade - Mar di Galilea
Il RELITTO originale dell’imbarcazione di Pietro fu ritrovato nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade
Chi scrive, nel 2000 andò con la famiglia in Israele.
Il nostro pellegrinaggio iniziò dal Lago di Tiberiade, dove tutto cominciò…
Giuseppe Flavio (Guerra giudaica, III,7) lo descrisse così:
«Il lago di Gennesar prende il nome dal vicino territorio. Misura 40 stadi in larghezza e 140 in lunghezza. Le sue acque sono dolci ma non buone da bere. Esse sono più leggere della pesante acqua di palude, e limpide perché le sue rive sono formate da ghiaia e sabbia; ha inoltre una temperatura mite: è meno fredda di quella di un fiume o di una sorgente, ma comunque più fresca di quanto si immagini, vista l'estensione del lago. Al centro di esso scorre il Giordano, che sembra nascere dal Panion, mentre in realtà giunge al Panion attraverso un percorso sotterraneo, e nasce invece dal bacino di nome Fiale, che si trova a 120 stadi da Cesarea, sulla destra, non molto distante dalla strada che porta alla Traconitide. [...] Non si sapeva che nascesse dal Giordano fino a quando non fu dimostrato da Filippo, tetrarca della Traconitide. Egli, gettando nella Fiale della paglia, la ritrovò trasportata al Panion, dove nell'Antichità si credeva nascesse il Giordano.
Tra i tanti YouTube che ho visionato, questo che vi propongo in visione è il migliore per chiarezza, bellezza e informazioni culturali geografiche-storiche ed Evangeliche.
Il mare di Galilea chiamato il lago di Gesù
di
Adrea Candore
https://www.youtube.com/watch?v=tUyoB-wObME
Le cartine orientative
Lago di Tiberiade




Il kibbutz di Ginnosar sul lago di Tiberiade e la scoperta della “barca di Gesù”
del prof.Giancarlo Biguzzi
https://www.gliscritti.it/approf/2007/papers/barca_gesu.htm

Il relitto originale, ben conservato grazie al fango del fondale che ricopriva le strutture lignee dello scafo, è stato datato alla seconda metà del I sec. A.C. dall’esame del Carbonio 14. Si tratta quindi di un battello a vela lungo 8,8 metri x 2,5 metri con un albero di 8 metri, risalente con ogni probabilità proprio all’epoca della predicazione di Gesù. L’imbarcazione, particolarmente adatta per la pesca costiera, poteva ospitare quattro rematori e circa una dozzina di persone. È plausibile quindi che il relitto del Lago di Tiberiade appartenga alla medesima tipologia della barca di cui raccontano gli evangelisti Luca (5,1-11) e Marco (4,35-41).
Il prezioso reperto è in mostra al centro Ygal Allon nel museo di Ginosar in Galilea (Israele), un museo che permette ai turisti di osservare da vicino questa semplice imbarcazione datata 40 avanti Cristo grazie a un test a radiocarbonio effettuato alla fine degli anni ottanta quando fu rinvenuta coperta da fango e melma nel lago di Tiberiade.
Gli archeologi riferirono subito che si trattava della tipica imbarcazione che usavano i pescatori ai tempi di San Pietro. Naturalmente non vi erano evidenze di sorta che si trattasse dell'imbarcazione dei Vangeli anche se l'umile costruzione lignea non ne diminuiva il valore archeologico.
CURIOSITA’ TECNICHE DELL’IMBARCAZIONE ORIGINALE
Dal sito: ![]() BibleWalks 500+ sites
BibleWalks 500+ sites
L’imbarcazione è stata datata, con il carbonio 14, intorno al 40 a.C. (più o meno 80 anni), o dal 50 a.C. al 50 d.C. sulla base delle ceramiche (tra cui una pentola ed una lampada) e dei chiodi ritrovati all’interno della barca. Questo fa ipotizzare che l’imbarcazione possa quindi risalire al tempo di Gesù Cristo. In effetti, si adatta alle molte descrizioni di barche delle Sacre Scritture, come quella nel Vangelo di Luca. Lunga 27 piedi e larga 7,5 piedi, la barca era costruita con dieci diversi tipi di legno e doveva consentire la pesca vicino alla riva. La tecnica costruttiva della barca risultò conforme altre barche costruite in quella parte del Mediterraneo tra il 100 a.C. e il 200 d.C. L’imbarcazione era stata costruita principalmente con assi di cedro, unite insieme da giunti e chiodi a mortasa e tenone fissati, adatta a navigare su bassi fondali grazie ad un fondo piatto, che le consentiva di avvicinarsi molto alla riva durante le operazioni di pesca. Gli archeologi hanno scoperto che la barca era stata costruita con dodici diversi tipi di legno, il che suggerisce diverse ipotesi: una carenza di legno o una costruzione in economia, fatta con legni di scarto, oppure che la stessa aveva subito riparazioni estese e ripetute. Delle 113 assi del fasciame della barca, 105 (92%) erano di cedro e uno di pino, entrambe conifere locali. Curioso il fatto che su 60 assi di quercia, 45 (75%) erano costituite da rami non lavorati. L’utilizzo del legno di conifere per le assi e di legno di latifoglie, di solito il rovere, per le intelaiature interne, era una pratica comune ed è seguito anche oggi nella costruzione di barche. Un interessante studio sulle tipologie di legno utilizzate può essere letto su questo sito.
La barca di pescatori era dotata di un albero, e quindi poteva alzare una vela, e aveva posto per quattro rematori sfalsati. Le sue dimensioni avrebbero permesso di trasportare 13 persone … Ovviamente, non c’è modo di sapere se questa particolare barca ebbe realmente un ruolo negli eventi raccontati nella Bibbia ma le sue strutture marinaresche trovano conferma in quanto raccontato nei libri sacri.
LA TEMPESTA SUL LAGO DI TIBERIADE (MARE DI GALILEA)

“Cristo nella tempesta sul mare di Galilea”
Rembrandt
Così si legge nel Vangelo di Matteo
« Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva.Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia.
|
Così si legge nel Vangelo di Marco
È interessante che, pur essendo un lago, l’evangelista Marco preferisca chiamarlo “mare”, a motivo della grandezza e della sua pericolosità, infatti spesso è battuto da venti che rendono difficile la navigazione.
La barca nella tempesta
Il Signore è a poppa, nella parte poppiera della barca, quella che affonda per prima; e dorme appoggiato ad un cuscino (Mc 4,38). La tempesta che incontra la barca non sveglia Gesù, sarà il cuore angosciato dei discepoli a far tremare la barca: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (v. 38). Di questa mancanza di fede è preoccupato Gesù.
Immaginiamo lo scompiglio su quella barca! Ma quale è il vero rischio di perdersi? Gesù non risponde alla domanda dei discepoli, ma, placato il vento e le acque, sarà lui a sollevare la domanda vera: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (v. 40).
Il mare non è una forza autonoma, come non lo è il Male, seppur ha una sua inspiegabile libertà di agire, come ci istruisce il testo “sapienziale” di Giobbe nella prima lettura: “Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso?” (Gb 38,8). C’è un limite invalicabile posto dal Signore, che è creatore e redentore: “Fin qui giungerai e non oltre, e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde” (v. 11).
La fede messa alla “prova” dal mare
L’immagine del mare, da sempre, rappresenta nella Bibbia una prova di fede.
Il popolo d’Israele liberato da Mosè è costretto a fermarsi davanti al Mar Rosso, apparentemente invalicabile. L’esercito egiziano incalza alle spalle ed è ormai vicino: “Non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto”? (Es 14,11). Con queste parole ricolme di angoscia, il popolo si rivolge a Mosè. E lui: “Non abbiate paura! Siate forti. Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli” (v. 13).
HO CHIESTO A DIO: PERCHE' MI HAI PORTATO SULLE ACQUE AGITATE?
MI HA RISPOSTO: PERCHE' I TUOI NEMICI (i demoni) NON SANNO NUOTARE ...
Papa: "siamo tutti sulla stessa barca"
Questo brano ci ricorda il momento straordinario di preghiera indetto da Papa Francesco il 27 marzo 2020, nel contesto della pandemia. Risuonano ancora le sue parole: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”.
Risulta essenziale la presenza del Signore. Con un rischio: che ognuno lo vorrebbe collocato secondo i propri schemi, alla guida, di vedetta, a rassicurare ognuno, ad evitare gli ostacoli… Ma il Signore è invece al suo posto e compie la sua opera. Lo aveva anticipato nelle parabole: il seme una volta gettato, non va perduto. “Dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce” (Mc 4,27).
Su questa barca con Gesù, che è la Chiesa
Con queste parole l’orazionale descrive la “via santa”, una vita non gettata nel nulla, non abbandonata a sè stessa.
Sulla barca della vita permane la presenza silenziosa ma efficace del Signore: “Taci, calmati!” (Mc 4,39). Al momento opportuno il Signore interviene, calma le acque e il vento, come ordina al male di non nuocere più.
Su questa barca, che è la Chiesa, possiamo attraversare sicuri il mare della vita; e la nostra fede, seppur debole e ferita, può ristorarsi alla “fonte” dei sacramenti.
La nostra fede poggia sicura sulla fede di Pietro e della Chiesa di Cristo. Lo ricorda il sacerdote nella celebrazione eucaristica: “Signore, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”.
PERCHE' GESU' SCEGLIE I PESCATORI
Lo spiega Sant’Agostino. Discorso 250
Dio preferisce i deboli e i poveri di questo mondo.
-
Il Signore Gesù ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti 1, sicché, volendo adunare la sua Chiesa da ogni parte del mondo, non cominciò con degli imperatori o senatori ma con dei pescatori. Se infatti fossero stati scelti in principio personaggi altolocati, essi avrebbero attribuito la loro scelta a se stessi e non alla grazia di Dio. Questo modo di procedere di Dio, a noi occulto, questa disposizione del nostro Salvatore ce la espone l'Apostolo quando dice:Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Sono parole dell'Apostolo. Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Poiché non molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti, e le cose ignobili e spregevoli del mondo ha scelto Dio, e le cose che non hanno consistenza - come se la avessero - per annichilire le cose dotate di consistenza; affinché nessun uomo possa vantarsi dinanzi a lui 2. La stessa cosa aveva detto il profeta: Ogni valle sarà colmata, e ogni monte e ogni colle sarà abbassato, perché si ottenga una pianura senza dislivelli 3. Veramente, oggi partecipano della grazia del Signore senza distinzione nobili e plebei, dotti e ignoranti, poveri e ricchi. Quando si tratta di ricevere questa grazia non avanza diritti di precedenza la superbia rispetto all'umiltà di chi nulla sa e nulla possiede 4 e nulla può. Ma cosa disse loro? Venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini 5. Se non ci avessero preceduto quei pescatori, chi sarebbe venuto a pescarci? Al giorno d'oggi uno è gran predicatore se riesce a presentare bene quello che ha scritto il pescatore.
Mescolanza di buoni e cattivi nella Chiesa terrestre
-
Il Signore Gesù Cristo scelse dunque dei pescatori di pesci e ne fece dei pescatori di uomini. Col fatto stesso del pescare poi volle darci degli ammaestramenti nei riguardi della chiamata dei popoli. Notate come le pesche furono due e come occorra distinguerle e separarle. Una fu quando il Signore scelse gli Apostoli e da pescatori li rese suoi discepoli 6; l'altra è quella che abbiamo ascoltato ora quando si leggeva il santo Vangelo, quella cioè che avvenne dopo la resurrezione del Signore Gesù Cristo. L'una dunque prima della resurrezione, l'altra dopo la resurrezione. E dobbiamo sottolineare con molta attenzione la differenza fra le due pesche, poiché questa duplice pesca è una nave piena di istruzioni per noi.
Almeno 4 erano pescatori di mestiere:
Simon Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo…
Non sono menzionati tutti i loro mestieri. Pietro e Andrea erano pescatori, probabilmente anche altri. Matteo era in esattore di tasse, Paolo fabbricava tende per mantenersi quando predicava ma a Gerusalemme era stato educato dal dotto fariseo Gamiliele. Sapeva parlare greco ed ebraico. Nonostante Matteo avesse molta esperienza riguardo il denaro e i numeri, furono affidate a Giuda le finanze e per questo si presume che avesse una certa istruzione. Tutti comunque si mantenevano con il loro lavoro.
Invece gli apostoli non credevano per fede, ma perché avevano incontrato e mangiato insieme a Gesù per 40 giorni dopo la sua morte.
Gesù appare ai pescatori
https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/libri/impariamo-racconti-bibbia/13/gesu-appare-ai-pescatori/
PIETRO Apostolo, santo
TRECCANI
https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-pietro-apostolo_(Enciclopedia-Italiana)/
https://www.culturacattolica.it/cultura/storia/storia-della-chiesa/il-primo-sbarco-dell-apostolo-pietro-in-italia
Tra gli scritti cosiddetti pseudo-clementini (preziosa fonte per gli studiosi dei primi secoli), composti poco dopo il 200 d.C., vi è un’opera denominata Viaggi di Pietro, che era stata adottata dai giudei ebioniti. Gli ebioniti credevano sia nell’ebraismo sia in Gesù come Messia (atteggiamento ancora oggi presente tra le migliaia di ebrei messianici d’Israele), e facevano riferimento ad un vangelo di Matteo rielaborato, ed anche all’opera Viaggi di Pietro. E’ da questo testo che fu attinta l’immagine della Chiesa come “Barca di Pietro”, perché l’apostolo ci teneva a sottolineare che, se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il “secondo timoniere”.
MARINAI E FEDE
https://www.marenostrumrapallo.it/cri/
Carlo GATTI
Rapallo, 26 Giugno 2024
UNA GITA A LUNI
UNA GITA A LUNI
Eravamo negli Anni ’70. La nostra famiglia, di origini-semi vichinghe, aveva due figli alle scuole elementari e due alle medie. Senza dare spiegazioni, neppure a mia moglie Guny, imboccai l’autostrada verso Sud e dissi: “oggi vi porto sulla luna!”
Mi girai di scatto e vidi dei volti sorridenti ma un po’ preoccupati per il mio stato di salute… “Mi correggo, vi porto al sito archeologico di Luni e c’è un motivo storico-culturale che potrebbe interessarvi. Forse si tratta di una leggenda, ma sono ancora in tanti a parlarne. Chissà che non sia vera! -
Google la dà per vera e tra poco ce la racconterà in poche righe ….”
Ne seguì un coro: “dai raccontacela prima tu!”
C'era una volta …. un nome che infiammava l'immaginazione e i sogni degli uomini del Nord: ROMA. Per loro, Roma rappresentava il sole, la luce, la ricchezza e la potenza. Sognavano di conquistarla e farla loro.
Un giorno, Hasting, un feroce vichingo norvegese, radunò tutti i capi delle tribù e disse: "Seguitemi e vi prometto che conquisteremo Roma, la magica città sarà nostra."

Dopo mesi di navigazione, la flotta normanna arrivò alle rive dell’alto Mar Tirreno. E lì, vicino al mare, apparve una città con marmi bianchi che brillavano al sole. Archi, torri e mura erano tutte di marmo. Non c'era dubbio: quella doveva essere Roma, la città eterna.
Solo Roma poteva permettersi il lusso di costruire tutto con il marmo, perfino le mura! "All'assalto!" gridò Hasting. "Ognuno di voi tornerà in patria come un eroe!"
I vichinghi si lanciarono all'attacco con violenza inaudita, ma furono respinti ogni volta. Gli assediati erano troppo valorosi.
Hasting allora pensò di usare l'astuzia. Mandò un messaggero in città con una richiesta: "Il mio capo è stato gravemente ferito nell’ultimo assalto e sta per morire. Prima di lasciare questa terra, vuole convertirsi alla vostra fede e ricevere il battesimo. Permettetegli di essere trasportato in barella entro le mura e di essere battezzato nella vostra cattedrale."
Come potevano rifiutare una simile preghiera? I cittadini, mossi a compassione, accettarono.
E così, la barella con Hasting fu portata verso la città. I portatori, con visi tristi e dolenti, avanzavano lentamente. Ma nei loro occhi si vedeva una scintilla feroce: sapevano che sotto il giaciglio era nascosta una spada.
Finalmente, la barella fu posta davanti alla cattedrale. I portatori si fermarono per un attimo di riposo...

Proprio in quel momento, all'improvviso, Hasting saltò su dalla barella, afferrando la sua spada nascosta. Con una rapidità incredibile, cominciò a colpire i cittadini sorpresi. La confusione fu tale che la città venne rapidamente conquistata e saccheggiata, senza che gli abitanti potessero difendersi. I vichinghi presero tutto ciò che potevano, lasciando dietro di sé morte e distruzione tra i magnifici edifici di marmo.
Convinti di aver conquistato la grande Roma, i barbari si ritirarono, portando con sé il bottino. Ma, sorpresa delle sorprese, quella splendida città non era Roma. Era Luni, una meravigliosa città costruita con il marmo bianco, un capolavoro dell'architettura etrusca e romana. Luni, la grande, la ricca, la splendida Luni.
Oggi, di quella magnificenza, rimangono solo poche rovine coperte di terra poco a sud della Spezia. Eppure, nei paesi freddi del Nord, durante i lunghi mesi invernali, i bambini ascoltano ancora la storia di Luni: una storia che sembra una leggenda. La leggenda della grande città che, per la sua straordinaria bellezza, imponenza e ricchezza, venne scambiata per Roma.
Così, ragazzi, la prossima volta che sentite parlare di un’avventura incredibile, ricordate la storia di Luni. Non tutte le leggende sono inventate, e qualche volta, ciò che sembra troppo bello per essere vero... lo è davvero.
Leggiamo insieme il parere di Wikipedia:
Hasting: Hástein Ragnarsson (scritto anche come Hastein Haesten, Hæsten, Hæstenn o
Hæsting o Alsting).
Fu un capo vichingo Norvegese della fine del IX secolo, appartenente alla dinastia di Muns Munsö, che guidò numerose spedizioni di razzia.
https://it.wikipedia.org/wiki/Hastein
Hastein e Björn passarono l'inverno su un'isola in Camargue, alla foce del Rodano prima di razziare Narbona, Nìmes e Arles, per poi dirigersi a nord a Valence e poi, lungo la costa ligure, in Italia. Qui attaccarono LUNI, grande città collocata all'estremità sudorientale dell'attuale regione Liguria.
Credendo erroneamente (a causa del lusso visibile) che Luni fosse nientemeno che Roma, Hastein decise di saccheggiare la città con ogni mezzo. Davanti a Luni Hastein si fece portare dai suoi uomini alla porta, dove chiese alle guardie di farlo entrare perché, prossimo alla morte, avrebbe desiderato convertirsi al cristianesimo. Una volta all'interno, fu portato alla chiesa cittadina dove ricevette i sacramenti, prima di saltare fuori dalla barella e condurre i suoi uomini al saccheggio della città. Secondo un'altra storia avrebbe voluto convertirsi prima di morire, e il giorno seguente avrebbe finto la morte. La città concesse a 50 dei suoi uomini di entrare in città per la sepoltura, tutti armati sotto i vestiti. Hastein saltò fuori dalla bara decapitando il religioso per poi saccheggiare la città. Una volta razziata Luni, saccheggiò Pisa e, una volta risalito l’Arno, razziò anche Fiesole. È probabile che la flotta abbia poi fatto rotta verso L’impero Bizantino nel Mediterraneo orientale.
Area archeologica di Luni | In volo sull'archeologia italiana
https://www.youtube.com/watch?v=FHuNkBUtZ9w&t=112s

La città di Luni si trova sulla riva sinistra del fiume Magra fondata come colonia romana nel 177 a.C., per il controllo dei territori conquistati ai liguri Apuani.
La colonia di Luni fu fondata dai Romani nel 177 a.C., per stabilirvi un posto avanzato contro i Liguri Apuani, ai quali avevano faticosamente strappato quel territorio. Il nome della città deriverebbe da una dea primitiva italica o dalla forma a falce del porto cittadino.

La freccia rossa verticale (foto in alto) indica l’uscita di Carrara, in direzione SUD, per visitare il Museo Archeologico Nazionale e le vestigia dell'antica colonia romana di “Portus Lunae”, ANTICA LUNI, dal cui porto salpavano navi cariche di marmo, oggi detto di Carrara, utilizzato per la costruzione dei più importanti monumenti della Roma antica.
La distanza (autostrada) Rapallo-Carrara è di 91,61 km
Il tempo di percorrenza medio è di 1 ora e 11 minuti
UNA NOVITA’

Sia l'area di sosta in direzione sud sia quella in direzione nord prevedono anche il passaggio nel tunnel multimediale Luni Experience dove, attraverso una sequenza di proiezioni e suoni, si può ripercorrere la storia dell'antica colonia romana dal cui porto salpavano navi cariche di marmo, oggi detto di Carrara, utilizzato per la costruzione dei più importanti monumenti della Roma antica.
"Non molti sanno che percorrendo la A12 tra Sarzana e Carrara si passa vicino a un sito archeologico di straordinaria importanza, l'antica città di Luna - ha detto Alessandra Guerrini, direttore regionale Musei Liguria -. L'intervento di SALT ci offre un esempio innovativo di come può svilupparsi una collaborazione tra un'infrastruttura viaria e il mondo della cultura. L'invito ai viaggiatori a fermarsi per conoscere il territorio, muovendosi a piedi a partire dall'autostrada, è un modo inedito per arricchire il percorso, trasformando il senso del viaggio. Un'esperienza di cui siamo felici - ha concluso -, resa possibile grazie alla sinergia tra privato e pubblico, che consente di valorizzare e rendere sempre più accessibile a tutti il patrimonio culturale".
La fondazione di una colonia romana in questa zona indica che il territorio era assai importante dal punto di vista strategico, militare e commerciale. L'accorta politica romana prevedeva il trasferimento di intere famiglie in tali zone, per lo più veterani di guerra, ai quali venivano concessi appezzamenti di terreno con diritto ereditario. Così avvenne anche per Luni.
Per quanto riguarda la “geografia” di questa zona c’è tuttora un po’ di confusione, e per dipanarla, mi rivolgo a Wikipedia:
A livello amministrativo, la Lunigiana è composta solamente dai comuni toscani. Fortunatamente, la Lunigiana storica è ancora oggi caratterizzata da una profonda unità culturale, viva nei dialetti, nei costumi, nelle tradizioni e nella cucina, che valicano i confini amministrativi tra Toscana e Liguria.
D’altronde a Ortonovo, in provincia della Spezia si trovano i resti dell’antica Luni, da cui trae il nome la Lunigiana.
Oggi si può finalmente affermare che LUNI si trova in Liguria, in provincia di LA SPEZIA!
Questa confusione viene dal passato, da decisioni prese contro la logica dell’unità dei popoli. Nel 1844 esistevano tre Lunigiane, parmense, con Pontremoli e Bagnone, modenese con Fivizzano, Aulla, Licciana, Massa e Carrara e una sarda con Sarzana, La Spezia e la Val di Vara. Con l’unità d’Italia, nel 1859, si creavano la provincia di Massa e Carrara con la val di Magra, e la provincia di Genova con La Spezia e la Val di Vara, spaccando così in due il territorio della Lunigiana storica. Nel 1923 nasceva la provincia della Spezia, con l’attuale territorio amministrativo, lasciando definitivamente la Lunigiana tra due provincie e tra due regioni.

Attraverso Parma e la Lunigiana passa, infatti, il corridoio più rapido che avvicina Roma al nord Europa e viceversa. E’ il tracciato seguito 2200 anni fa dal console Marco Emilio Lepido, che dopo aver fondato Parma fonda anche la città ed il porto di Luni
MAPPA DEL PORTO DI LUNI
Portus Lunae: certezze e incertezze. Indizi, disegni, mappe, prove
https://www.archeominosapiens.it/portus-lunae-certezze/
Tanti ed anche nuovi indizi, certamente non tutti attendibili, per questa storia che viene da lontano.
Le prime ricostruzioni ambientali avevano a disposizione le affermazioni degli Autori Classici che non sempre sono apparse coerenti fra loro o con i tempi di riferimento. Una fra tutte la descrizione del grande porto di Luni esistente prima della fondazione di Luni, che avrebbe accolto la flotta romana in partenza per la campagna di Spagna. In seguito, la necessità di un nuovo porto, importante, commerciale è emersa, ma solo a seguito dell’industria del Marmo Apuano.
Poi l’avvento delle cartografie, sempre più influenzate dalla geometria e dalla topografia. Fino alla ricerca delle nuove motivazioni ed informazioni deducibili dalla geologia, ma soprattutto dalla geomorfologia, dalla petrografia (dei materiali), della tettonica, della sismologia, etc. Finalmente, in tempi recenti, sono giunte in aiuto le indagini geotecniche di corredo agli interventi edilizi e le campagne geofisiche e, soprattutto, quelle di carotaggio continuo, alcune ancora allo studio, che porteranno certamente nuove indicazioni, soprattutto dirette.
La soluzione più plausibile ad oggi relativamente al Portus Lunae? Probabilmente è quella che prevede l’esistenza di diversi approdi prossimi alla Città, raggiungibili attraverso canali protetti dall’ambiente lagunare, dunale e retrodunale.
Poi un porto mercantile, marmifero, che l’ambiente naturale, l’economia industriale ed il buonsenso vedono prossimo al Bacino Marmifero Apuano.
Molti indizi, ma mancano ancora le prove strettamente archeologiche.

Luni: una possibile via dei marmi prima dell’avvento industriale del Marmo Lunense (Apuano). Da DEL SOLDATO, 2021.

La zona portuale. A sinistra si nota la scritta “Vestiggie del Molo” ed indicano il tracciato del fiume MAGRA che scende verso la sua foce.
Segnalo: MUSEO NAZIONALE E ZONA ARCHELOGICA - LUNI
https://www.archeominosapiens.it/portus-lunae-certezze/
Cliccando (sotto) su ogni indicazione specifica, potete percorrere il sito archeologico in tutte le sue sezioni egregiamente documentate e mostrate con meravigliose immagini.
-
VISITA
-
L’ANTICA CITTà DI LUNA
-
AREA ARCHEOLOGICA
-
COLLEZIONI
-
IL MUSEO
-
PERCORSI
-
SERVIZI EDUCATIVI
-
NEWS ED EVENTI
-
PUBBLICAZIONI
-
COME FARE PER…
-
Media
Anfiteatro di Luni

Fu costruito nel suburbio orientale della città, secondo l'orientamento della ripartizione agraria che in età augustiana sostituì quella traccia all' atto di fondazione della colonia. Sorge a circa 250 metri dalla Porta Orientale, lungo la via Aurelia. L'asse maggiore m 88.50, l'asse minore misura m 70,20.











CAPITELLO DI PILASTRO (vedi descrizione nell’apposita bacheca)
SCOPRI LA STORIA DELLA CITTÀ DI LUNA
La colonia romana di Luna che ha avuto una vita lunga più di mille anni. I Romani iniziano ad occupare il territorio su cui sorge la città agli inizi del II sec. a.C. per istituire una testa di ponte in vista della conquista della Spagna. Nel 177 a.C. duemila cittadini romani partecipano alla fondazione della colonia di Luna patrocinata dai triumviri M. Emilio Lepido, P. Elio Tuberone e Gn. Sicinio; a ciascun colono sono assegnati 13 ettari in un’area compresa indicativamente tra il fiume Magra e l’attuale Comune di Pietrasanta.
CERCA: https://luni.cultura.gov.it/museo
COLLEZIONI
I REPERTI ARCHEOLOGICI CI RACCONTANO LA LUNGA STORIA DELLA COLONIA ROMANA DI LUNA E DEL SUO TERRITORIO. SCOPRI LE COLLEZIONI DEL MUSEO
Clicca sotto sulle sezioni che t’interessano:
VISITA
L’ANTICA CITTà DI LUNA
AREA ARCHEOLOGICA
COLLEZIONI
IL MUSEO
PERCORSI
SERVIZI EDUCATIVI
NEWS ED EVENTI
PUBBLICAZIONI
COME FARE PER…
MEDIA
BIGLIETTI
Tutte le tariffe d’ingresso e il dettaglio delle riduzioni e delle gratuità
LEGGI TUTTO
ORARI
Gli orari di apertura del museo e le aperture speciali
LEGGI TUTTO
COME ARRIVARE
Come raggiungerci e dove parcheggiare
LEGGI TUTTO
CONSIGLI PER LA VISITA
Prepara la tua visita: percorsi studiati su misura per te
LEGGI TUTTO
Chioccia d'oro – Il Ristorante più consigliato e vicino al Museo
4,5 *****
316 recensioni
20-30 € Ristorante
Servizio: Ha tavoli all'aperto · Offre menu per bambini · Cani ammessi
Indirizzo:
Via Appia, 9, 19034 Luni Mare SP
Orari:
Chiuso ⋅ Apre alle ore 12:30
Aggiornati da altre persone 4 settimane fa
Telefono: 0187 66689 Chioccia d'oro
4,5
316 recensioni
20-30 € Ristorante
Servizio: Ha tavoli all'aperto · Offre menu per bambini · Cani ammessi
Indirizzo:
Via Appia, 9, 19034 Luni Mare SP
Orari:
Chiuso ⋅ Apre alle ore 12:30
Aggiornati da altre persone 4 settimane fa
Telefono: 0187 66689
Prezzo a persona: 20-30 €
Concludo con un flash del sommo Poeta catturato su F/b - di Mauro Salucci

Dante Alighieri sul fiume Entella. Il 6 ottobre 1306 il poeta è in Liguria, a Sarzana. Suo compito è trattare l'accordo di pace fra Francesco Malaspina e il vescovo di Luni Antonio Nuvolone di Camilla. Da Sarzana, Dante viaggia fino a Genova, sino ai paesi e le città del Ponente ligure. Nella Divina Commedia, oltre a descrivere la costa e alcuni personaggi, lancerà pesanti invettive contro i genovesi.
Carlo GATTI
Rapallo 15 Giugno 2024
MARINA DI BARDI - ZOAGLI - UNA VILLA STORICA - SI CHIAMA LA QUIETE
MARINA DI BARDI - ZOAGLI
UNA VILLA STORICA - SI CHIAMA "LA QUIETE"
Da molti anni ormai, ogni volta che percorro l’Aurelia, l’antica via consolare romana, per spostarmi da Rapallo a Chiavari, giunto a Marina di Bardi (Zoagli), il mio sguardo cade su una villa a picco sul mare che sfiora la sede stradale al centro di un’ampia curva.
L’ho sempre vista trascurata, come si può vedere nelle foto che mostro sotto: con le finestre chiuse, i muri sempre più sbiaditi dal tempo e senza mai notare una qualsiasi presenza umana nei dintorni.

Eppure, rifletto ogni volta: da ogni sua finestra che guarda il Golfo Tigullio si deve godere un’incomparabile vista capace di catturare la gioia, il pensiero e l’invidia di tanti turisti di passaggio. Il parco che s’intravede dalla AURELIA appare molto curato da un esperto giardiniere.


Fu in una particolare occasione di scarso traffico che rallentai l’auto per “studiarla” meglio, e notai due ancore “vere” appoggiate ai lati dell’ingresso su due piedistalli marmorei. Sono ancore del tipo HALL e da come sono esposte, intravidi la possibilità che la villa potesse avere una sua storia …
Le ancore di tipo Hall vennero ideate alla fine del XIX secolo e dimostrarono le loro ottime prestazioni in collaudi realizzati nel 1891 in Inghilterra e nel 1892 in Germania, tanto da essere ancora ampiamente utilizzate per le navi di numerose marinerie. Nelle ancore Hall, lo sforzo di trazione maggiore viene sopportato dai due orecchioni, consentendo di eliminare gli inconvenienti che si possono verificare nelle articolazioni basate su perni; l’assenza del ceppo, inoltre, presenta il grande vantaggio di facilitare le manovre per salpare l’ancora, semplificandone la sistemazione a bordo.
Passarono molti anni e quella mia curiosità ebbe finalmente una risposta tra le pagine di un libro di Agostino PENDOLA, nostro concittadino e apprezzato storico della Resistenza Partigiana Ligure locale e non solo della Seconda guerra mondiale.
Com’era…

Com’è oggi…
La villa si chiamava, e si chiama ancora LA QUIETE, in effetti da qui partì il primo segnale di “PACE” per la nostra città dopo cinque anni di guerra!


Da quanto si legge brevemente nella didascalia della foto di Agostino Pendola, in questa villa si decise tra il CNL (Comitato Nazionale di Liberazione) ed il Comando del contingente nazi-fascista (San Marco) di concedere il transito minaccioso della colonna da Rapallo verso Genova, con l’accordo che non ci sarebbero stati attacchi da ambo le parti. Mediatore di questa importante operazione di ritiro delle forze germaniche dal territorio italiano fu il console generale di Spagna che risiedeva, nei pressi di Zoagli, in questa villa misteriosa!
Occorre forse ricordare che nella Seconda guerra mondiale, la Spagna mantenne un atteggiamento diplomatico prudente: benché ideologicamente legato ai regimi nazifascisti di Germania e Italia.
In quella giornata ruggente, era il 25 Aprile 1945, il giorno della liberazione, i tedeschi si arresero alla città di Genova!
A pag. 38 del libro di Agostino PENDOLA si legge:
Si arrivò così al 25 aprile. A Sant’Ambrogio della fucilazione dei patrioti (Muraglione antisbarco presso il porto di Rapallo) la sera prima non seppero nulla. “Quella mattina – continua – dalla galleria del Castellaro, verso Zoagli, sbucò una colonna di tedeschi. Arrivati sotto casa mia si fermarono, e il comandante prese alloggio in una villetta proprio sotto l’Aurelia. Io compresi che bisogna avvisare Rapallo del pericolo che correva, se i tedeschi avessero proseguito. Decisi di scendere, evitando il più possibile la strada principale. Arrivato in fondo alla salita trovai un amico insieme un tedesco; seppi dopo che si trattava di un austriaco. Parlava un po’ italiano, mi diede la sua pistola in segno di resa. In tre ci dirigemmo verso il Comune, dove trovai Giovanni Maggio con gli altri del CLN, nessuno era armato. Raccontai cosa avevo visto e loro mi dissero: va a vedere se sono disponibili a passare per Rapallo senza far danni, e noi non li disturberemo. Tornai indietro, sull’Aurelia di fronte alla villetta dei tedeschi c’erano alcuni militari e altre persone; io dissi ai tedeschi che dovevo parlare con il comandante. Qualcuno mi chiese se ero matto. Mi si avvicinò un tizio che mi chiese cosa volevo andare a fare. Dissi che avevo un messaggio dal CLN. Vista la mia determinazione, decise di venire con me. Seppi dopo che poteva essere il segretario del console Lindner. Entrammo nella casa e riferii al comandante, che parlava un pò l’italiano, la proposta di G. Maggio e del CLN. La persona che mi accompagnava e che parlava perfettamente il tedesco iniziò a esprimersi in quella lingua con l’ufficiale tedesco. Ho avuto l’impressione che il segretario del console facesse a sua volta da intermediario, ma ancora non conoscevo il tedesco, e non capii cosa si stessero dicendo. Va bene, rispose alla fine il tedesco.” I due uscirono, e il segretario disse a Persico che avrebbe provveduto a avvertire in Comune dell’accordo. E questo in effetti è quanto successe, i tedeschi passarono da Rapallo la sera, verso le 7 o le 8, proprio quando la guarnigione (nazista) genovese si arrendeva ai partigiani”.
Bertelloni-Canale
Avv. Giovanni MAGGIO fu il primo Sindaco del dopoguerra a Rapallo e Presidente Amministrazione Provinciale di Genova
Autore: Agostino PENDOLA
L’ECCIDIO DEL MURAGLIONE
E ALTRE STORIE DELLA RESISTENZA RAPALLESE
© 2009 Gammarò editori – Sestri Levante www.gammaro.it info@gammaro.it ISBN-10: 88-95010-85-X ISBN-13: 978-88-95010-85-4 Questo libro è stato pubblicato con il contributo della Provincia di Genova.
Introduzione:
Continua, con questo libretto, la ricerca delle radici civili della nostra città che ho iniziato da qualche tempo. Tre anni fa, occupandomi della politica rapallese alla fine dell’Ottocento, ho voluto andare ai primi momenti della nostra lotta politica, ai primi dibattiti e alle prime polemiche, anch’esse infuocate come oggi, forse di più. Questa volta ho preferito arrivare più vicino a noi, alla Resistenza. Si dice Resistenza e si pensa subito alle montagne dell’Aveto e della Graveglia, all’Alta Fontanabuona, perché in effetti è lì che la guerra di Liberazione – nella Riviera Ligure di Levante - ha avuto i momenti più acuti, i rastrellamenti e le battaglie, i morti più numerosi. Le targhe che popolano le valli ce lo ricordano. È dalle formazioni che in quei luoghi combatterono che ha tratto origine la maggiore memorialistica partigiana. Naturalmente la Resistenza non si è combattuta solo sui monti, le SAP hanno portato la guerra nelle città, laddove i fascisti e i tedeschi si sentivano sicuri. Proprio a Rapallo qualche anno fa è stato proiettato un lungometraggio sul partigiano Pesce che a Milano animò una famosa Squadra d’Azione Partigiana. Anche questo è stato un aspetto della nostra Resistenza, un aspetto che si articolava con le bande sui monti, in un continuo travaso tra montagna e città. Di questo mi parlava anni fa un ex-partigiano, l’indimenticabile Ermanno Baffico scomparso di recente, quando raccontava di quando si incontrava a Genova con i suoi compagni di lotta delle Squadre repubblicane nei locali della Biblioteca Popolare Mazzini in via Garibaldi, per poi risalire la Valle del Bisagno per la Scoffera, altra zona di operazioni delle sue formazioni. Un film recente, premiato nei concorsi cinematografici, ha raccontato le vicende della Divisione Partigiana Osoppo, aderente al Partito d’Azione. Vicende di lotta fratricida con altre formazioni, vicende tristi, che pure sono state una parte della Resistenza. Queste storie, che in gran parte leggiamo nei libri o vediamo nei film, le abbiamo avute anche sulle nostre colline. Anche a Rapallo abbiamo avuto le Squadre d’Azione e c’è stata lotta – per fortuna non altrettanto cruenta come nel Nord-Est dove hanno operato i partigiani della Osoppo– tra le varie anime del movimento partigiano. Questo libro è nato per caso; partito dal desiderio di fissare alcuni avvenimenti, ho trovato altre notizie che mi hanno convinto a raccontare quello che a Rapallo non era mai stato raccontato. Ma questo libro non sarebbe stato possibile senza la mirabile ricerca di Vittorio Civitella sulla Brigate “Giustizia e Libertà” Matteotti, che operarono nell’alta Val Fontanabuona a partire dal giugno 1944. È stato proprio leggendolo che ho trovato la traccia per arrivare a ciò che finora mancava per raccontare quello che successe a Rapallo nella notte tra il 24 e 25 aprile con la fucilazione di sei partigiani a Langano, sul porto. È una vicenda che anche ai rapallesi non più giovani non è mai stata molto chiara. Su cosa sia successo veramente circolano varie versioni, tutte monche e largamente incomplete. La cosa non deve meravigliare, chi è morto non racconta, chi è sopravvissuto in genere non vuole ripercorrere momenti nei quali si è visto perduto. Eppure da qualche anno i documenti sono disponibili, documenti scritti sul momento da partigiani, oppure testimonianze raccolte e poi portate lontano. Danno un quadro abbastanza completo del più importante momento resistenziale di Rapallo, e l’ho messo deliberatamente all’inizio. Il titolo non è mio, proviene da una relazione scritta dieci anni dopo quella notte dal Dott. Manlio Piaggio che ho largamente utilizzato nella seconda parte del capitolo, una testimonianza di prima mano di chi in quei mesi non si nascose ad attendere che passasse la bufera. È un titolo che rende perfettamente chiaro cosa successe. Tuttavia i documenti trovati a Genova non sarebbero stati completi senza l’apporto del figlio di un fucilato (ma sopravvissuto). Filippo Carlotti è partito da quel poco che gli aveva raccontato suo padre, per cercare una storia abbozzata, per rintracciare altri protagonisti. Dal confine con la Svizzera, da dove era partito suo padre, a Tradate, paese di un altro partigiano, ha raccolto una documentazione che da solo mai avrei raggiunto. Scorrendo le note si noterà come che gran parte del materiale non proviene da Rapallo, con l’esclusione di alcune fotografie fornite da parenti degli uccisi, o di testimonianze quando si tratta di interviste. A chi ha fornito il materiale va il mio ringraziamento. Ma per il testo, i documenti che sono alla base di questo lavoro provengono quasi tutti da archivi non cittadini. Genova naturalmente, ma non solo. Su questo fatto si potrebbe riflettere un momento: Rapallo è una città che non conserva la memoria. O, se la conserva, non la rende disponibile a chi la usa. Il cattivo esempio lo danno le istituzioni, a partire dal comune. L’archivio storico cittadino, vera miniera di atti, documenti e quant’altro serve per scrivere la storia, è conservato nei fondi di un palazzo, la sua consultazione è lasciata alla disponibilità del responsabile. Perfino la raccolta del MARE che con i suoi limiti potrebbe sopperire alle altre deficienze, non è più consultabile a causa delle cattive condizioni dei volumi. Andremo alla Biblioteca Universitaria di Genova per leggere il MARE? Dove peraltro la raccolta non è completa. Per fortuna non è sempre e ovunque così. L’Istituto della Resistenza a Genova, non solo conserva la documentazione, ma ha personale preparato e sempre disponibile. Per questo lavoro è stato molto utile e a loro va il mio ringraziamento. Come va a chi ha sacrificato una parte del suo tempo per raccontarmi cosa sapeva, i fatti di cui era stato testimone, perché anche gli altri sappiano. Ma soprattutto la riconoscenza di noi rapallesi deve andare a chi è salito in montagna in quei giorni, a chi non ha lasciato che la liberazione del nostro Paese avvenisse solo per l’azione di forze esterne, ma ha voluto che il riscatto nascesse da noi stessi.
Questo articolo, nato per caso da una semplice curiosità dell’autore, si è sviluppato lungo una ricerca che mi ha portato a riscoprire le sofferenze dei nostri genitori e di tutti i concittadini rapallesi che hanno visto trasformare la loro PACIFICA OASI DI TERRA TURISTICA in un campo di battaglia infernale! A tutti loro vada il nostro pensiero!
Ho riportato interamente la INTRODUZIONE del libro di Agostino PENDOLA in quanto tocca alcuni punti che ancora ci fanno riflettere; uno tra tutti, a noi tanto caro, è l’importanza documentale attribuita alla rivista IL MARE che vide la luce nel lontano 1908 ed è tuttora in “servizio attivo” come unico testimone oculare che tocca da sempre il cuore e la coscienza di Rapallo.
RINGRAZIO lo storico rapallese Agostino PENDOLA per averci consegnato i suoi “studi” sui quali rifletteremo e ne faremo sempre tesoro!
Seguono alcuni articoli della Seconda guerra mondiale che riguardano il nostro territorio, e sono stati pubblicati sul sito di Mare Nostrum Rapallo:
PIPPO” VENIVA DAL MARE di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/pippetto/
BOMBE SU RAPALLO. COME ERAVAMO di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/rapallo-come-eravamo/
LA MIA GUERRA di Ada Bottini
https://www.marenostrumrapallo.it/la-mia-guerra/
GAZZANA PRIAROGGIA GIANFRANCO, UN RAPALLESE D'ADOZIONE di Maurizio Brescia
https://www.marenostrumrapallo.it/pria/
IL PICCOLO P/FO LANGANO SFIDO' LA KRIEGSMARINE di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/langano/
MATHAUSEN-RAPALLO - STORIA DI UN PILOTA GENOVESE di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/da-mathausen-a-rapallo/
CARMELO DE SALVO REDUCE DAI LAGER NAZISTI di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/la-storia-di-carmelo-de-salvo-reduce-dai-lager-nazisti/
IL CANNONE DELLE GRAZIE di Carlo Gatti
https://www.marenostrumrapallo.it/grazie/
Carlo GATTI
Rapallo, 7 Giugno 2024
L’AMMIRAGLIO ANDREA DORIA NEL TIGULLIO
L’AMMIRAGLIO ANDREA DORIA
NEL TIGULLIO
Una battaglia navale che ci è stata tramandata oralmente…
 Foto di Monica Patané
Foto di Monica Patané
Al servizio di Francesco I
Andrea Doria e la sua flotta riuscirono, ancora una volta, a prendere il mare prima che arrivassero i nemici.
Trovato rifugio nella roccaforte dei Grimaldi a Monaco, l'ammiraglio iniziò a compiere una serie di colpi di mano contro le coste occupate dagli spagnoli, passando da un successo all'altro e riuscendo pure ad evitare che Marsiglia, accerchiata dagli imperiali, si arrendesse.
Durante il periodo in cui Andrea Doria serviva la corona francese, il golfo del Tigullio divenne teatro di una delle sue audaci operazioni navali. Sfruttando la copertura della notte e la conoscenza dei venti locali, il Doria guidò le sue galee in un attacco a sorpresa contro una flotta di galeoni spagnoli ancorata tra Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino. La battaglia fu breve ma intensa: alcuni vascelli furono catturati, mentre altri incendiati sotto il fuoco incrociato. Questo episodio dimostra ancora oggi l’abilità che ebbe l’Ammiraglio genovese nel coordinare attacchi fulminei sfruttando al massimo le condizioni ambientali a suo favore.
Le vittorie di Doria furono inutili. Nel 1525 Francesco I perse la cruciale battaglia di Pavia, fu catturato e trasportato a Madrid.

Ritratto di Andrea Doria (Oneglia) – Opera di Sebastiano del Piombo

Ritratto di Andrea Doria nelle vesti di Nettuno - Opera del Bronzino
ANDREA DORIA è stato un ammiraglio, politico e nobile italiano della Repubblica di Genova.
Nascita: 30 novembre 1466, Oneglia, Imperia
Morte: 25 novembre 1560, Genova
Partner: Peretta Usodimare, Alfonso I del Carretto
Luogo di sepoltura: Chiesa di San Matteo (Genova)
Dinastia: Doria
In carica: 1531 – 1560
Madre: Caracosa Doria di Dolceacqua
Andrea Doria non lasciò figli e la sua eredità venne raccolta da Gianandrea, figlio dell'erede prediletto Giannettino (ucciso dai Fieschi nel 1547).
Andrea Doria raffigurato sul prospetto principale del Palazzo San Giorgio
Andrea Doria è una figura centrale nella storia navale del XVI secolo. Le sue imprese militari si sono svolte principalmente nel Mediterraneo, dove le sue abilità tattiche e la sua capacità di cambiare alleanze gli permisero di giocare un ruolo determinante negli equilibri di potere tra le grandi nazioni europee, in particolare tra Francia e Spagna, riflettendo le complesse dinamiche politiche dell’epoca.

Galeone spagnolo del XVI secolo

Un galeone del XVI secolo era lungo mediamente 40-42 mt (o più) per una larghezza d'una decina di metri. I galeoni avevano da tre fino a cinque alberi e in genere l'albero di trinchetto (prodiero) possedeva tre vele quadre, la più grande era la vela di trinchetto, seguita dal parrocchetto e dal velaccio di trinchetto.
Una ventina di anni fa, lo storico rapallese Pierluigi Benatti mi raccontò di una epica battaglia che si svolse nel golfo Tigullio tra Portofino e Rapallo. Andrea Doria, venuto a conoscenza di una flotta di galeoni spagnoli all’ancora nel Tigullio, li sorprese all’alba, ne catturò una parte e ne affondò le restanti.
Secondo la sua narrazione, la strategia tipica di A. Doria includeva operazioni all’alba per cogliere il nemico impreparato, una tattica che gli permise di ottenere numerosi successi.
In merito alla specifica battaglia nel golfo del Tigullio, purtroppo non ci sono molte fonti dettagliate e disponibili che descrivano esattamente un episodio con le caratteristiche che P. Benatti mi menzionò. Tuttavia, è noto che Andrea Doria, durante il periodo in cui era al servizio di Francesco I di Francia (a partire dal 1522), condusse diverse operazioni contro le flotte spagnole e barbaresche, spesso sfruttando sia la sorpresa sia la velocità delle sue galee.

Le navi del Principe
Andrea Doria era famoso per le sue tattiche innovative, tra cui l’uso delle galee leggere e manovrabili che potevano attaccare rapidamente e ritirarsi altrettanto velocemente.
Questo approccio era particolarmente efficace contro le più lente e pesanti navi da guerra spagnole. L’uso della sorpresa e degli attacchi all’alba era, come abbiamo appena accennato, una componente chiave delle sue operazioni, come testimoniano molte delle sue campagne di successo.
Anche se il racconto specifico di P. Benatti non è facilmente reperibile, questa descrizione è in linea con le modalità operative di Andrea Doria che seppe sfruttare con grande maestria l’importanza strategica della costa ligure durante le guerre del XVI secolo, e come il grande ammiraglio abbia influenzato le sorti di questi conflitti attraverso operazioni audaci e ben pianificate.
GALEA GENOVESE

Galea Genovese in rada a Genova, in posizione di "sosta breve" (pronta a partire con breve preavviso).
Notare i remi alzati, non perchè si preparasse a vogare ma perchè in quel particolare "assetto" non c'era posto per poterli ricoverare lungonave e nemmeno in posizione "trasversale" così venivano tenuti fuori bordo, assicurati ai banchi di voga.
Un telone ricopre tutta la nave riparando l'equipaggio da sole, pioggia, freddo (a seconda dei casi). I rematori riposano sui banchi di voga, dormendo come possono.....
Galea o galera è un'ampia tipologia di navi da guerra e da commercio, usata nel Mar Mediterraneo per oltre tremila anni, spinta dalla forza dei remi e talvolta dal vento, grazie anche alla presenza di alberi e vele: il suo declino cominciò a partire dal XVII secolo, quando venne progressivamente soppiantata dai velieri, estinguendosi definitivamente alla fine del XVIII secolo.
La struttura leggera e affilata, e la propulsione a remi la rendeva veloce e manovrabile in ogni condizione; le vele quadre o latine permettevano di sfruttare il vento quando favorevole.
La struttura leggera ed affilata era però un handicap in quanto non permetteva di montare cannoni in batteria (come i galeoni e le altre navi a propulsione velica del tempo) riducendo l'armamento ad un solo piccolo "pezzo" a prora e qualche "innocua" spingarda. Era quindi una nave usata solo per lo speronamento e l'abbordaggio ma che rischiava di essere affondata da una "bordata" ben diretta.
In quaranta metri di lunghezza poteva "ospitare" 200 rematori ed altrettanti soldati armati.
Non era quindi una nave adatta a lunghi viaggi senza scali intermedi ma bensì per la navigazione costiera e la guerra di corsa.

Ricostruzione a grandezza naturale, vista da prora - Galata Museo del mare. Si vede il cannone prodiero due armigeri e una spingarda.
LUCIANA GATTI
Centro di studio sulla tecnica, Genova
http://geca.area.ge.cnr.it/files/302569.pdf
ARMI DA FUOCO SULLE IMBARCAZIONI GENOVESI
NELLA PRIMA META’ MODERNA
Clicca tre volte su VISTA - "ingrandisci"


Esempi di Battaglie e Operazioni Navali condotte dall’ammiraglio Andrea Doria
La Battaglia di Capo d’Orso (1528)
Ad Amalfi, presso Capo d’Orso, si combatté il 28 aprile 1528 una battaglia navale (detta anche “della Cava” o “d’Amalfi”) tra le navi di Filippino Doria e quelle spagnole comandate dal marchese del Vasto.

George Loring Brown – Vista d’Amalfi, Baia di Salerno
Una delle battaglie più famose in cui Doria giocò un ruolo cruciale. Durante questa battaglia, la flotta francese, comandata da Doria, sconfisse una flotta spagnola, rafforzando il controllo francese sul Mediterraneo occidentale.
Gli Spagnoli, alle sei galere (Capitana, Gobba, Villamarina, Perpignana, Calabrese, Sicana) avevano aggiunto due fuste, due brigantini e molte barche, che erano state armate con materiale e personale tolto al presidio di Napoli, sicché potevano sperare d’assalire in forze superiori le otto galere di Filippino, prima che giungessero i promessi aiuti veneziani. Il Doria, avvertito in tempo, mosse risolutamente contro gli assalitori, ma, accortosi d’essere più debole, ricorse a uno stratagemma: ordinò al suo luogotenente Lomellino di simulare la fuga appena giunto a tiro del nemico, e di prendere il largo con le sue tre galere, ritornando poi a tempo opportuno per investire di fianco. Gli Spagnoli, dopo avere poco efficacemente sparato sugli avversari, mossero all’abbordaggio, e già due galere di Filippino erano state conquistate, quando le unità del Lomellino attaccarono secondo il previsto, determinando la completa vittoria. Quattro galere e due brigantini spagnoli furono presi o colati a fondo, e 1400 uomini circa uccisi o messi fuori di combattimento; da parte di Filippino nessuna unità perduta e caduti circa 500 uomini.
La battaglia di Capo d’Orso è l’unico combattimento di notevole importanza, che ricordi la storia nella prima metà del secolo XVI tra squadre di popoli civili.
La Presa di Genova (1528)
Il Doria rifiutò la Signoria della città, preferendo lasciare ad alcuni "Riformatori" la stesura di una nuova costituzione. Savona fu la prima vittima della rinata Repubblica: il suo porto fu distrutto ed interrato, ed i genovesi provvidero a potenziare la fortezza del Priamar per dominare la città, che non si riprese più. La Compagna Communis cessò di esistere e fu istituita la Repubblica di Genova con questo nome; furono resi ancora più importanti gli "Alberghi", liste di "iscrizione" alla nobiltà della Città, riconosciute dal governo.

Svolta filospagnola di Andrea Doria e Ricostruzione del Dominio genovese da 1528 al 1530
Nel 1528, Andrea Doria, l’influente ammiraglio e politico genovese, cambiò alleanza, abbandonando il re di Francia Francesco I per entrare al servizio dell'imperatore Carlo V di Spagna. Questa mossa strategica fu cruciale per l'esito degli eventi a Genova. Doria, con il supporto della flotta spagnola, riuscì a sollevare la città contro il dominio francese. La popolazione genovese, stanca del controllo francese e delle sue imposizioni, si ribellò. Doria sfruttò abilmente il malcontento diffuso e la sua reputazione per guidare la rivolta. La flotta spagnola, insieme alle forze di Doria, assediò la città, costringendo i francesi a ritirarsi. Dopo la cacciata dei francesi, Genova passò sotto l'influenza spagnola, ottenendo una certa autonomia sotto la protezione dell'Impero. Questo cambiamento politico permise a Doria di instaurare un governo oligarchico, con un nuovo sistema di governance che consolidò la sua posizione di potere e rafforzò l'indipendenza di Genova rispetto alle altre potenze europee. Il voltafaccia di Doria e la conseguente presa di Genova segnano un momento cruciale nella storia della città, dando inizio a un periodo di rinnovata prosperità e stabilità sotto la protezione spagnola.
La Difesa di Corfù (1537)

Nel 1537, l'isola di Corfù, sotto il controllo della Repubblica di Venezia, fu minacciata da un'imponente flotta ottomana comandata da Khayr al-Din Barbarossa. Andrea Doria, al servizio dell'imperatore Carlo V, giocò un ruolo cruciale nella difesa dell'isola. Consapevole della superiorità numerica della flotta ottomana, Doria mise in atto una strategia difensiva ingegnosa e coordinata. Egli rafforzò le difese costiere e organizzò una serie di pattugliamenti navali per monitorare i movimenti del nemico. Le sue abilità nella guerra navale e la sua capacità di mantenere alto il morale delle truppe furono determinanti. Nonostante i ripetuti attacchi degli Ottomani, Doria riuscì a mantenere le linee di difesa intatte, infliggendo gravi perdite agli assalitori. La resistenza eroica delle truppe veneziane e genovesi, supportata dall'esperienza tattica di Doria, impedì agli Ottomani di conquistare l'isola. La difesa di Corfù dimostrò la competenza di Doria nel gestire operazioni navali complesse e la sua capacità di coordinare efficacemente le forze alleate. Questo successo non solo consolidò la reputazione di Doria come uno dei più grandi ammiragli del suo tempo, ma contribuì anche a mantenere l'equilibrio di potere nel Mediterraneo, proteggendo gli interessi veneziani e dell'Impero. La difesa di Corfù nel 1537 rimane un esempio lampante di strategia militare e di resistenza contro un nemico formidabile.
Intorno agli Anni 1522-1525, sebbene già legato in precedenza al fronte filospagnolo, Andrea Doria si mise al servizio della Francia: le sue galee si battevano a fianco di quelle di Francesco I e A. Doria arrotondava con i proventi della cattura delle navi nemiche, spagnole o barbaresche, e il riscatto dei prigionieri.
L’Importanza strategica del Golfo del Tigullio

Le insenature di levante del Promontorio di Portofino offrono riparo alle imbarcazioni con i venti di Tramontana, Maestrale e Libeccio
Quella parte del Tigullio, situata tra Portofino e Rapallo, aveva un’importanza strategica notevole. Questo tratto di costa ligure offriva, anche allora, ripari naturali che erano vitali per le operazioni navali. La conoscenza approfondita di questi luoghi da parte di Andrea Doria gli conferiva un vantaggio significativo rispetto ai suoi avversari, spesso meno familiari con le insidie della costa ligure.
Immaginaria Battaglia nel Tigullio
A questo punto, anche senza una documentazione precisa della battaglia, si può tentare di descrivere la battaglia nel golfo del Tigullio basandosi sulle “classiche” tattiche di Andrea Doria.
Riproponiamo brevemente il quadro storico:
Durante il periodo in cui Andrea Doria serviva la corona francese, il golfo del Tigullio divenne teatro di una delle sue audaci operazioni navali. Sfruttando la copertura della notte e la conoscenza dei venti locali, Doria guidò le sue galee in un attacco a sorpresa contro una flotta di galeoni spagnoli ancorata tra Santa Margherita Ligure e Rapallo. All’alba, le navi spagnole furono colte di sorpresa. La battaglia fu breve ma intensa: alcune navi furono catturate, mentre altre affondarono sotto il fuoco incrociato….
Andrea Doria era abilissimo nel coordinare “colpi di mano micidiali” sfruttando al massimo le condizioni ambientali a suo favore.
Quello era il suo mare, la tramontana notturna era il suo vento preferito, ed il servizio di spionaggio terrestre (vedette appostate ovunque) e le perlustrazioni marittime ravvicinate, lo informavano costantemente circa:
- La presenza di imbarcazioni spagnole in perlustrazione intorno al Promontorio di Portofino.
- Le eventuali precauzioni prese dagli spagnoli per respingere attacchi di sorpresa tra cui:
a) Cannoni e artiglierie in posizione e pronti a sparare.
b) Consistenza di soldati armati in coperta
c) Posizione e prontezza delle attrezzature marinaresche (alberi e vele)
Presumibilmente, valutate tutte le informazioni, Andrea Doria, sfruttando il vento di terra, fece compiere alla sua flotta un’ampia curva verso il largo per poi rientrare nel golfo del Tigullio da levante onde poter procedere speditamente, in “linea di fianco”, mettendo la prua di ogni galea su un bersaglio designato da colpire a distanza ravvicinata.
Possiamo soltanto immaginare gli effetti di tale sorpresa: caos totale a bordo delle navi spagnole. Fuoco e fiamme, urla che coprono gli ordini degli ufficiali, marinai che si tuffano in mare. I vascelli sono tutti impossibilitati a salpare le ancora nel tentativo di scappare e a reagire alle cannonate delle imbarcazioni genovesi.
Possiamo immaginare le galee di Andrea Doria che dopo il primo attacco ai remi, si dividono, accostando una parte verso il mare e l’altra verso terra, compiendo un circolo e ripresentandosi in “linea di fianco” per terminare il “lavoro chirurgico” con un secondo e definitivo attacco micidiale, che non è più di sorpresa ma solo un atto predatorio che frutterà la vittoria ed un eccellente bottino per i genovesi.
ALBUM FOTOGRAFICO

Oneglia - Casa Natale di Andrea Doria


Oneglia - Vicino alla Basilica di San Giovanni Battista e al Mercato Andrea Doria, scendendo verso il mare si trova l'edificio dove nacque Andrea Doria. C'è una targa commemorativa del grande Ammiraglio.

Oneglia - Mercato Andrea Doria MCMXXX
ANDREA DORIA A GENOVA

PALAZZO DORIA PAMPHILJ - VILLA DEL PRINCIPE

GENOVA - La chiesa di San Matteo
E’ un edificio religioso cattolico del centro storico di Genova, fa parte del vicariato “Centro Est” dell’arcidiocesi di Genova. Si affaccia sull’omonima piazza, che nel Medioevo era il centro dell'insediamento della famiglia Doria, e rappresenta forse l'angolo meglio conservato della Genova medioevale. La chiesa è formalmente ancora oggi Abbazia dei Doria.

GENOVA - La cripta di Andrea Doria
Andrea Doria è ricordato come uno dei membri più importanti della famiglia, se non il più importante. Alla sua morte, il Montorsoli venne incaricato di realizzare la cripta del capitano, insignito del prestigiosissimo titolo di "Defensor" per le sue azioni a protezione della cristianità. Lo spazio fu ricavato al di sotto dell'altare della chiesa. Per accedervi si scende per uno scalone di marmo bianco, lo stesso che ricopre completamente l'ambiente. Al centro si trova la tomba del principe, un sarcofago sormontato da due angeli a circondarne l'effige.
Il marmo bianco ricopre le pareti della cripta che ancora oggi ospita il sepolcro di Andrea Doria.
I palazzi dei Doria a Genova (foto sotto), si trovano nella zona della Chiesa di S. Matteo in pieno centro storico



SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI

LE TOMBE DEI DORIA


La cripta all'interno dell'Abbazia di San Fruttuoso con le tombe dei Doria come si presentavano prima del restauro conservativo operato dal Fondo Ambiente Italiano nel 1983.
Dal livello inferiore del chiostro si accede al profondo vano a volta concesso ai Doria dai monaci come sepolcreto.
Le tombe nobiliari, nelle quali alloggiano le salme di alcuni importanti membri della famiglia Doria morti tra il 1275 e il 1305, sono in marmo bianco e pietra grigia alternati nella tipica bicromia ligure.
Sono disposte a schiera sui tre lati del vano e sono costituite da arche in muratura singole o a coppie, in gran parte con epigrafi, sormontate da arcosoli a sesto acuto sorretti da colonnine in marmo con tettuccio a capanna.
Oltre alle tombe della famiglia Doria, nella cripta sono presenti le tombe delle sorelle Maria e Caterina Avegno, eroine di San Fruttuoso, ivi sepolte per disposizione degli stessi principi Doria.

Riferimenti:
ANDREA DORIA
https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-doria_(Dizionario-Biografico)/
ANDREA DORIA
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Doria
ANDREA DORIA – STORIA LOCALE - PORTOFINO
https://www.portofinoamp.it/storia-locale/andrea-doria
Carlo GATTI
Rapallo, 23 Maggio 2023
SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTE GRISA - TRIESTE
SANTUARIO DELLA MADONNA DI MONTE GRISA
TRIESTE
Nel mese di maggio, il profumo dei fiori si mescola con la brezza marina, avvolgendo Trieste e i cuori dei suoi abitanti in un'atmosfera di devozione e gratitudine. È il periodo in cui il Santuario della Madonna di Monte Grisa risplende con particolare fervore, richiamando pellegrini da ogni angolo del mondo. Ma per me, uomo di mare e figlio della Liguria, questa devozione va oltre la semplice pratica religiosa. È un legame profondo, intessuto con i ricordi dell'oceano e delle esperienze vissute tra le onde.

Come marinaio, ho imparato a confidare nel conforto di Maria in ogni pericolo, a cercare il suo sostegno quando il mare si fa burrascoso e le stelle sono il mio unico faro. Ogni viaggio, ogni nodo marinaro, è un atto di devozione, un ex voto sussurrato al vento. E così, quando mi trovo di fronte al Santuario di Monte Grisa, non vedo soltanto pietra e argento, ma il riflesso della mia fede e delle mie speranze, nel rollio ed il beccheggio nelle onde dell’Adriatico.
In questo articolo, desidero condividere con voi questo legame profondo, raccontare di Trieste, città marinara tanto cara al mio cuore, e del Santuario della Grisa che è diventato per me il rifugio sicuro nelle tempeste della vita.

Il Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina è un Santuario Mariano cattolico a nord della città di Trieste. Sorge all'altitudine di 330 metri sul monte Grisa, da cui si gode di una vista spettacolare della città e del golfo. Fu progettato dall'ingegnere Antonio Guacci su schizzo del vescovo di Trieste e Capodistria Antonio Santin: la struttura triangolare evoca la lettera M, iniziale della Vergine Maria. Il Santuario è caratterizzato da un'imponente struttura in cemento armato, con la presenza di due chiese sovrapposte.

Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa, con la sua mole domina la splendida città di Trieste ed il suo golfo
Il santuario fu consacrato il 22 maggio 1966
UN PO’ DI STORIA
Il santuario mariano di Monte Grisa, che domina il golfo di Trieste, è inconfondibile con la sua forma a M e la caratteristica struttura portante in cemento armato a triangoli che ne hanno fatto una delle più fotografate tra le chiese moderniste.
Nel 1945 l'arcivescovo di Trieste Antonio Santin fece un voto alla Madonna per la salvezza di Trieste, minacciata di distruzione dagli eventi bellici. Finita la guerra.
nel 1948 monsignor Strazzacappa propose di realizzare, con l'intervento di tutte le diocesi d'Italia, un tempio di interesse nazionale dedicato alla Madonna.
Nel 1959, papa Giovanni XXIII decise che il Tempio sarebbe stato dedicato a Maria Madre e Regina come simbolo di pace e unità tra tutti i popoli, in particolare tra entrambi i lati del confine, che dal luogo del santuario dista meno di 10 chilometri.
Da aprile a settembre di quell'anno ebbe luogo il cosiddetto "pellegrinaggio delle meraviglie": la statua della Madonna di Fatima attraversò varie città italiane e raggiunse Trieste, accolta dall'arcivescovo, il 17 settembre 1959. Due giorni dopo fu posta la prima pietra del grande tempio.
Era desiderio di tutti avere per il nuovo tempio una statua della Madonna di Fatima: a ciò provvide il vescovo di Leiria João Pereira Venâncio, il quale incaricò lo stesso scultore che aveva eseguito la statua per la capelinha di scolpirne una uguale per Trieste.
Il 22 maggio 1966 il tempio fu consacrato e iniziarono i pellegrinaggi dall'Italia e dall'estero.
Dal 2011 il Tempio può vantare la presenza di un coro che canta in stile gregoriano in seno alle cerimonie religiose: il Coro Incanto Gregoriano. Il repertorio, oltre ai normali canti della Messa, esegue oggi delle magnifiche salmodie e litanie che il repertorio Gregoriano presenta e che, puntualmente, favoriscono la spiritualità, la devozione e la dimensione del Sacro.

Logo del Santuario Mariano

GLI ESTERNI DEL SANTUARIO
La facciata esterna dell’edificio mostra 3 grandi dimensioni architettoniche: la piramide ad indicare la trascendenza, la composizione dei triangoli ad indicarne la pluralità e la sua monolitica struttura ad indicarne l’unità.
Nella composizione di questi 3 grandi simboli, il Tempio anche dall’esterno, annunzia un messaggio sempre attuale: “l’unità nella pluralità si raggiunge quando si guarda in alto, dove si scorge maggiormente ciò che unisce anziché ciò che divide”.



Nel LINK sotto viene spiegata l’interessante Architettura dell’edificio con le sue SIMBOLOGIE E SPIRITUALITA’.
http://www.montegrisa.org/architettura-simbologia-e-spiritualita

Antonio Guacci
L’ing. Antonio Guacci, docente dell’università di Trieste presso la facoltà di ingegneria civile, accolse l’invito del committente mons. Antonio Santin, Vescovo di Trieste-Capodistria ad edificare un Tempio Mariano che raccogliesse la memoria di quattro eventi nazionali:
Il voto fatto dal presule per la salvezza di Trieste (30 apr. 1945)
Il ricordo dei soldati caduti e dispersi (1945)
Il dramma dell’Esodo Giuliano-Dalmata (1943-1956)
La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (13 sett. 1959)
Antonio Guacci elaborò un originale progetto, un “Memoriale”, su un ciglione carsico a 330 metri sul livello del mare, visibile da tutti i paesi che si affacciano sul golfo. Il triangolo nel linguaggio simbolico biblico, rappresenta la trascendenza di Dio.
Nel Nuovo Testamento, richiama la prima verità della fede, la Trinità: un solo Dio in 3 persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Il volume dell’edificio è di c.a. mc 40.000, con un’altezza di circa ml. 40, con la superficie dell’aula inferiore di mq 1.600 e di quella superiore di mq 1.500; dimensioni ragguardevoli per un edificio di culto, tanto da renderlo assieme alla sua ubicazione il più maestoso di Trieste.
Le pareti a vetro della chiesa superiore conferiscono all’aula trasparenza e luminosità che la rendono in continuità con il cielo, il mare e la vegetazione circostante.
Tra le tante simbologie rappresentate in questo Santuario, a noi interessa segnalarvi anche un aspetto molto particolare che rispecchia il forte legame della Trieste marinara con il culto Mariano:
La chiesa superiore assomiglia alla “coperta” di una nave, dove l’altare maggiore, indica il “ponte di comando”: il “nocchiero” Cristo unendola a Se con il suo spirito, la sospinge verso la gloria del Padre.L’altare della Madonna, invece, in fronte all’altare dell’Eucarestia ne suggerisce la “rotta” della nave: “fate quello che Egli vi dirà” (Gv.2,5).
INTERNI DEL SANTUARIO
LA CHIESA SUPERIORE
GALLERIA D’IMMAGINI



LA CHIESA INFERIORE
http://www.montegrisa.org/chiesa-inferiore
La chiesa inferiore, invece, con gli intrecci dei fasci luminosi, con le sue “lame” di luce e le penombre donano all’interno un’aurea di mistero che invita alla riflessione ed al silenzio.



DATI E DATE

Stato |
Italia |
Regione |
Friuli-Venezia Giulia |
Località |
Trieste |
Coordinate |
45°41′35.2″N13°44′57.18″ECoordinate: 45°41′35.2″N 13°44′57.18″E (Mappa) |
Religione |
cattolica di rito romano |
Titolare |
Nostra Signora di Fátima |
Ordine |
Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria |
Diocesi |
Trieste |
Consacrazione |
1966 |
Architetto |
Ing. Antonio Guacci |
Stile architettonico |
brutalismo |
Inizio costruzione |
1963 |
Completamento |
1966 |
Sito web |
Sito ufficiale del Santuario |
Per chi ama Trieste segnalo i seguenti Link:
Trieste, breve esposizione della sua storia
https://www.trieste.com/citta/storia.html
La Risiera di San Sabba, il lager di Trieste
https://www.storicang.it/a/risiera-di-san-sabba-il-lager-di-trieste_15529
Il colle di San Giusto è il centro storico di Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giusto_(Trieste)
La grande festa del mare a Trieste: storie e curiosità sulla Barcolana
https://www.triesteprima.it/social/barcolana-storia.html
Triestini Celebri
https://www.trieste.com/citta/celebri.html
A cura di:
Carlo GATTI
Rapallo, 8 Maggio 2024
GENOVA - QUANDO TUTTO GIRAVA INTORNO AL PALAZZO DEL PRINCIPE
GENOVA - QUANDO TUTTO GIRAVA INTORNO AL PALAZZO DEL PRINCIPE
LA FREGATA ARGO DI ANDREA DORIA

Foto: A Mae Zena

Foto: Tripadvisor
Navigando nella bonaccia del Porto Antico, lo sguardo attento potrebbe scorgere un'imbarcazione che evoca l'antica grandezza dei mari: la fregata "Argo" di Andrea Doria, ancorata con antica fierezza. Questo vascello è stato ricostruito con maestria, rispettando i disegni originali del Cinquecento. Le vele si ergono alte, con i vessilli verdi, segno distintivo della casata, e quelli bianchi con l'aquila araldica dei Doria. Un tendale di velluto cremisi, prezioso al tatto, completa l'immagine.
In quei tempi lontani, l'"Argo" serviva a trasportare nobili e notabili che giungevano via mare al Palazzo del Principe, regale dimora che svettava sulle onde, permettendo all'ammiraglio di dominare con lo sguardo il golfo di Genova. Oggi la situazione è ben diversa: lo scenario è dominato dalla “sopraelevata” e dalle moderne navi da crociera ormeggiate a Ponte dei Mille, come mostra la foto sotto.

Foto: di Anna Armenise
Foto: A Mae Zena
Davanti al giardino meridionale, dove una statua di Nettuno rendeva omaggio al potere marittimo (pensatelo senza il porto moderno, ma in armonia diretta col mare), le galee delle aquile dei Doria attraccavano quando l'ammiraglio, sia Andrea che Giovanni Andrea, doveva imbarcarsi sulla sua Ammiraglia o sbarcarne per tornare a casa.

Foto: il Caffaro
LA CAPITANA
Ma non solo l'Argo sventola le sue vele nel Porto Antico. L'ammiraglio, infatti, aveva sempre ancorate in Darsena dodici galee pronte per la guerra, che poi divennero venti, con la Capitana, la galea più prestigiosa del suo tempo, al loro comando.
La storia racconta di un tempo in cui l'ammiraglio e l'Imperatore Carlo V concordarono l'impresa in Africa, e per tale avventura, fu necessario allestire una nuova flotta e una degna capitana. Così, sotto gli occhi dell'Imperatore, fu varata la Quadrireme, una galera maestosa, tanto sontuosa da far invidia agli antichi imperatori.
Le bandiere sventolavano, gli stemmi brillavano, e le parole latine adornavano le vele, mentre l'ammiraglio, ritratto come Nettuno, dominava con fierezza il mare.

Foto A Mae Zena
Nel 1538, a Genova, l'arrivo dell'Imperatore Carlo V e del Papa Paolo III fu celebrato con una grandiosa parata navale, una dimostrazione di potenza che preparava il terreno per una crociata contro gli Ottomani, preludio alla vittoria di Lepanto nel 1571.
Così, tra storia e leggenda, le navi del Principe solcarono i mari, portando con sé il destino di imperi e regni, tra le onde del Mediterraneo.
IL PALAZZO DEL PRINCIPE
VISTA FRONTALE

Foto: Tritaly.com
“Il Signor Principe facea fare una quadrireme, legno non usitato, per vedere se riuscita bene, per servirsene riuscendo molto utilmernte” raccontano i cronisti del tempo e ancora “L’Imperatore è sbarcato in la quadrireme, la quale è la più bella galera che si possa immaginare, e a popa li è preparata una cameretta ove dormirà esso et lo Infante Don Luis di Portugal”.
“La quadrireme è tale che a gran fatica non si potrebbe meglio pingersi et immaginarsi”… un altro storico… “Questo legno era con sì raro artificio et con tanta et si nuova magnificenza fabbricata, et ornato così riccamente, che pareggiava in questo genere le spese superbissime delli antichi imperatori”.
“Il Principe Andrea Doria ha fatto una galera per la cesarea Maiestà; quale dicono essere longa quindice palme et larga quatro più delle altr. Dove che nelle altre usano tre rafforzati (tre fila di rematori) per banco in questa ne usano quatro: E de qui preso il nome Quadrireme. In prora vanno tre gagliardi, che così dicono stendardi, con Bandere de damasco cremesin; longhe palmi ventitrè l’una, posti tutti in oro. In quello de mezo una stella tutta d’oro col campo pieno de razi et freze atorno, con littere che dicono, “Vias tuas Domine dimostra mihi (Signore mostrami le tue vie”.
Nelle altre dui la impressa de sua Maestà; con facelle de foco, con parole che dicono Ignis ante ipsum precedet (il fuoco lo precede).
Ne la bandiera della Gabbia qual pendeva fino al mare un Angelo molto grande con littere intorno che dicono Misit deus angelus suum ut custodiat te in omnibus viis tuis (Dio pose un suo angelo a custode delle tue vie).
Ne la bandiera de la Antena (pennone) uno Scuto, una celata (elmo), una spada con parole intorno Apprehende arma et scutum et exurge in adiutorium mihi (Afferra lo scudo e le armi e corri in mio aiuto).
Tre stendardi, dui de largheza de sette pezze, l’altro de otto longo palme vinticinque; l’altro trenta.

Foto: Galata Museo del Mare
“La poppa della ricostruzione di una galea genovese presso il Museo Galata”

Foto: A Mae Zena
“La prua della galea”
Nel grande il Crucifixo con freze (frecce) d’oro senza parole. Neli altri dui le armi de sua Maestà et staranno innanzi la popa dreto le qual anderà una bandiera de damasco biancho longa vintisei palmi; in mezo una pietra de littere Arcum conteret et confriget ; arma et scuta ombure tigni (l’arco si consuma e si spezza; brucia le armi e gli scudi col fuoco), et per lo campo chiave calici et croce de sancto Andrea. Dale bande duoi altre bandiere con littere intagliate Et plus ultra con l’impressa stemma di sua Maiestà.
Poi si ferno vintiquatro bandiere de damascho con campo gialo messo in oro con le arme de sua Maiestà: con le frezi rosse ne li cantoni de argento con le impresse de la sua Maiestà.
La Camera viene tutta intaliata de lavori bellissimi de legname messi in azuro et or, et de più altri paramenti di tela d’oro e d’argento.
Le pope viene medesimamente intagliata de uno Cendale de Veluto cremisino fodrato de brocato riccio sopra riccio; et un altro di scarlato pe ogni dì.
La Ciurma vestita di seta con camise lavorate di seta. L’arteglieria che è portata da ogni parte serà molto grossa e minuta.; gli huomini che ce andaranno si pensa che saranno ben vestiti et ben armati con questa et quatordece altre galere andava in Barzellona ove se intende che serà sua Maiestà. Et sono opinioni che voglia venir in Italia un’altra volta: pur il più crede che no, et che il Principe piglierà li sette mila spagnoli che sono in ordine per questa impresa: et l’armata de Spagna et de Portugallo et verrà in Sardegna. El signor Marchese con le altre galere et nave che son qui, imbarcarà li quatro milia italiani et sette milia Todeschi che sono in Lombardia, et andràno a napoli e de lì in Sicilia per pigliare cinque milia spagnoli che sono lì: et le galere passeranno in Sardegna”.

Foto Musei di Genova - Comune di Genova
“L’Ammiraglio ritratto da Sebastiano del Piombo”

Foto: Genova Today
Il quadro di Andrea Doria con il gatto Dragut
La tela, attribuita al pittore fiammingo William Key, ritrae il vecchio Andrea Doria, con il viso smunto e rugoso, una lunga barba bianca e, intorno al collo, il Toson d’Oro che gli ha donato Carlo v.
Il principe guarda lo spettatore con due occhi straniti, nonostante il carisma che emana la sua persona. Il gatto, robusto e nel pieno delle sue forze, invece fissa il suo padrone. C’è una tensione palpabile, un forte contrasto tra i due. Doria ormai è stanco e alla fine della sua vita, mentre il gatto Dragut appare maestoso nel suo portamento e dà una sensazione di sazietà e appagamento. Sic transit gloria mundi.
Da GENOVATODAY
Nell'immaginario popolare, ai gatti sono concessi un po' tutti i nomi, specie quelli stravaganti. E non manca chi ha deciso di chiamare il suo felino come un temibile pirata, nonché suo acerrimo nemico: è il caso del celebre ammiraglio genovese Andrea Doria, vissuto tra il '400 e il '500.
La storia è riportata alla luce dalla tela "Ritratto di Andrea Doria con il gatto" di William Key, conservata nelle sale di Palazzo del Principe. Nel quadro si vede il nobile con il suo grosso gatto Dragut. Ma chi era Dragut, e perché venne chiamato così?
L'ammiraglio, nel 1540, diresse alcune operazioni navali volte a frenare le continue incursioni dei corsari ottomani. Sotto il suo comando, suo nipote Giannettino in particolare riuscì finalmente a catturare Dragut, luogotenente di Khayr al-Din Barbarossa, il temibile "Barbarossa" comandante della flotta ottomana. Dragut venne consegnato all'ammiraglio Andrea Doria che - vista la pericolosità dell'individuo ma anche il prestigio della cattura - lo fece incatenare ai remi della sua nave per quattro anni. Dopo 48 terribili mesi in queste condizioni, ritenutolo ormai innocuo, lo fece vendere come schiavo. Insomma, la carriera di Dragut sembrava ormai finita, invece Barbarossa si ricordò di lui e, secondo alcune fonti, pagò un ricco riscatto per riportare ai suoi servizi il suo luogotenente. Questo la dice lunga di come Dragut fosse stimato.
Sulla base di questi racconti, si dice che Andrea Doria nutrisse un certo rispetto (e forse anche dell'affetto) nei confronti di un nemico così temibile e valoroso, che non si era arreso nemmeno dopo 4 anni di prigionia. Insomma, una di quelle persone che, se non fosse appartenuta a un fronte opposto, probabilmente Doria avrebbe voluto al suo fianco. E dunque, in suo onore, chiamò Dragut il proprio gatto.
Dragut immortalato al Palazzo Ducale

Foto: Wikipedia
Nelle nicchie sopra il cornicione della settecentesca facciata del Palazzo Ducale, disegnata dall’architetto Cantoni, sono presenti otto singolari sculture. Si tratta di otto statue realizzate (1777) dall’artista Giacomo Maria da Bissone che immortalano, incatenati e sottomessi alla Repubblica, otto grandi nemici di Genova. Da sinistra a destra sono lì posti ad eterna ed imperitura gloria della Superba.

Foto: A Mae Zena
Il pirata DRAGUT occupa la terza nicchia
Mare Nostrum Rapallo
RAPALLO: “mamma… li turchi” !
https://www.marenostrumrapallo.it/li-turchi/
RINGRAZIA

Per l’indispensabile contributo …
UNA VISITA CONSIGLIATA, REALE O VIRTUALE, PER CONOSCERE UN PEZZO IMPORTANTE DELLA STORIA E DELL’ARTE DELLA GENOVA RINASCIMENTALE
DORIA PAMPHILJ
-
BIGLIETTI
-
GALLERIA DORIA PAMPHILJ
-
VILLA DEL PRINCIPE
-
STORIA DELLA FAMIGLIA
-
IL TRUST
-
VISITA LA GALLERIA
-
VISITA LA VILLA
Villa del Principe - Palazzo di Andrea Doria - Genova

https://www.doriapamphilj.it/genova/la-visita/
Mare Nostrum Rapallo segnala il libro:
2015 - DRAGUT – AMMIRAGLIO E CORSARO OTTOMANO – Emilio CARTA
RINGRAZIAMENTI:
Per le immagini pubblicate a scopo divulgativo: Palazzo del Principe Genova
-
VISITGENOA
-
A MAE ZENA
-
TRIPADVISOR
-
ARTE E MUSEI
-
COMUNE DI GENOVA
-
GUIDA DI GENOVA
-
GENOVA TODAY
Carlo GATTI
Rapallo, 6 Maggio 2024
LA RAPALLO DI ALTRI TEMPI … LA TAVERNA AZZURRA
LA RAPALLO DI ALTRI TEMPI …
LA TAVERNA AZZURRA
Negli affascinanti anni del dopoguerra, quando la tensione della Guerra fredda permeava l'aria e le onde del Golfo Tigullio danzavano al ritmo delle navi da guerra americane, il mondo dei ragazzini come noi si dipingeva con note vibranti di colore e profumi impregnati di nuove scoperte, un quadro indelebile nel nostro album di ricordi.

Foto dell'autore

Di giorno, curiosi e pieni di meraviglia, ci avventuravamo lungo il Molo Langano di Rapallo per vedere gli alti e composti marinai americani sbarcare con le loro divise bianche, una visione affascinante che ci rapiva letteralmente. Era la prima volta che ci trovavamo di fronte a marinai di colore, una novità che ci riempiva di curiosità. Li seguivamo con gli occhi lucidi di meraviglia e, talvolta, ci sorprendevano con qualche dolciume, regali preziosi che custodivamo gelosamente nei nostri cuori di bambini, peraltro già emancipati da visioni orrende di bombardamenti e sparatorie notturne tra partigiani e nazifascisti.
Il profumo che emanavano, un misto di tabacco e sapone, ci avvolgeva come una carezza amichevole, lasciando dietro di sé una scia di pulito che sapeva di avventura e di mondi lontani.
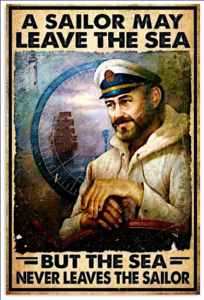
In quei momenti, le strade si riempivano di vita, con gruppi di marinai che si aggiravano tra le bancarelle di souvenir, mentre altri esploravano gli angoli più nascosti del centro storico alla ricerca delle “lucciole” che, ad ogni arrivo di navi USA alla fonda, giungevano numerose dalle tane dell’angiporto di Genova per aprire la caccia al tesoro con le loro fruttuose avventure da vivere e raccontare...
Note di colore che noi “scoprivamo” ascoltando i commenti dei più grandi che in seguito, per darci un tono malizioso, riferivamo ai nostri coetanei che tanti genitori tenevano ancora prudentemente per mano. Erano parole e concetti … che entravano per la prima volta in quel vocabolario che avremmo usato per sempre nel nostro quotidiano!
Alcune immagini della odierna TAVERNA AZZURRA …


E poi c'era la TAVERNA AZZURRA, un vero e proprio santuario della felicità, situato al centro della passeggiata a mare, dove una sinfonia di profumi esotici si mescolava con l’odore salmastro del mare. Il suo pianoterra ospitava un ristorante dai sapori autentici, mentre la terrazza sopraelevata si trasformava in un giardino incantato, ricco di colori, fiori e luci che incantavano lo sguardo e l'anima.

Ma era di sera che il vero incanto si manifestava. Nonostante le restrizioni imposte dai rigidi canoni educativi del tempo, noi ragazzini della collina di S. Agostino trovavamo rifugio nel magico mondo della musica che entrava con la brezza marina nelle nostre case fino a notte fonda senza chiedere il permesso.

Era il New World col suo jazz e swing, portate dalle big band nostrane alle prime armi, a creare un'atmosfera di festa e allegria che contagiava anche i nostri genitori, reduci dalle dure prove della guerra e desiderosi di ritrovare un po' di leggerezza e spensieratezza.
Insieme a quella “gioia musicale” che ci procurava emozioni e i primi brividi sulla nostra giovane pelle, eravamo travolti da odori intensi di carne alla brace che era un oltraggio alla miseria in cui eravamo nati e di cui ancora soffrivamo in quel periodo di dura e lenta ripresa.
Questa tavola imbandita di gioia e speranza era solo il primo capitolo di una storia di rinascita e speranza. Eravamo ancora con le pezze al culo, ma eravamo testimoni di un cambiamento epocale che avrebbe visto rifiorire tante altre "Taverne Azzurre" lungo i nostri litorali.
E così, tra profumi, colori e note di jazz, i ricordi di quei giorni lontani ma indimenticabili si fondono con la nostalgia di un tempo che non tornerà mai più, ma che continuerà a vivere nei nostri cuori per sempre.
Carlo GATTI
Rapallo, 2 Aprile 2024
OROMARE - TUTTI I SERVIZI DELLA SOCIETA' OROMARE DI GENOVA - PARTE SECONDA
OROMARE
PARTE SECONDA


TUTTI I SERVIZI DELLA SOCIETA’ OROMARE DI GENOVA
Molo Giano - Genova
Sede Ufficio Operativo
Direttore Generale

Michele ORONTI
Il porto di Genova si estende per circa 20 chilometri, offrendo infrastrutture per accogliere una vasta gamma di navi, dalle navi passeggeri alle petroliere, dai container alle imbarcazioni turistiche.
Mentre le grandi navi attraggono l'attenzione dei visitatori con la loro imponenza, c'è un mondo di attività meno conosciute che avvengono sottobordo. Tra queste, troviamo le barche da lavoro, silenziosamente impegnate nelle loro mansioni di supporto vitale per il funzionamento del porto.
Da chiatte a rimorchio a pontoni specializzati, queste imbarcazioni svolgono una miriade di compiti fondamentali. Sono le ancelle premurose delle navi, pronte a intervenire per riparazioni, trasbordi di carichi speciali, pulizia e manutenzione della carena. Spesso trascurate dall'occhio del visitatore, queste barche da lavoro svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema portuale.
In questo articolo, ci addentreremo nel mondo affascinante e poco noto dei servizi tecnici ed ecologici offerti dalle barche da lavoro nel porto di Genova. Esploreremo come l'industria marittima sia in continua evoluzione per soddisfare le esigenze del commercio moderno e affrontare le crescenti preoccupazioni ambientali. Dall'implementazione di pratiche sostenibili alla gestione delle attività offshore, scopriremo come il porto di Genova si adatti ai cambiamenti del tempo.
Questo viaggio ci permetterà di apprezzare non solo la vasta gamma di attività supportate dal porto, ma anche il ruolo cruciale degli imprenditori locali nell'innovazione e nel miglioramento di questo vitale snodo commerciale.
Dopo anni di lavoro nel porto di Genova, ho avuto il privilegio di scoprire la funzione strategica di un Armatore silenzioso, che con la sua Società si è affermato come uno dei pilastri centrali che sostengono le operazioni navali presso la "Superba".
Questa rivelazione ha accentuato ancora una volta la straordinaria capacità degli imprenditori liguri di affrontare sfide e intraprendere iniziative nell'ambito marittimo, soddisfacendo ogni esigenza delle navi che fanno scalo presso questo porto iconico.
Benvenuti a questa intervista dedicata al mondo dell'imprenditoria marittima, dove esploreremo il ruolo fondamentale di un nostro concittadino di Rapallo nel cuore del porto di Genova. Scopriremo come il tessuto industriale della regione sia intimamente intrecciato con le attività portuali che alimentano uno dei più grandi porti del Mediterraneo.
Senza ulteriori indugi, vi invito a esplorare insieme il mondo affascinante e vitale dell'imprenditoria marittima attraverso gli occhi e le esperienze del nostro interlocutore: Presidente Michele ORONTI al quale poniamo soltanto alcune parole-chiave.
Qual è il Profilo Aziendale della sua attività nel Porto di Genova?
Sin dalla sua fondazione Oromare ha concentrato esperienza e professionalità in un settore specifico, garantendo un valido supporto logistico ai cantieri navali ed ai terminal portuali, grazie al trasporto merci, attrezzature e materiali; collaborando con enti di primaria importanza, sia pubblici che privati; la tipologia e la consistenza dei servizi effettuati hanno portato la Società ad essere considerata un valido referente in termini di consulenza, di trasporto e di noleggio nel settore di specializzazione.
In ambito portuale la Oromare opera principalmente in tutto il territorio di Genova, per conto di Organismi Nazionali e Società di Gestione, realizzando servizi che vanno dai trasporti di carichi eccezionali agli imbarchi/sbarchi per sollevamento di carichi sino a 200 tonnellate, dal noleggio di distanziatori e scalandroni al trasporto di acqua dolce, dal ritiro e smaltimento acque nere/grigie al ritiro e smaltimento di rifiuti, dai disinquinamenti e bonifiche di specchi acquei ai lavori di marineria.
Servizi considerevoli sono stati realizzati sia in ambito nazionale che internazionale per grandi gruppi come Saipem S.p.A., Impresa Pietro Cidonio S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Fincantieri S.p.A., Navalmare S.r.l., Fagioli S.p.A., Officine San Giorgio del Porto S.p.A., T. Mariotti S.p.A., Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Terminal Sech S.p.A., Marina Militare Italiana e diversi Broker marittimi.
Quale è La Mission quotidiana?
Ogni giorno siamo impegnati nella nostra MISSION che è quella di fornire ai nostri clienti i migliori servizi di trasporto, rimorchio e sollevamento in termini di flessibilità, puntualità, costo e affidabilità, con la precisione e la qualità che ci contraddistinguono.
Passione, coraggio e rispetto sono i valori distintivi dell'azienda.
La cura in ogni dettaglio e l'attenzione nel seguire ogni esigenza del cliente sono per noi azioni imprescindibili per qualsiasi tipo di servizio offerto e tutti i nostri sforzi sono tesi a raggiungere questo risultato.
Crediamo quindi necessario esprimere la vision, la mission e i valori aziendali, così da far capire ai membri che compongono l'azienda, ai collaboratori e ai clienti dove vogliamo arrivare e i nostri futuri obiettivi.
Costantemente ci rapportiamo con tutti i nostri collaboratori affinché comprendano e condividano la visione ed il desiderio che abbiamo nell’eliminare ogni genere di problema per i Clienti.
Quali sono i principali sistemi di gestione integrata adottati da Oromare S.p.A. e quali standard internazionali seguono?
Come Politica Aziendale, Oromare da anni mantiene un sistema di gestione integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001.
I requisiti del sistema ci permettono di mantenere il passo dell’evoluzione del mercato e, nello stesso tempo, ci consentono di operare efficacemente nel rispetto dell’ambiente e alla sicurezza sul lavoro.
Il crescente coinvolgimento degli operatori e il costante impegno dell’Organizzazione sui temi ambientali e di sicurezza, nonché un netto miglioramento organizzativo sono stati i principali risultati diretti conseguiti attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato SQA.
A tale proposito vogliamo sottolineare l’impegno che dedichiamo e lo sforzo finanziario che affrontiamo tutti gli anni per mantenere armati ed in ottime condizioni tutti i nostri mezzi. Ogni prescrizione, modifica tecnica e sostituzione di elementi relativi le strutture della flotta, richiesta dall'Ente di Classifica (R.I.N.A.), viene osservata scrupolosamente.
Apportiamo sempre migliorie strutturali, peraltro non prescritte dall'Ente di Classifica, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle imbarcazioni sul piano della "qualità operativa". Le pitture utilizzate sono di nuova tipologia atte a garantire la salvaguardia dell’ambiente marino. Ogni fase della riclassifica e dell'armamento dei vari mezzi viene effettuata nel massimo rispetto sotto l’aspetto “Sicurezza ed Ambiente”.
Il miglioramento ambientale continuo viene perseguito stabilendo impegni per ridurre gli impatti che le attività svolte possono avere sul territorio, al fine di prevenire l’inquinamento e ridurre il consumo di risorse anche in conformità della legislazione vigente.
Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro siamo impegnati nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è attuata sia con il rispetto di tutta la legislazione applicabile, sia dei requisiti a cui l’Organizzazione stessa ha voluto aderire implementando il proprio sistema di gestione, tra cui vi è, nell’ottica del miglioramento continuo, un costante impegno nel coinvolgimento degli operatori ai quali vengono conferiti gli incarichi più congeniali e per i quali sono stati definiti programmi di formazione ed addestramento mirati.
Pertanto, i nostri obiettivi primari sono la piena adesione a tutti i requisiti e lo sforzo di operare garantendo la conformità alle norme di riferimento esercitando un adeguato controllo ed applicando tutte le misure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Data la totale assenza di malattie professionali e la bassissima presenza di infortuni degli ultimi anni, intendiamo migliorare le nostre prestazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro diminuendo o eliminando tutti quegli eventi collegati all’attività lavorativa che potrebbero provocare infortuni o malattie professionali, riesaminando puntualmente e periodicamente gli obiettivi e i traguardi.
Abbiamo stabilito criteri e metodi per valutare tutti i rischi con l’obiettivo di monitorarli costantemente aggiornando, di continuo, la valutazione dei rischi.
I nostri servizi, prima di essere predisposti, vengono valutati ed analizzati nel loro insieme al fine di prevedere tutti i possibili aspetti (tecnico, operativo, di sicurezza per gli operatori, di rispetto per l’ambiente, economico…).
Raggiunto il risultato si procede, in accordo col SPP, con l’istruzione e l’assegnazione degli incarichi ai vari operatori i quali sono guidati da esperti Comandanti e Direttori di Macchina.
Gli sforzi della Dirigenza, congiunti a quelli dei collaboratori, operanti in maniera sinergica e con affiatamento, sono ripagati dall’apprezzamento, da parte delle Autorità e della Clientela.
Per ottenere i risultati sopradescritti realizziamo programmi di addestramento del personale volti alla sicurezza, alla tutela ambientale ed al rispetto della conformità dei requisiti di qualità.
Qual è lo scopo del Codice Etico all'interno di Oromare S.p.A.?
Il Codice Etico e Modello OGC contiene l’indicazione dei principi etici rilevanti per Oromare S.p.A., anche ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01, e costituisce un elemento essenziale di controllo preventivo.
In termini generali il Codice Etico è il documento ufficiale della nostra Società che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità ai quali si ritiene debbano uniformarsi i comportamenti dei dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, pubblica amministrazione ed in generale di tutti coloro che entrano in contatto con la nostra realtà aziendale.
Il mio invito è quello di osservare i principi di seguito elencati, per contribuire ad accrescere il valore e la reputazione della nostra Società.
La ringrazio per la sua chiarezza e disponibilità!
Il nostro viaggio nel microcosmo portuale dell’antica Repubblica Marinara prosegue con il racconto dettagliato dello stesso Presidente Michele ORONTI.
SERVIZI OFFSHORE
Rimorchi d’Altura
Chiatte pontate
Rimorchi in tandem
La compagnia armatoriale genovese Oromare ha confermato a SHIPPING ITALY di avere ceduto il Sean Cristopher, (nella foto) datato rimorchiatore d’altura della sua flotta – è stato realizzato nei cantieri Campanella di Savona nel 1976 – che assumerà la bandiera del Togo e passerà nelle mani di un operatore attivo nell’offshore africano.
“Abbiamo siglato un Moa con l’acquirente, l’operazione si concluderà nel giro dei prossimi 60-90 giorni. Dopodiché, il Sean Cristopher, che non era armato, verrà rimorchiato in un cantiere navale in Francia dove verrà sottoposto a lavori per il rinnovo della classe” spiega Michele Oronti, alla guida della società nelle vesti di amministratore delegato. Trattandosi di un mezzo di una certa età, l’operazione ha un valore “risicato”, spiega Oronti, ovvero di “circa 55mila euro”. La sua cessione trova quindi ragione soprattutto nella volontà di ringiovanimento della flotta di Oromare, che si sposa anche con le esigenze dello stesso porto di Genova.
“La Port Authority ci ha chiesto di liberare nei prossimi mesi la sede in cui attualmente sono ormeggiati i nostri mezzi, a Calata Santa Limbania, per potere dare avvio ai lavori che interesseranno l’Hennebique e Ponte dei Mille” continua Oronti. “Il nuovo sito non è stato ancora individuato ma, dato che lo specchio acqueo a nostra disposizione potrebbe essere inferiore, abbiamo condiviso l’impostazione di mantenere in flotta i mezzi realmente operativi. L’ideale per noi sarebbe di poter disporre, in quel caso, di più spazio a terra in modo da condurvi alcune attività che oggi svolgiamo sui mezzi in mare”. Con quest’ottica, la compagnia sta valutando anche alcune demolizioni, in particolare di alcune delle sue chiatte più datate, che “in quel caso faremo fare a Genova, a San Giorgio del Porto (entrato peraltro recentemente nella compagine azionaria, ndr)”.
Sul fronte opposto, ovvero quello di eventuali ingressi in flotta, Oromare come già anticipato sta procedendo nell’iter per il riacquisto del Sea Dream da Ocean (di cui dispone ora sulla base di un noleggio a scafo nudo con la società triestina in scadenza a fine 2022 con opzione d’acquisto), per il quale sta vagliando alcune possibilità di finanziamento da parte di istituti bancari, mentre, conclude Oronti, pur continuando a osservare il mercato, valuterà successivamente ulteriori acquisizioni.
RIMORCHI D’ALTURA
Con il trascorrere degli anni, ampliando e rafforzando le nostre attività, ci siamo specializzati nei rimorchi d'altura in tutta l'area del Mediterraneo e non solo.
Grazie ai nostri rimorchiatori, i quali hanno diverse caratteristiche tra loro, siamo in grado di soddisfare tutte le diverse tipologie di servizio richiesto.
M/R SEA DREAM

Caratteristiche tecniche
-
BHP: 4.640 - 3460 BKW - 900 RPM
-
Tiro al gancio: 63,6 Tons
-
Velocità: 12,4 Nodi massima - 9 nodi economica
-
G.R.T.: 354 - N.R.T:. 106 - Dislocamento: 322 Tons - 96 Tons - 499 Tons
-
Dimensioni:
- lunghezza: 35,26 m.
- Larghezza: 10,00 m.
-
Pescaggio massimo: 4,63 m.
-
Spazio in coperta: 13 x 6,3 m. = 81,90 sqm
-
Capacità massima di carico: 85 Tons - 3 Tons/mq
-
Classificazione: RINA: C#Hull*MACH Tug; Navigazione illimitata
-
IMO: 9560259
-
Armatore: Oromare S.p.a. - Genova - Italia
-
Costruttore: Cantieri Damen
-
Anno di costruzione: 2011
-
Motore principale: 2 Caterpillar C280-6/CS
-
Propulsione: 2 Fixed pitch propellers in a propeller nozzle
-
Bow Thruster: 215 kW
-
Equipaggiamento: Cavi m 850 + m 450 + (m 750 spare)
- 1 x 850 m towing cable Ø 48 mm/12 layers
- 1 x 450 m towing cable Ø 48 mm/12 layers
- 1 x 750 m spare cable Ø 48 mm/12 layers
- 1 70 tons Towing Hook
-
Cam Fork A fork combined with 2 towing pins - WK-Hydraulics
-
Stern Roller: 35 Tons – Breadth: 3 m.
-
Gru idraulica: 2,2 tons at 8,60 m. - 1,25 tons at 12,60 m.
-
Alloggi: 8 singole cabine
-
Fabbricatore acqua: 4 MT/day
-
Capacità delle tanke: F.O. 163 MT (lt 193.000) - FW 15 MT
-
Miglia a velocità economica: 6.000
-
Brake Holding capacity: 1 x150 Tons + 1 x 100 Tons
-
Ancore: Chain - 2 x 360 Kg. - 2 x 8 lengths per ancora (175 m ognuna)
-
Battello di emergenza: Si
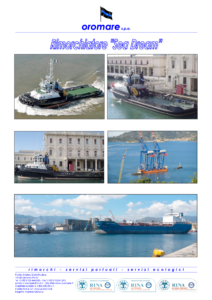
GIANEMILIO C.
Sean Cristopher in banchina

Caratteristiche tecniche
-
BHP: 3060HP - 2251 KW
-
Tiro al gancio: 48 Tonnellate
-
G.R.T.: 248 Tonnellate
-
N.R.T.: 74 Tonnellate
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 32 m.
- Larghezza: 8,50 m.
- Pescaggio: 4,80 m.
-
Spazio in coperta: 10,80 x 5,40 = 58 sqm
-
Velocità: 13 Nodi
-
Bandiera: Italiana
-
Armatore: Oromare S.p.a. - Genova - Italia
-
Costruttore: Coop Metallurgica Ing. G. Tommasi -Ancona - Italia
-
Anno di costruzione: 1983
-
Classificazione RINA: *100 A 1-1NAV. I.L. RE - N.° 62929
-
IMO N.°: 8209913
-
Nominativo Internazionale: I Z E H
-
Porto di registrazione: Genova - Italia - Int. Reg. N°48
-
Motorizzazione: Nohab Polar Type P 312 BHP 3060
-
Generatori ausiliari: 3 Auxiliaries Engines
-
Propulsione: 1 Controllable Pitch Propeller in Kort Nozzle
-
Bow Thruster: 2 Bow Thrusters
-
Sblocco gancio: Pneumatic Remote Controlled fm AFT and FWD of Wheel House
-
Capacità cisterna: F.O. 140 MT FW 60 MT
-
Equipaggiamento: 2 Drums Waterfall Winch ( NORWINCH)
- 1 x 572 m towing cable Ø 46 mm
- 1 x 300 m towing cable Ø 46 mm
- 1 50 tons SEEBEK Towing Hook
- 1 Stern Roller
- Il rimorchiatore è autorizzato a navigare in area A1 + A2
-
Alloggi Equipaggio: N. 8 cabine singole
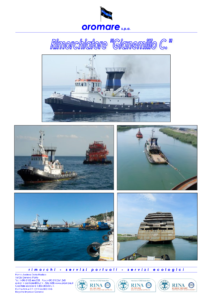
SEAN CHRISTOPHER
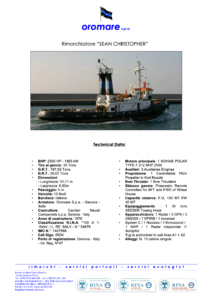
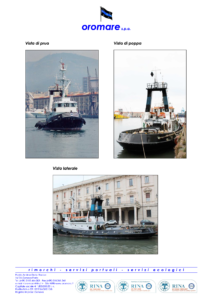
Caratteristiche Tecniche
-
BHP: 2500 HP - 1865 kW
-
Tiro al gancio: 35 T.
-
G.R.T.: 197,55 T.
-
N.R.T.: 26,07 T.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 31,11 m.
- Larghezza: 8,83 m.
- Pescaggio massimo: 4,40 m.
-
Velocità: 13 Nodi
-
Armatore: OROMARE S.p.a. - Genova - Italia
-
Costruttore: Cantieri Navali Campanella s.p.a. - Savona - Italia
-
Anno di costruzione: 1976
-
Classificazione RINA: *100 A 1-1NAV. I.L. RE. SALV.- N.° 54679
-
IMO N.°: 7427568
-
Call Sign: IRDK
-
Motore principale: 1 Nohab Polar Type F 212 - BHP 2500
-
Ausiliari: 3 Auxiliaries Engines
-
Propulsione: 1 Controllable Pitch Propeller in Kort Nozzle
-
Bow Thruster: 1 Bow Thrusters
-
Sblocco al gancio: Pneumatic Remote Controlled fm AFT and FWD of Wheel House
-
Capacità cisterna: F.O. 150 MT FW 45 MT
-
Equipaggiamento : 1 35 tons SEEBEK Towing Hook
-
Apparecchiature:
- 1 Radar / 3 GPS / 3 GMDSS / 1 EPIRB
- 1 Inmarsat - System C / 1 Navatex / 1 Echosound /1 WHF
- 1 Radar Trasponder /1 Autopolot
- il rimorchiatore è autorizzato a navigare in Area A1 + A2
-
Alloggi: 13 cabine singole
RIMORCHI IN TANDEM

SERVIZI PORTUALI
CHIATTE PONTATE
CASTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 30 m.
- Larghezza: 10 m.
- Profondità: 3 m.
-
Classificazione Ri.N.A: 100 A 1
-
N° iscrizione Ri.N.A: 55151
-
Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.
-
Navigazione: Internazionale
-
Certificato di classe: No. 9904793
-
Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56
-
Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks
-
Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258
-
Bandiera: Italiana
-
Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana
-
Data di costruzione: 1975
-
Impianto di pompaggio liquidi e zavorra
ORION II

Caratteristiche tecniche:
-
Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.
-
Classificazione RINA Pontoon; Special Navigation
-
N° iscrizione RINA 97672
-
Abilitazione: Trasporto carichi solidi e/o attrezzature sul ponte
-
Navigazione: Internazionale entro 20 miglia dalla costa
-
Caratteristiche principali: m 49,56 x 19,50 x 4,30 - TSL 1.080
-
Portata: 10T/m2 - Ton. 1.800 (Baricentro m. 3,70) – Ton. 1000 (Baricentro m.9,2) – Ton. 300 (Baricentro m. 20,0)
-
Spazio libero x caricazione: Completo – Bitte sotto altezza coperta
-
Bandiera: Italiana
-
Data di costruzione: 1977
-
Autorizzato all’imbarco RoRo: attraverso rampa da m. portata rotabile T. 90 – Per asse T. 8,5
MYKONOS 1°

Oromare S.p.A. ha preso parte, grazie alla capacità dei mezzi che compongono la sua flotta, tra cui un pontone galleggiante con una capacità di sollevamento fino a 200 t., a tutte le fasi di smantellamento del relitto Costa Concordia.
Il pontone, denominato "Mykonos I", è stato principalmente impiegato durante tutte operazioni riguardanti le fasi di sollevamento e trasporto dei cassoni usati per tenere a galla la nave.


Caratteristiche tecniche:
-
Tipologia: Galleggiante a biga per sollevamenti
-
Propulsione: Non autopropulso
-
Bandiera: Italiana
-
N° Iscrizione RI.N.A: 50528
-
Abilitazione: Sollevamenti in navigazione locale a rimorchio
-
Anno di costruzione: 1972
Caratteristiche principali:
-
Scafo: m. 36,24 x 18,24 x 3,02
-
Altezza biga: 60 m.
-
Pescaggio massimo: 2,5 m.
-
TSL: 783,38 t.
-
Ganci Da Sollevamento: N° 2
-
Portata: 1' gancio da 100 t. - 2' gancio da 200 t
-
Portata massima: 200 t.
Portate/sbraccio: (VEDI GRAFICO)
-
T. 200 - sbraccio m. 09 - altezza del gancio dall´acqua m. 27
-
T. 100 - sbraccio m. 18 - altezza del gancio dall´acqua m. 43
-
T. 50 - sbraccio m. 36 - altezza del gancio dall´acqua m. 19
SERVIZI PORTUALI
-
Rimorchi portuali e costieri
-
Fornitura acqua dolce
-
Distanziatori e parabordi
-
Sollevamenti eccezionali
-
Trasporto liquidi
-
Scalandroni e Lavori di marineria

Ritiro rifiuti

CASTORE
CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 30 m.
- Larghezza: 10 m.
- Profondità: 3 m.
-
Classificazione Ri.N.A: 100 A 1
-
N° iscrizione Ri.N.A: 55151
-
Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.
-
Navigazione: Internazionale
-
Certificato di classe: No. 9904793
-
Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56
-
Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks
-
Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258
-
Bandiera: Italiana
-
Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana
-
Data di costruzione: 1975
-
Impianto di pompaggio liquidi e zavorra
(Sopra e Sotto) - La Portaerei americana WASP ormeggiata all’OARN e presa in cura dai mezzi della OROMARE.

JANUARIUS

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Ufficio matricola : Ge 8752
-
Costruttore: Roncallo e Pastorino - Genova
-
Materiale di costruzione: Acciaio
-
Anno di costruzione: 1995
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 20,17 m.
- Larghezza: 4,00 m.
- Altezza al ponte di coperta: 1,90 m.
- Immersione massima: 1,4 m.
- Immersione minima: 0,9 m.
-
S.L.: 27 t.
-
Velocità in trasferimento: 8 nodi
-
Navigazione cui è abilitata: Nazionale Litoranea
-
Ruolino equipaggio:Persone N° 2
-
Tabella convenzionale: Persone N° 2
Apparato motore
-
Motori (N° e tipo): N° 2 CGT
-
Potenza: 172 x 2 KW (234 x 2 cv)
-
Giri: 2600
-
Eliche: N° 2 passo fisso
-
Generatori Elettrici: 2 c.a.380V-6KWA ed N.1 c.a.220V-4KWA
Apparecchiatura di navigazione/telecomunicazione
-
1 Bussola magnetica
-
1 Apparato VHF fisso + cellulare
Apparecchiattura per disinquinamento
-
Panne costiere mt. 100 gonfiabili - tipo "Mannesman"
-
Rullomotorizzato per panne: Si
-
Compressore per gonfiaggio panne: Si
-
Collegamento a scafo delle panne: Si
-
Ancora:Si
-
Corpi morti: Si
-
Gavitelli:Si
-
1 Skimmer per recupero idrocarburi da m.c. 80/ora
-
1 Discoil da m.c. 12 ora
-
Sistema direcupero Rifiuti solidi galleggianti: Cesto oleodinamico capacità m.c. 0,5
-
1 Contenitorie dedicato per rifiuti solidi recuperati da m.c. 2
-
Impianto fisso per irrorazione disperdenti: Si
-
Impianto fisso ad acqua per pulizia scogliere: Si con prevalenza mt. 30
-
Disperdente "terza generazione": Si da lt. 200
-
Casse strutturali dedicate ai disperdenti: Si x lt. 200

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Galleggiante non dotato di auto-propulsione
-
T.L.S.: 91,23 t.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 18,88 m.
- Larghezza: 8,50 m.
- Altezza: 2,0 m.
- Immersione a p.c.: 1,3 m.
-
Coperta: 160 mq.
-
Il pontone è dotato di 3 paratie stagne trasversali.
-
Portata: 150 t.
-
Matricola: GE 8891
SERVIZI PORTUALI
Rimorchi portuali e costieri
In ambito portuale la Società opera principalmente in tutto il territorio di Genova con piccoli rimorchiatori che, grazie anche all'ottima manovrabilità, riescono ad eseguire i servizi in maniera affidabile ed in totale sicurezza.
SEPORT PRIMO

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Stazza lorda : 40,05 t.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 17,07 m.
- Larghezza: 4,82 m.
- Altezza di costruzione: 2,07 m.
-
Motore: N° 2 motori diesel sviluppanti un potenza di HP 500
-
Tiro al gancio: 12 t.
-
Velocità: 14 Knts
-
Scafo in acciaio con parabordi perimetrali
-
Ottima manovrabilità
-
Scafo interamente pontato
-
Superficie scoperta ed agibile a pp.: mq. 20
-
Cabina con tavolo e divani per poter ospitare 10 prs
-
Abilitazione alla NNLS entro 3 miglia dalla costa
-
Telefono cellulare
-
Radar
-
Generatore elettrico da 7300 W
-
Spingarda ad alta pressione
SEPORT SECONDO

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Stazza lorda : 40,05 t.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 17,07 m.
- Larghezza: 4,82 m.
- Altezza di costruzione: 2,07 m.
-
Motore: N° 2 motori diesel sviluppanti una potenza di HP 500
-
Tiro al gancio: 12 t.
-
Velocità: 14 Knts
-
Scafo in acciaio con parabordi perimetrali
-
Ottima manovrabilità
-
Scafo interamente pontato
-
Superficie scoperta ed agibile a pp.: mq. 20
-
Cabina con tavolo e divani per poter ospitare 10 prs
-
Abilitazione alla NNLS entro 3 miglia dalla costa
-
Telefono cellulare
-
Radar
-
Generatore elettrico da 7300 W
-
Spingarda ad alta pressione
GIADA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stazza lorda: 11,92 t
-
Motore: 170 HP
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 11,50 m.
- Larghezza: 2,72 m.
-
Trasporto rifiuti solidi sino a m.c. 10
-
Trasporto materiale in stiva sino a T. 5
-
Trasporto rifiuti liquidi in tanks sino a m.c. 5
-
Anno di costruzione: 2008
VENEZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Stazza lorda: 20,21 t
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 13,13 m.
- Larghezza : 3,50 m.
-
Pescaggio: 1,80 m.
-
Motore: 10 Cv
-
Potenza al gancio: 5 t.
DISTANZIATORI E PARABORDI


CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Stazza lorda:180,71 t.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 32,30 m.
- Larghezza: 7,94 m.
- Altezza: 2,50 m.
-
Anno di costruzione: 2001
-
Servizio: Trasporto acqua dolce
-
Capacità: 400 t.
-
Impianto pompaggio liquidi e zavorra
SOLLEVAMENTI ECCEZIONALI

Smantellamento relitto Costa Concordia

Rimozione motori Ursa Major

TRENO AD ANDORA- deragliamento treno sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia
TRASPORTI LIQUIDI
ALISEA

CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Stazza lorda:180,71 t.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 32,30 m.
- Larghezza: 7,94 m.
- Altezza: 2,50 m.
-
Anno di costruzione: 2001
-
Servizio: Trasporto acqua dolce
-
Capacità:400 t.
-
Impianto pompaggio liquidi e zavorra
CASTORE - POLLUCE



CARATTERISTICHE TECNICHE
-
Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.
-
Dimensioni:
- Lunghezza: 30 m.
- Larghezza: 10 m.
- Profondità: 3 m.
-
Classificazione Ri.N.A: 100 A 1
-
N° iscrizione Ri.N.A: 55151
-
Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.
-
Navigazione: Internazionale
-
Certificato di classe: No. 9904793
-
Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56
-
Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks
-
Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258
-
Bandiera: Italiana
-
Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana
-
Data di costruzione: 1975
-
Impianto di pompaggio liquidi e zavorra
SCALANDRONI E LAVORI DI MARINERIA

POSIZIONAMENTO PANNE

SERVIZI ECOLOGICI

Ritiro RifiutI
Ritiro ACQUE NERE/GRIGE

Disinquinamento Bonifiche

contatti
Direttore Generale
|
|
Reparto Commerciale
|
Reparto Operativo e Rapporti con Enti
|
Ufficio Acquisti e Servizio Clienti
|
Reparto Amministrativo
|
Carlo GATTI
Rapallo, 20 Marzo 2024



























