MOBY PRINCE, un'altra Ustica?
MOBY PRINCE
Un'altra Ustica?


Foto n.1 – La Moby Prince in navigazione
Quella fatale coincidenza
Abbiamo già avuto occasione di occuparci della tragedia del traghetto MOBY PRINCE della Soc. Navarma, ma solo per rimarcare la fatale coincidenza con un’altra catastrofe del mare: l’incendio e il successivo affondamento della petroliera HAVEN davanti alle acque di Arenzano. Tredici ore separarono la collisione del traghetto italiano dall’esplosione della petroliera cipriota e tutto avvenne a sole 75 miglia nautiche di distanza.
Porto di Livorno. Alle 22,25 del 10 aprile 1991, il traghetto Moby Prince si staccò dalla banchina e sbarcò il pilota con le stesse modalità compiute centinaia di volte in precedenza. Navigò per un breve tratto di canale e poco dopo s’infilò nella fiancata della petroliera Agip Abruzzo prendendo fuoco: 140 vittime, un solo sopravvissuto. Fu la più grave sciagura della marineria civile italiana.
Sono passati quasi vent’anni, ma nell’immaginario collettivo è sempre vivo l’ignobile cliché diffuso ad arte sui media il giorno successivo l’incidente:
“Fitta nebbia, un comandante distratto dalla partita di calcio, una rotta sbagliata, tragica fatalità”. D’altra parte, questa "verità" fu il risultato delle Commissioni d’Inchiesta della Capitaneria di Porto di Livorno e del Ministero della Marina Mercantile. Chissà! Forse era la spiegazione più semplice… Ma oggi, sotto la spinta della:
“Associazione 10 Aprile - Familiari delle vittime del Moby Prince” www.MobyPrince.it
è stato compiuto un impressionante percorso di riscoperta degli atti, delle carte e dei documenti, che erano già fin troppo chiari, ma occorreva leggerli ed interpretarli con onestà e consapevolezza. Purtroppo altre prove e testimonianze sono venute alla luce quando la traccia era ormai segnata, quando l’inchiesta sommaria e i successivi due gradi del processo si erano ormai incanalati verso “la tragica fatalità”. Oggi, improvvisamente il vento è cambiato, sia per la lotta e l’amore della citata Associazione, sia per la determinazione e il coraggio dimostrato da alcuni onesti professionisti dell’informazione.
Una Indagine Provvidenziale
La vicenda del traghetto-passeggeri è tornata alla ribalta in questi ultimi anni per la tenace ricerca di Enrico Fedrighini, milanese, già consigliere presso il Comune e la Provincia di Milano che ha dato il primo colpo di piccone alle sentenze della magistratura, con il suo libro “Moby Prince. Un caso ancora aperto”. Quattro anni è durato l’impegno dell’autore per analizzare faldoni processuali, relazioni, inchieste amministrative e perizie. «Ebbene, c’è tutto nelle carte. Occorreva metterle insieme. Nell’impressionante mole di documenti c’è quanto basta per dire che quella verità è fasulla e che nella rada del porto di Livorno è accaduto ben altro. Qualcosa che abbiamo il diritto di sapere. Perché è una brutta storia, una storia che fa paura». Ha dichiarato recentemente l’autore.
Ma in occasione dell’anniversario del disastro, scende in campo anche Giovanni Minoli, direttore di Rai Educational, riportando l’attenzione degli italiani sul “Moby Prince" diventato ormai un “CASO”. «Questa indagine giornalistica alla fine lascia grande angoscia», dice Minoli. «Emergono grosse novità rispetto alla verità ufficiale" – e aggiunge – Il "Moby Prince" è un’altra Ustica, di cui non erano conosciuti, finora, i contorni inquietanti. Il mio auspicio è che, alla luce di queste novità, presto ci si occupi del caso con una commissione d’inchiesta».
Lo scrupoloso giornalista della RAI ce lo ha raccontato un mese fa in TV sottoponendoci carte nautiche della rada di Livorno; proponendo numerose registrazioni di conversazioni radio di operatori portuali in servizio quella notte; nuove prove satellitari emerse dopo le conclusioni delle inchieste. Proviamo ora a calarci nel merito di queste nuove analisi sintetizzandone i contenuti:
- Non è stata trovata traccia di apparati televisivi sul ponte di comando della M.P. che avrebbero accusato di negligenza il comandante Ugo Chessa ed il suo equipaggio – Vedi Nota
- L’Avvisatore Marittimo (di guardia in porto H-24) e molti altri testimoni hanno testimoniato che la rotta percorsa dal traghetto era giusta e prudente e non corrispondente a quella ipotizzata nelle inchieste. Purtroppo la testimonianza di questo “antico” servizio portuale non è mai stato richiesto.
- La Agip Abruzzo quella sera aveva cambiato diverse volte la posizione d’ancoraggio senza avvisare le Autorità e dai tracciati radar risulta, inoltre, che la petroliera si trovava ancorata in zona proibita, all’interno del canale d’uscita del porto di Livorno. Questa tesi è confermata dalle registrazioni di conversazione e degli ordini impartiti dal comandante Superina della Agip A.
- Il Centro Meteo dell’aeronautica di Pratica di Mare e la Criminalpol documentano la mancanza di nebbia al momento dell’impatto. Probabilmente questo elemento e l’accusa d’imprudenza nei confronti di chi non può più difendersi, serviva a nascondere un’altra realtà.


F.2 - La petroliera Agip Abruzzo in fiamme
- Si è anche udita - molto nitidamente - la voce registrata dell’unico superstite del traghetto, il mozzo Barnard, affermare alla radio degli ormeggiatori che lo avevano raccolto a bordo, che c’erano ancora superstiti vivi sulla Moby Prince. Ma nessuno si preoccupò di rintracciare la nave alla deriva nella rada, con il suo carico umano che stava lentamente soffocando.
- Ci fu poi l'episodio del cadavere sul ponte. In un filmato girato da un elicottero dei Carabinieri all’alba dell'11 aprile, si è visto chiaramente un cadavere disteso sulla schiena a poppa, sulle lamiere bruciate. Al momento delle riprese aeree, si è potuto notare come l'uomo non fosse bruciato (indossava una maglia rossa n.d.r.), ma, al contrario, si mostrasse stranamente integro pur trovandosi sul ponte distrutto dalle fiamme. Successivamente, nei video girati dai Vigili del fuoco, lo stesso uomo è apparso completamente carbonizzato, avvalorando cosi la nuova ipotesi secondo cui parte dei passeggeri non morì in breve tempo per effetto del monossido di carbonio sprigionato dall'incendio. L'ipotesi smentita in fase processuale da alcune perizie, ma accettata da altre, è quella che il passeggero, sopravvissuto durante la notte all'incendio e ai fumi tossici, sia uscito alle prime luci dell'alba per raggiungere i soccorritori, ma a causa dell'enorme calore ancora sprigionato dalle lamiere del ponte, sia morto in un secondo tempo.
- Nel settembre del 1992, venne trasmesso dai telegiornali un video amatoriale girato da un passeggero nei minuti precedenti la collisione. Il fatto che la cassetta trovata in una borsa nel salone De Lux, abbia resistito all'incendio, dimostrerebbe che, almeno in quella zona della nave, non c’erano temperature elevatissime e che una parte di passeggeri/equipaggio abbia potuto resistere a lungo in quelle circostanze.


Foto n.3- Il traghetto il giorno dopo
- I soccorsi partiti immediatamente si sono diretti tutti sulla Agip Abruzzo. Nessuno verso la Moby Prince che venne lasciata in fiamme, alla deriva con il suo carico umano che, diligentemente, aspettava di essere salvato. Moriranno dopo ore di paura, angoscia e disperazione. Eppure la Moby era ben visibile in rada, come dimostra l’episodio dei due bravi ormeggiatori che, con la loro imbarcazione portuale, accorsero spontaneamente a prestare soccorso e trassero in salvo l’unico sopravvissuto: il mozzo Barnard, e proprio da loro partì la comunicazione alla Capitaneria di Porto che indicava la posizione del traghetto e la necessità di soccorrere altri passeggeri ancora in vita. Le Autorità rimasero silenti, nonostante la presenza del Comandante del porto di Livorno a bordo di una motovedetta di servizio. Chi aveva il compito di coordinare le operazioni di salvataggio, tacque per più di 5 ore. I soccorritori aspettarono invano le istruzioni, mentre sulla Moby Prince si moriva.
- Le persone a bordo del Moby Prince non sono morte in pochi minuti, ma dopo ore come hanno dimostrato i referti delle autopsie.
- L’impatto non è stato improvviso. Tutti i passeggeri erano nel salone De Lux (stanza provvista di porte tagliafuoco) con bagagli e giubbotti di salvataggio.
Ciò significa che erano stati rigorosamente radunati là, dove sono stati trovati. Nessun corpo presentava traumi. Difficile quindi conciliare tutto ciò con l’impatto improvviso causato, per di più, dalla negligenza del personale che guardava la partita in TV.
- Soccorsi impossibili? I responsabili della sicurezza sostennero che, data la temperatura delle lamiere, era impossibile salire sul Moby Prince. Nulla di più falso. In quella maledetta notte, alle ore 3.30 un coraggioso marinaio, Giovanni Veneruso, senza alcun tipo d’indumento ignifugo, con il suo rimorchiatore privato decise di avvicinarsi al traghetto ed agganciarlo, mentre le motovedette della Capitaneria osservavano immobili a distanza. Il giovane toccò le lamiere senza problemi, salì a bordo, si guardò in giro e subito gli giunse l’ordine perentorio di abbandonare la nave. Perché?- Sono emerse testimonianze circa la presenza di “strane” imbarcazioni che si sarebbero avvicinate al traghetto con l’intenzione d’abbordarlo e che improvvisamente scomparvero dalla scena del disastro. Cosa cercavano?

Foto n.4 - Base USA di Camp Darby
A questo punto ricordiamo che l’Alto Tirreno è una delle zone più presidiate da impianti di telecomunicazioni militari. La base americana di Camp Darby è molto vicina a Livorno e La Spezia, che insieme formano un sistema integrato di controllo. Tuttavia le anomalie “fuori controllo” furono davvero numerose e tutte senza ragionevoli spiegazioni: - Testimoni non ascoltati – responsabili in servizio, quella notte, non interrogati - Tracciati radar non acquisiti, negati, distrutti - Posizioni delle navi in rada non accertate - Fascicoli scomparsi dalla Procura - Relazioni sparite - Scatole nere distrutte - Giornali di bordo dimenticati - Manomissioni e sabotaggi operati sul relitto del Moby Prince - Tracce di esplosivo militare a bordo del Moby mai presi in esame - Nastri registrati scomparsi - Cassette VHS manomesse – L’elicottero militare che sorvolava la zona al momento della collisione, ignorato e dimenticato - Navi “fantasma“ che si allontanano dal luogo dell’impatto velocemente - Presenza di pescherecci italo-somali i cui nomi compaiono, forse non a caso, nell’omicidio di Ilaria Alpi - Ufficiali che quella sera vedono e relazionano su movimentazioni di materiale bellico tra navi nel porto di Livorno, ma i cui rapporti scompaiono - Alcuni importanti documenti confermano che nella rada di Livorno era in corso una operazione destinata a rimanere “coperta” e che coinvolgeva un numero imprecisato di imbarcazioni - Operazione che doveva restare segreta: 5 navi militari americane cariche di armi provenienti dal Golfo Persico, dove si era appena conclusa l’operazione Desert Storm, erano presenti in zona e sembra ormai accertato che stessero sbarcando materiale bellico destinato alla base di Darby su chiatte a rimorchio e senza luci di posizione.
Il relitto della Moby Prince fu fatto demolire in fretta, lontano dall’Italia, in Turchia, ad Allaga, località tristemente nota, come più volte denunciato da Greenpeace, perché specializzata nel togliere di mezzo navi sospette e pericolose.
Tutto questo porta a ritenere che, quella sera, la zona del porto di Livorno doveva essere tra le più sorvegliate d’Italia da tutti gli operatori civili e militari, Servizi Segreti compresi.
“Quella del 10 aprile è una bella sera di primavera. Il mare è calmo, la visibilità è di 5-6 miglia. Una leggera brezza salmastra mischiata ai vapori della ciminiera della nave penetra nelle narici e accarezza i volti dei pochi passeggeri rimasti sul ponte esterno del traghetto a osservare le luci della città”, scrive Fedrighini. “Sono le 22,03 quando la nave passeggeri molla gli ormeggi e si allontana scivolando sulle acque scure e oleose. Destinazione Olbia. I passeggeri vengono accolti a bordo dalle note musicali di una canzone degli anni ’60, “Quando, quando, quando”. Accadono le solite cose: c’è chi si prepara per la notte, chi chiacchiera, chi beve una birra al bar. Non si tratta di una sceneggiatura, purtroppo”, aggiunge Fedrighini. “Quelle piccole cose banali che ogni persona compie rappresentano gli ultimi istanti di un’intera vita. Centoquaranta persone stanno scrivendo le ultime parole sulle pagine di un libro che per loro è destinato a interrompersi di lì a pochi minuti”. Il "dopo", ossia questi 19 anni in cui i familiari delle vittime hanno chiesto verità, è la parte più inquietante della vicenda: un’inchiesta amministrativa conclusa a tempo di record (11 giorni); questa e molte altre "stranezze" scovate da Fedrighini e Minoli fanno di questa dimenticata strage italiana, la più inquietante. L’ennesimo mistero d’Italia. Con Ustica successe la stessa cosa. Ricordate? Anche in quel caso la Commissione di inchiesta stabilì che l’aereo Itavia era caduto per un cedimento strutturale. Non a caso la strage del Moby Prince viene chiamata l’Ustica del mare. Per sapere la verità sulla tragedia del Moby Prince non si deve fare chissà quali ipotesi fantasiose, non si deve aderire a strampalate ipotesi degli amanti dei complotti o altro, è sufficiente leggere gli atti, i documenti, le testimonianze...... E, a questo proposito, vi segnaliamo l’Atto di Opposizione (http://www.mobyprince.it/files/OPPOSIZIONE-ALLA-RICHIESTA-DI-ARCHIVIAZIONE-17.05.2010-definitiva) prodotto dall’avv. Carlo Palermo a difesa dei signori Angelo e Luchino Chessa (figli del comandante del M.P.) e Maurizio Giardini, parti offese nel proc.pen. N..... relativo al decesso di 140 persone nell’incidente del M.P.
Nota: Comandanti e piloti sono sempre sotto esami, perchè la manovra è la parte più difficile del viaggio e tra questi due personaggi spesso si saldano vincoli di amicizia e di stima che si perpetuano oltre il “retire”. Ugo Chessa, comandante del Moby Prince non arrivò alla pensione perchè morì tragicamente in servizio, nonostante fosse considerato nell’ambiente il miglior comandante di traghetti in quegli anni e sono più che certo che nessuno di noi ha mai creduto, neppure per un istante, all’infamia e al disonore di cui fu vittima questo “grande marinaio”.
Carlo GATTI
Rapallo, 28.05.11
LONDON VALOUR - Il GIORNO del Diavolo
LONDON VALOUR
IL GIORNO DEL DIAVOLO
LA ROTTURA DEI TEMPI

Foto n.1 - Quando l'anticiclone delle Azzorre si ritira verso W, si apre una porta ai flussi di aria fredda marittima di origine atlantica che, provenendo da NW e correndo lungo il bordo dell'alta pressione, giungono in Mediterraneo accelerate dal corridoio (vedi freccia nera nella carta meteo). Si stabilisce così il regime dei venti di Maestrale, caratteristico di queste zone, che sorgono spesso improvvisamente, forti nel golfo del Leone, più forti sulle coste occidentali corse e ulteriormente accelerati dall’imbuto delle Bocche di Bonifacio.
Caratteristica del Maestrale
Talvolta si possono verificare situazioni peggiorative, come quando nel golfo di Genova si viene a creare una "depressione sottovento" dovuta a un brusco abbassamento della pressione a ridosso all'arco alpino, oppure se si verifica una situazione di bassa pressione sull'Europa orientale, che concorre con la sua circolazione ciclonica all'accelerazione delle correnti da NW. Nel nostro emisfero le depressioni girano nel senso orario, pertanto, il fenomeno meteo inizia a Scirocco (SE), si rinforza a Libeccio (SW) e sfonda a Maestrale (NW). Il mese di aprile è spesso interessato da questo pericoloso fenomeno che i marinai chiamano rottura dei tempi e sui bordi la gente di mare drizza le antenne quando appare il mare lungo. Si tratta sicuramente di quel sintomo ancestrale che localizza, in una zona non troppo lontana, un vento tempestoso che avanza inesorabilmente e con il quale, presto, si dovrà fare i conti…
IL GIORNO DEL DIAVOLO
In questa premessa c’è la spiegazione di quanto successe quarant’anni fa, in quel famigerato 9 aprile 1970 che vide sfracellarsi sulla diga del porto di Genova la T/n London Valour. Chi c’era non può che ricordarlo come “il giorno del diavolo”. 22 persone perirono sotto gli occhi di una città attonita, sbalordita e impotente dinanzi ai terribili colpi di mare sollevati da un vento che in poche ore girò da Scirocco a Maestrale rinforzandosi ad ogni quadrante della rosa dei venti. In quelle condizioni estreme, raramente viste dai genovesi, a poco o nulla valsero i numerosi tentativi di salvataggio improvvisati dai coraggiosi soccorritori.
I Fatti
Il 2 Aprile 1970 la nave partì da Novorossisk diretta a Genova con 23.606 tonnellate di cromo. Il 7 Aprile giunse a Genova e diede fondo l’ancora in rada, nell’attesa d’andare in banchina per le operazioni di scarico.
Alle 12.00 del 9 Aprile la pressione barometrica era molto bassa: 748 mm. Il vento era debole e spirava ancora da Scirocco. La diga foranea spariva letteralmente sommersa dalla risacca e quel gonfiore del mare mostrava in quel momento un fenomeno meteo esagerato, mai visto prima: senza onde e senza vento, il porto e la città non avevano più protezione, la diga era come inghiottita. Secondo le testimonianze di bordo, nessun avviso di burrasca era stato emesso via radio o segnalato nell’ambito portuale dal Semaforo della Lanterna. Alle 13.00 il vento girò a SW ed andò aumentando d’intensità.
Ci fu una riunione sul ponte di comando della London Valour, ma il comandante D. M. Muir non diede particolari disposizioni e si ritirò in cabina con sua moglie.
Alle 13.30 l’ufficiale di guardia sul ponte avvisò il Comandante e l’ufficiale di guardia in macchina che il tempo era in netto e rapido peggioramento, ma fu il 1° Ufficiale di coperta che, scorgendo dal suo oblò la diga estremamente vicina, diede l’Allarme Generale.
Il C. Macchinista recepì l’emergenza e si prodigò per accelerare al massimo l’avviamento della turbina. Purtroppo la prontezza a manovrare la macchina fu data soltanto pochi minuti dopo l’impatto della nave contro la diga.
Alle 13.50 il vento da libeccio era forza 8 e il barometro segnava il valore più basso della giornata 742 mm.
M/n LONDON VALOUR
|
Nave |
Varo |
Ristrut. |
Stazza L. |
Lungh. |
Largh. |
Equip. |
|
London Valour
|
1956 Haver. U.K. |
1967 La Spezia |
15.875 |
174.73 mt |
21.43 mt |
56 58 * |
* La cifra è riferita al momento del naufragio. Essa comprende la moglie del Comandante e quella del Marconista che erano ospiti a bordo e non facevano parte dell’equipaggio.
L’Impatto
Nel frattempo il fortunale da libeccio raggiunse e superò i 100 Km/h sollevando onde eccezionalmente alte e violente che si abbatterono frontalmente contro la diga foranea. Verso le 14.25, l’ancora del mercantile britannico London Valour non mordeva più il fondale e cominciò ad arare e in pochissimi minuti la nave scarrocciò per 1300 metri, dalla sua posizione d’ancoraggio fino allo schianto contro la scogliera frangiflutti della testata di levante della diga Duca di Galliera.

Foto n.2 - La London Valour in agonia sugli scogli della diga. Alcuni naufraghi sono visibili in controplancia. Notare a sinistra l’imbarcazione dei piloti che si è impennata sulla cresta di un’onda.
Sul posto arrivarono i piloti portuali, l’elicottero dei VVFF, rimorchiatori, motovedette della Capitaneria, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia, Alle 14.45 i valorosi Vigili del Fuoco misero in funzione un va e vieni, (una doppia cima di nylon tesa tra la diga e il ponte di comando), sul quale scorreva una carrucola munita di cintura a braga per consentire il salvataggio di un naufrago per volta.
La nave si spaccò in due tronconi e i membri dell'equipaggio si trovarono divisi in due gruppi, tutti muniti di giubbotto salvagente. Dorothy, la moglie del comandante Edward Muir, fu sbalzata dall’imbragatura della precaria funivia e precipitò tra gli scogli spazzati dalle onde, sotto gli occhi del marito, nonostante i tentativi di salvataggio di un Vigile del Fuoco che si tuffò invano più volte. I depositi di nafta cedettero e il combustibile, nero e denso come catrame, si sparse in mare e avviluppò i naufraghi caduti in acqua. Tra questi, il comandante del mercantile, che rifiutò l'aiuto di un soccorritore, si slacciò il giubbotto e si lasciò andare.

Foto n.3 - “Volteggiava sulla scena del disastro, sfidando la bufera, il leggendario elicottero dell'ardimentoso capitano Enrico, eroe dei Vigili del Fuoco che poco tempo dopo non sarebbe più rientrato da un'ennesima operazione di salvataggio”.
Le operazioni di Salvataggio
Nella fase iniziale della tragedia, una parte dell’equipaggio si era concentrato presso il cassero centrale della nave. Questa era la zona più pericolosa perché battuta e schiacciata tra le onde e la diga.
Un razzo ed una cima di collegamento furono comunque sparati sulla diga ed i Vigili del Fuoco riuscirono ad approntare il già citato Va e Vieni, che poté salvare tre marinai indiani. L’apparato sembrava collaudato ed il Comandante convinse la moglie a mettersi in salvo, ma subito dopo s’inceppò. Alla signora Muir mancarono le forze per resistere aggrappata alla teleferica e precipitò tra gli scogli dinanzi agli occhi atterriti dell’equipaggio e del marito che, incurante del pericolo, volle darle l’estremo saluto con la bandiera inglese (Union Jack, N.d.A.). Questo fu il momento più drammatico e commovente della tragedia che colpì la nave ed il nostro scalo.
Poco dopo, un’onda gigantesca spazzò via il marconista Mr. Hill e sua moglie che sparirono insieme ed annegarono tra i flutti. Il 2° Macchinista Mr. Carey fu strappato dalla stessa onda e scaraventato in mare, ma fu miracolosamente salvato dalla ciambella dell’elicottero del Cap. Enrico. In quell’occasione il Comandante fu visto per l’ultima volta, era ferito gravemente ad una gamba e volle seguire la stessa sorte di sua moglie.
La stessa incredibile onda aveva sollevato il 1° Ufficiale di coperta Mr. Kitchener, 31 anni, di due piani, sino alla Monkey Island (il ponte della “bussola normale”, ubicata sopra la timoneria, N.d.A.), dove già si trovavano il Cadetto Mr. Lewis ed altri marinai indiani. Questi ultimi, sebbene sollecitati dai loro superiori, rifiutarono il tuffo della speranza e perirono massacrati tra gli scogli.
Gli Ufficiali inglesi furono invece salvati dai Piloti del porto e dalla vedetta del capitano Telmon della Capitaneria di porto. Una parte del personale che si era concentrato a poppa si salvò per due fattori principali:
a)- Il coraggio e l’iniziativa dimostrata dal 2° Ufficiale inglese, Mr. Donald Allan McIsaac, 25 anni. (L’ufficiale che era di guardia sul ponte di comando nel momento del naufragio, N.d.A.)
b)- Nell’impatto con il terminale della diga, la poppa della nave risultava libera e sporgente. Da quella posizione più esterna, i più coraggiosi tra l’equipaggio si gettarono in mare e subito dopo furono raccolti dai soccorritori.
Altri provvidenziali salvataggi avvennero tramite il collegamento nave-diga approntato e curato con estremo coraggio dai Vigili del Fuoco e dai marinai della nave.
Tra i tanti atti di coraggio e di grande valore compiuti dai genovesi, desideriamo ricordare quello che si verificò alle 16.17 quando, sulla cresta di un’onda gigantesca, arrivo un naufrago, tutto nero di catrame, al di là della barriera di protezione del canale di calma. Italo Ferraro, un pallanuotista-sub di quasi due metri, si tuffò con muta e pinne dal terrapieno della Fiera e, come un angelo calato dal cielo, afferrò il marinaio, lo mise in salvo e poi sparì. Nell’impatto della nave contro gli scogli appoggiati alla diga, lo scafo subì notevoli spaccature, dalle quali straripò il fuel oil, con cui venivano accese le caldaie. Il prodotto combustibile si sparse in mare, la cui superficie divenne una lastra nera che imbrattò completamente i naufraghi tanto da renderli irriconoscibili, estremamente scivolosi e quindi difficilmente catturabili dai soccorritori.
Le vittime
Nel disastro perirono 22 persone. Si salvarono 38 membri dell’equipaggio: i più coraggiosi, coloro che si tuffarono in mare e furono spinti dalle onde tra le braccia dei soccorritori che si erano appostati un po’ ovunque, in quelle acque vorticose, schiumose ed impazzite.
Nei giorni successivi, gli stessi media Inglesi definirono eroico il comportamento dei soccorritori genovesi che intervennero in quelle drammatiche operazioni di salvataggio
Una delle Verità
Quando, dopo il naufragio, i sommozzatori s’immersero per ispezionare lo scafo, notarono che le sette lunghezze di catena (ogni lunghezza misura 25 metri, N.d.A.) filate dalla nave per ancorarsi, erano distese ed intatte. L’ancora poggiava sul fondale melmoso di 25 metri, però, le unghia delle marre erano rivolte verso l’alto e tra loro passava un cavo d’acciaio.
Questa circostanza fu la fatale spiegazione del cedimento dell’ancora della nave e del suo rapido avvicinamento alla diga, nel momento di massima forza del mare e del vento.
Le marre si capovolsero nell’impatto con l’insospettata presenza di un cavo d’acciaio e non poterono mordere il fondale, fare presa nel fango e porre quindi resistenza all’effetto di quella libecciata devastante.
Le Responsabilità
La Corte Reale di Giustizia del Tribunale Marittimo di Londra, il 17 Maggio 1972 emise la seguente sentenza:
Il naufragio e la conseguente perdita della London Valour fu causata dall’errata condotta del comandante Cap. Donald Marchbank Muir, 57 anni….
Emerse pure che: “il comandante dimenticò di avvertire i suoi Ufficiali di coperta che, alla Sezione Macchina della nave, (C.Macchinista, Mr. Samuel Harvey Mitchell, N.d.A.) necessitava un congruo preavviso prima di dare la tradizionale “prontezza”, a causa d’ordinari lavori di manutenzione ai motori ausiliari che erano, comunque terminati in mattinata.
I Protagonisti
A seguito di questi fatti furono concesse:
LE MEDAGLIE DI “BENEMERENZA MARINARA”
al cap. Giuliano Telmon (Capitaneria di Porto) : Oro
al cap. Rinaldo Enrico (Vigili del Fuoco) : Oro
al pilota Giovanni Santagata (Corpo Piloti-Porto) : Argento
al pilota Aldo Baffo (Corpo Piloti) : Argento
al pilota Giuseppe Fioretti (Corpo Piloti-Porto) : Bronzo
Conclusione
Nonostante l’eroico comportamento di tutti i soccorritori intervenuti in mare, in terra e in aria, a rischio della propria vita, il bilancio delle vittime fu molto grave e la tragica lezione impartita dall’ammiraglio vento impose nuove regole ai responsabili del porto. Nuove norme di sicurezza furono riscritte e, grazie alla loro puntuale applicazione, molte altre vittime furono in seguito evitate. Ci riferiamo all’incendio ed esplosione della superpetroliera Hakuyoh Maru avvenuta nel porto petroli di Multedo il 12 luglio 1981 e soprattutto all’incendio, esplosione e affondamento di un’altra superpetroliera la Haven al largo di Arenzano avvenuta l’11 aprile 1991.
Ultimo Atto
LA LONDON VALOUR AFFONDO’ DURANTE L’ULTIMO VIAGGIO
Il relitto della London Valour, con le sue sovrastrutture emergenti, rimase per diciotto mesi come simbolo e monito di quanto il dio-mare, al di là d’ogni tecnologia, sia ancora l’invincibile peso massimo, posto al centro di un immenso ring e sempre pronto a decidere il destino di chi non lo tema o non lo rispetti secondo le sue regole.
Appoggiata a pochi metri dal vecchio fanale rosso d’entrata, la ex-nave britannica non impedì la costruzione dell’ultimo pezzo di diga verso levante.
Per la verità, fu lasciato un varco navigabile per il transito delle imbarcazioni minori addette alla risoluzione dei vari problemi creati dal relitto.
La London Valour fu liberata del carico ed in parte fu demolita sul posto. Numerose furono le traversie di quel periodo e non facili le decisioni prese dalle Autorità Marittima e Portuale. Nessun Cantiere di demolizione, infatti, era in grado di ospitare un relitto con un simile pescaggio, né tanto meno era facile trovare un porto che rischiasse la paralisi del traffico a causa del suo affondamento, magari sull’imboccatura…
Dopo qualche mese dal disastro, entrò in scena la ditta olandese Smit Tak International Bergingsbedriff, specialista a livello mondiale in operazioni di Recuperi Navali, che vantava un originale sistema per rendere galleggiante i resti della London Valour, tramite l’immissione di milioni di palline di polistirolo nelle sue capienti stive.
La Smit Tak non riuscì a riportarla interamente a galla, ma le garantì, tuttavia, una discreta galleggiabilità, che avrebbe dovuto assicurare il suo rimorchio in mare aperto e quindi l’affondamento, con l’uso di dinamite, nella zona delle Baleari, ad est di Minorca, su un fondale di circa 3500 metri, denominata “Fossa delle Baleari”.
L’abisso marino, destinato ad accogliere le spoglie della London Valour, era stato accuratamente scelto dalle Autorità competenti, con il preciso intendimento di rendere sicura la navigazione in Mediterraneo, oltre che salvaguardare le attività marinare dei Paesi limitrofi, legate alla pesca, turismo ecc… da possibili problemi d’inquinamento.
Il 12 ottobre del 1971, ai primi chiarori dell’alba, il rimorchiatore oceanico Vortice disincagliò il relitto dalla diga e lo fece con molta accuratezza per non creare superflue lacerazioni sotto lo scafo, quindi lo consegnò ai rimorchiatori d’altomare Torregrande (capo convoglio) e Genua per il traino prestabilito.
Epilogo
Siamo così giunti all’epilogo di questa incredibile tragedia marinara e forse nessuno, meglio di Charly, il Comandante del Torregrande, può accompagnarci in questa specie di rito funebre a conclusione di una storia tristissima che, volenti o nolenti, ci appartiene completamente.
“Nonostante il tempo fosse buono, al momento della partenza da Genova, il bollettino meteo era pressoché indecifrabile, nel senso che lasciava spazio a quella parola “variabilità” che anche i più giovani lupi di mare imparano presto a detestare e a diffidare per la sua incapacità di prendere una posizione chiara e quindi di non prevedere proprio nulla…Ma il problema più serio, fin dall’inizio del viaggio, era del tutto psicologico: era infatti difficile controllare serenamente la navigazione di prora, avendo al traino un relitto che pescava 22 metri, come una superpetroliera dei giorni nostri, e del quale si potevano vedere soltanto le colonne dei bighi, che apparivano tra l’altro bianchi e fatui come fantasmi e, come tali, capaci di sparire in qualsiasi momento.
Torregrande e Genua avevano un tiro complessivo di 4.500 cavalli di razza, che furono subito totalmente sbrigliati, nell’illusione d’uscire al più presto da quell’incubo! Purtroppo la velocità era poco superiore ai tre nodi. Altri 10.000 cavalli di potenza, magra consolazione, non avrebbero aumentato di un decimo l’andatura, a causa dell’inesistente idrodinamicità della sua massa informe e sommersa.
Tra i nostri equipaggi, cui non difettava certo l’esperienza, la parola d’ordine era: “occhi aperti ragazzi”, mentre avevo già preso tutte le misure d’emergenza, tra cui l’aver predisposto un marinaio, di guardia nel locale del verricello automatico (chiamato Troller, N.d.A.), pronto a tagliare il cavo di rimorchio con la fiamma ossidrica, in caso d’affondamento improvviso del relitto.
Dopo il tramonto di quell’insolita giornata di navigazione, il tempo andò peggiorando e nella notte, forti piovaschi impedivano il pieno controllo visivo del rimorchio, che appariva protetto da una barriera bianca di pioggia e schiuma, sulla quale andavano ad infrangersi i potentissimi fasci bianchi di due proiettori da 1000 watt ciascuno.
Lo Stato Maggiore Olandese, che aveva la regia dell’intera l’operazione, era ospite sul Torregrande. Il suo compito era di controllare il buon andamento della navigazione del convoglio sino al punto prestabilito, per poi procurare l’inabissamento del relitto con l’impiego di cariche di dinamite. Ci trovavamo, purtroppo, ad un terzo soltanto del percorso e tutto lasciava pensare ad un suo imminente affondamento. L’esperienza insegna che anche nei momenti difficili ci sia, quasi sempre, un momento di comicità! I nostri ospiti olandesi, celebri per le loro tradizioni marinare, non ressero ai primi colpi di mare e, quasi subito, sparirono sottocoperta, portandosi dietro la puzza sotto il naso e tutti quei strani strumenti, con il quali si erano imbarcati a Genova…Durante la serata cercai di stanarli ripetutamente per renderli edotti della situazione che, a nostro avviso, era ormai irreversibile, a causa del graduale abbassamento del relitto e della velocità quasi del tutto azzerata. Dopo l’ennesimo invito a salire sul Ponte, il nostromo Zeppin, di ritorno dai loro alloggi, mi disse con un tono che non ammetteva indulgenze:
“Se o bon maina o se conosce a-o cattivo tempo… sti chi se treuvan a bordo pe sbaglio; se né battan u belin du periculu, du relittu e de Baleari, pensan sulu a racca cume bestie marotte…! Ma ghe lo ditu in sciu muru au capu: loda o ma e stanni a ca, besugu! Ma chi va imbarcou?
(Trad. Se il buon marinaio si vede nel cattivo tempo…questi qui si trovano a bordo per sbaglio; se ne fregano del pericolo, del relitto e delle Baleari, loro pensano solo a vomitare come animali ammalati! Ma gliel’ho detto a muso duro al capo: loda il mare, ma stattene a casa…Ma chi vi ha imbarcati?
Intorno all’una e trenta di notte, il comandante del Genua G.Negro mi chiamò per radio: “per noi i giochi sono fatti, e di giocare non n’abbiamo più voglia…” gli risposi che anche noi eravamo dello stesso parere e che poteva “staccare” quando voleva, e di continuare a scortarci con il proiettore sino al “finale dell’incompiuta”…
Cercai ancora una volta, invano, d’aver l’O.K. degli olandesi e poi misi in atto, con calma, il piano di recupero dell’attrezzatura di rimorchio per evitare che andasse persa con i resti della London Valour. Verso le 02.30, dopo aver virato a bordo la prima parte del rimorchio (250 metri di cavo d’acciaio), iniziammo a recuperare anche i 220 metri di cavo di nylon collegati al relitto. Eravamo flagellati dall’ennesimo piovasco, ma ci avvicinammo fino a pochi metri da quella visione dantesca…poi, mi portai a poppa estrema e Zeppin mi passò la mannaia di bordo. Mi feci quindi appoggiare il cavo da 90 m/m sul piatto bordo poppiero e diedi un colpo deciso e preciso che ci liberò, brutalmente, da quella funesta angoscia che ci aveva attanagliato per molte ore il cuore e la mente…
Il troncone della ex-nave britannica London Valour colò a picco alle 02.58 del 13 ottobre 1971, sbavando schiuma, eruttando migliaia e migliaia di palline di polistirolo e salutando il mondo con un fragoroso rigurgito”.
Dopo un anno d’inutili studi e progetti andati in fumo, il relitto fu rimorchiato al largo da due rimorchiatori d’altomare al comando dello scrivente.
La London Valour non raggiunse la Fossa delle Baleari, ma affondò per la seconda volta, sotto i colpi di una violenta burrasca a 90 miglia a sud di Genova, su un fondale di 2640 metri, in latitudine 43°02’N e longitudine 08°06’E, ad una quarantina di miglia da Imperia e circa cinquanta ad Ovest di Capo Corso.
Il ruota del timone fu donata all'Ospedale San Martino che aveva assistito i superstiti.
La campana è oggi conservata presso la Chiesa Anglicana di Genova.
La bandiera è stata consegnata alla Capitaneria di Porto.
Fu una tragedia inverosimile, a poche bracciate dalla costa, sotto gli occhi attoniti di una storica città marinara.
Quel giorno qualcuno scrisse:
La London Valour si è inabissata definitivamente, rifiutando ancora una volta di sottomettersi al volere dell’uomo e scegliendosi da sola il fondale che è divenuto la sua tomba, 2640 metri al disotto della superficie di quel mare che così selvaggiamente l’aveva ferita.
Carlo GATTI
Rapallo, 23.05.11
Album fotografico








A rotûa d'i ténpi

L'amico Carlo Pini ci scrive: "Cari amici, ho potuto leggere sul sito, con interesse e partecipazione, l’oramai datato racconto di Carlo Gatti sulla tragedia della London Valour. Esso ha inevitabilmente agitato in me svariati ricordi, strettamente collegati sia al bambino che al marittimo che sono stato: avevo infatti sei anni quando il naufragio è avvenuto e, nonostante il tempo passato, ne ricordo a menadito la vicenda.
Ho dunque coinvolto Enrico Granara, persona interessata alle storie di mare e del mare, valente traduttore di testi d’ogni genere dalle lingue originali al genovese. Qui di seguito ne troverete l’esito, pregevole, reso nei suoni originari della nostra parlata. Esso a mio parere ne restituisce ancora di più la tragicità già così ben illustrata nella originaria stesura del Gatti.
Un caro saluto e vivi complimenti per l’energia con cui animate la Società. Carlo Pini"
A rotûa d'i ténpi Quande l'anticiclún de-e Azzorre u se retîa versu ponente, a s'arve 'na porta a-e brixe fréide d'u mâ atlanticu, ch'a vegne d'ou Nòrde/ponente, insciû bòrdu de l'âta pressiun, e-e arîvan int'u Mediterràniu, sponciæ int'e n'andannia. (vanni a vedde a fréssa néigra int'a carta méteo).
U l'é cuscì ch'u se forma u scistêma d'i vénti de Meistrâ, ch'u l'é típicu de-e nòstre bande. Vénti che soventi se lêvan tûtt'assemme forti int'u Gurfu d'u Lion, ciû forti inscê coste còrse de ponente e che-e van ancun ciû fòrte int'u tortaieu de-e Bocche de Bonifaçiu.
E a-e vòtte pœ accapitâ dôtræ scituasiúin a-a mâpezu, comme quande int'u Gurfu de Zêna a se vegne a creâ 'na "depressiún sótta ventu" dovûa ou fætu ch'a pressiún a redòssu d'u arcu alpìn a chinna tûtt'assemme, ò arîva 'na bassa pressiún insce l'Europa de levante, a quæ, cu-u sò gîu ciclónnicu a zeuga a fâ andâ e brixe da Nòrde/Ponente ancun ciû fòrti.
Int'u nostru emisfèru e depressiúin e gîan int'u sensu oràrriu e donca u fenómenu méteo u l'insa a Sciöcu (SE), u se rinforsa a Lebéccio (SW) e u sfonda a Meistrâ (NW). U méize d'Arvî u l'é soventi int'u mêzu de questu fenòmenu peigûsu, ciammòu da-i mainæ "rotûa d'i ténpi" e inscî bòrdi d'u meu a gente de mâ a issa e antenne quande a vedde u mâ lungu.
De segûu u l'é 'n scìntomu ancestrâle ch'u attrœva inte 'na zöna ch'a no l'é lontann-a, 'n véntu tenpestûzu ch'u avansa drîtu sensa inciànpi e cuu quæ, fîtu, ghe saiâ da fâ i cunti…
U giurnu d'u diâu
U l'é cuscî che se desccèga quellu ch'u l'êa accapitòu l'é quarant’anni, int'u gramm-u 9 d'Arvî 1970, quande a T/n London Valour a s'êa fracasâ insciâ diga d'u pòrtu de Zêna.
Quelli che gh'êan i s'aregordan d'u “giurnu d'u diâu”. Vintiduî cristiæn êan morti sòtta i éuggi de 'na çitæ piggiâ da-u resâtu, abarlýgâ, sensa puéi fâ ninte davànti a-i terribili córpi de mâ issæ da' n véntu che in poche ûe u l'áiva gîòu da Sciöcu a Meistrâ rinforsândose a ogni gælu d'a rêuza d'i vénti.
Inte quelle condiçiuín estrême, che i zeneixi àivan vîstu de ræu, a pocu ò ninte àivan varsciýu i mâi tanti tentatîvi de sarvamentu improvisæ da-i coragiûzi òmmi d'u socórsu.
I Fæti
U 2 d'Arvî 1970 u piroscafu u l'é partîu da Novorossisk in direçiún de Zêna con 23.606 tonnéi de cromu int'e stîe. U 7 d'Arvî u l'êa arîvòu a Zêna e l'áiva caciòu l’àncoa in ràdda, aspetându d’anâ in banchìnn-a pe-e operaçiuín de descàregu.
A-e 12.00 ùe d'u 9 d'Arvî u barometru u l'éa bassu: 748 mm. U véntu u l'êa ancun de Sciöcu. A diga forànea a pàiva sparîa sótta a resàcca e inte quellu momentu u mâ ìnsciu u mostrâva quarcösa d'ezageròu, mâi vîstu prìmma: sensa unde e sensa véntu, u pòrtu e a çitæ pàivan arrestæ sensa proteçiún, cuâ diga colâ da l'ægua.
Segóndu i testimònni de bòrdu, nisciún avîzu de bòrasca u l'êa stætu eméssu via radio, ò drentu u pòrtu da-u Semàforo d'a Lanterna. A-e 13.00 ùe u véntu u l'àiva giòu a lebécciu [SW], aumentandu d’intenscitæ.
Insciû pónte de comandu d'a "London Valour" gh'êa stæta 'na riuniún, ma u cumandànte D. M. Muir u s'êa retiòu int'a sò cabinn-a cuâ moggê, sensa dâ òrdini particulâri.
A-e 13.30 l’ôfisiâle de guardia insciû pónte u l'àiva avizòu u Comandànte e l’ôfisiâle de guardia in màcchina ch'u ténpu u stâva pezoându cu'inna rapiditæ da no credde.
Ma u l'êa stætu u 1° ôfisiâle de cuvèrta, ch'u l'àiva dætu l'Alàrme Generàle, doppu avéi vîstu da-a sò cabìnn-a che a diga a l'êa troppu vixìn.
U Cappu Machinìsta u l'àiva acapîu a scituasiún e u s'êa missu fîtu a preparâ l’aviaméntu d'a turbinna.
Ma pe sfortùnn-a a lestixe pe manovrâ a màcchina a l'êa vegnûa fœaa sôlo pochi menûi doppu u spunciún de-a näe contra a diga.
A-e 13.50 u véntu da Lebécciu u l'êa a forsa 8 e u baròmetru u segnâva u valû ciû bassu d'a giornâ, 742 mm.
Intantu u [fortunâle] da Lebécciu u l'àiva passòu i 100 Km/h issandu unde âte e violente che se abbattéivan contra a diga forànea.
Verso e 14.25, l’àncoa d'u mercantîle ingleize no a mordéiva ciû u fundu [no amorrâva ciû] e a comensâva a-arâ, tantu che appreuvu dôtræ menûi a nâe a scaruciâva pe 1300 metri, da-u sò postu d’ancoàggiu scinn'a scciantâse contra a scuggêa ch'a faxéiva da franze-unde insciâ testâ de levante d'a diga Duca de Gallièra.
Òua a "London Valour" a l'êa in angonía inscî schéuggi de-a diga e se puéivan vedde d'i naufraghi insciâ controplancia. E, a-a mancinn-a, se puéiva vedde a barca d'i piloti ch'a s'êa isâa insciâ cresta de n’unda.
Insciû postu l'êa arîvòu i piloti d'u portu, l’elicotteru d'i pompê, i remorchi, e motovedette d'a Capitaneria, d'i Carabinieri, d'a Finansa e d'i Cantunê.
A-e 14.45 i pompê, cuâ sò valentixe, àivan missu in pê un va e ven, ('na çimma doggia de nylon téiza tra a diga e u pónte de comandu), insciû quæ a scorrîa 'na tàggia cuâ sò çenta a braga p'ou sarvamentu de 'n naufrago pe vòtta.
U scaffu d'u mercantîle u s'êa scciappòu inte duî pessi e a sò ciûzma a s'êa attrœvâ divîsa in due gruppi, tûtti cuu sò giaché de sarvamentu. A Dorothy, a moggê d'u cumandante Edward Muir, a l'êa stæta asbriâ da l'inbragatûa de quella funivìa a-a mâpêzu e a l'êa derruâ tramezzu i schéuggi spassæ da-e unde, sòtta i éuggi d'u màiu e nonostante i tentatîvi de sarvamentu de'n pompê ch'u s'àiva bolòu inutilmente ciû vòtte.
I depöxiti de nafta àivan cedûu e u combustìbile, néigru e dénso comme catràn, s'êa sparzûu in mâ e avilupòu i naufraghi chéiti in ægua. Tra questi, u cumandante d'u mercantîle, ch'àiva refûòu l'agiuttu de'n socoritû, u s'êa deslasòu u giaché e s'êa lasciòu andâ.
“Insciâ scena d'u disastru, u legendâiu elicotteru d'u capitaniu Enrico u xoâva sfidddandu a buriann-a, l'erô d'i pompê che appreuvu u no saiéiva ciû ritornòu da questa sò ûrtima operaçiún de sarvamentu”.

E operaçiúin de sarvamentu
Int'a fase iniçiâle d'a tragedia, 'na parte d'a ciûzma a s'êa concentrâ arrente ou càsau, int'u céntru d'a näe.
Questa a l'êa a zona ciû péigûza perché battûa e scciancâ tra-e unde e a diga.
De tütte e mainæe 'n fùrgau e 'na çimma de colegaméntu êan stæti asbriæ insciâ diga e i pompê arriescîvan a mette sciû u Va e Ven, ch'u l'avéiva posciüu sarvâ tréi mainæ indien.
L’aparâtu u pàiva colaudòu e Cumandante u l'avéiva convintu a moggê a méttise in sàrvu, ma u s'êa incepòu fîtu.
Aa sciâ Muir gh'êa mancòu e fòrse pe rexìste agrapâ aa teleférica e a l'êa derruâ tra i schéuggi davanti a-i éuggi aterî d'a ciûzma e d'u màiu, u quæ, sensa dâ a mente ou peîgu, u gh'avéiva dætu l’ûrtimu salûu cuâ bandêa ingléize (Union Jack, N.d.A.).
Questu u l'êa stætu u momentu ciû drammàticu e pin de comoçiún d'a tragedia ch'avéiva colpîu a näe e u nostru pòrtu.
Aprêuvu, n’unda zagante l'avéiva spasòu via u marconista Mr. Hill e a moggê, sparî insémme e negæ tra mòuxi. U 2° Machinista Mr. Carey u l'êa stætu scciancòu da-a mæxima unda e asbriòu in mâ, ma pe miâcou u l'êa stætu sarvòu d'ou canestrellu cacciòu da l’élicotteru du Cap. Enrico.
Inte quella circostànsa u Cumandante u l'êa stætu vîstu pe l’ûrtima vòtta, u l'êa ferîu de mainæa grave a'na gànba e u l'avéiva vusciûu andâ aprêuvu ou mæximu destìn d'a sò moggê.
A mæxima unda stramesuâ l'avéiva solevòu u 1° ôfisiâle de cuvèrta Mr. Kitchener, 31 anni, de duî ciàn, scinn'a Monkey Island (u ponte d'a “bùscioa normâle”, colocâ sorva u timún, N.d.A.), donde s'attrœvâvan zà u Cadettu Mr. Lewis e dôtræ mainæ indien. Questi ûrtimi, scìben ch'êan stæti incoragiæ da-i sò superiû, s'êan refuæ a fâ u bollu d'a speransa pe finî masacræ tra i schéuggi.
In cangiu, i ôfisiâli ingléixi êan stæti sarvæ da-i Piloti d'u pòrtu e d'â vedetta d'u capitaniu Telmon d'a 'Capitaneria'.
'Na parte d'a ciûzma ch'a s'êa riunîa a poppa a s'êa sarvâ pe dûe raxuin:
a)- u coràggiu e l’iniçiatîva d'u 2° ôfisiâle ingléise, Mr. Donald Allan McIsaac, 25 anni. (U l'êa de guardia insciû ponte de comandu a l'ùa d'u naufragiu, N.d.A.)
b)- Inte l'ùrtu cuâ diga, a poppa d'u vapû a l'êa arestâ libera e spòrzente. Da quella posiçiún ciû esterna, i ciû coragiûzi d'a ciûzma s'êan asbriæ in mâ e tiæ sciû fîtu da-i òmmi d'u socórsu.
Dôtræ câxi de sarvamentu êan stæti puscíbili a mêzu d'u culegamentu näe-diga fætu e manezzòu cuu ciû grande coràggiu da-i pompê e da-i mainæ d'a näe.
Tra i tanti àtti de coràggiu e de grande valû compî da-i zeneixi, duvemmu aregordâ quellu compîu a-e 16.17 quande, insciâ crésta de n’unda zagante, u l'êa arîvòu 'n naufragu, vegnûu tûttu néigru de catran, pasôu a linnia de proteçiún d'u canâ de carma.
Italo Ferraro, 'n zugôu de bàlla-nêuo e sub de quæxi duî metri, u s'êa ballôu cuâ muta e ætte da-u terapìn d'a Fêa e, comme 'n àngiou calòu da-u çê, u l'avéiva aferòu u mainâ, missu in sàrvu e poi u l'êa sparîu.
Inte l'urtu d'a näe contra u mùggiu de schéuggi apogiæ aa diga, u scaffu u l'avéiva subîu d'e spacatûe profónde, da-e quæ u l'êa sciortîu u 'fuel oil' ch'u vegnîva dœviòu pe açénde e câdêe.
U cunbustíbile u s'êa sparzûu in mâ e a sò superficie a s'êa cangiâ inte 'na ciàppa néigra ch'avéiva imbratòu ben ben i naufraghi tantu che no se puéivan ciû cunusce e-i êan vegnûi mâi tantu leppegûsi, cuu gran giamìn d'i òmmi d'u socórsu pe aguantâli.
E víttime Int'u desastru êan morte 22 persónn-e. 38 òmmi d'a ciûzma s'êan sarvæ: i ciû coragiûzi, quelli che s'êan bollæ in mâ e ch'êan stæti sponciæ da-i mòuxi tra-e brasse d'i òmmi d'u socórsu apostæ 'n po’ dapertùttu, inte quell'ægua vorticûza, scciummûza e inmatîa.
Int'i giurni sucesîvi, i giurnâli ingléixi avévan definîu erôica a condûta de-i òmmi zeneixi d'u socórsu ch'êan intervegnûi inte quelle dramàtiche operaçiúin de sarvamentu.
Unn-a de-e Veitæ Quande, doppu u naufragiu, i magrúin in inmersciún avéivan ispeçionòu u scaffu, u l'êa stætu notòu che e sette lunghesse de cadénn-a ('na lunghessa a mezûa 25 metri, N.d.A.) fîæ da-a näe pe ancoäse, l'êan distéize e intatte.
Difæti l’àncoa a pogiâva insciû fúndu leppegûzu de 25 metri, ma e ónge d'e-e mâre l'êan disposte de d'âtu e tra lô ghe passâva 'n câu d’âsâ.
Questa fatalitæ a desscêga che l'áncoa l'avéiva cêduu e che a näe a s'êa acostâ con rapiditæ a-a diga int'u momentu de màscima fòrsa d'u mâ e d'u véntu.
E mâre s'êan inbösæ inte l'urtu cuâ insospetâ prezénsa de'n câu d’âsâ e ascì no-e puvéivan morde u fúndu, fâ da préiza int'a bràtta e fâ rexisténsa a quella lebécciadda devastante.
E responsibilitæ A Córte Reâle de Giustìçia d'u Tribunâle Maríttimo de Londra, u 17 de Mazzu 1972 u l'avéiva eméssu questa sentensa chí:
U naufragiu e a conseguente pèrdia d'a "London Valour" a l'êa stæta occaxunâ da-a condûta in erô d'u cumandànte Cap. Donald Marchbank Muir, 57 anni….
A sentensa a dixéiva ascì che: “ u cumandànte u s'êa ascordòu de avertî i sò Ôfiçiâli de covèrta che, aa Seçiún Màcchina d'u vapû, (C.Machinista, Mr. Samuel Harvey Mitchell, N.d.A.) u l'êa necesâiu 'n bun preavîsu primma de dâ a normâle “lestîxe”, a caxun d'i lòi de manutençiún a-i motôri ousiliâri, i quæ, de tûtte e mainæe êan terminæ int'a mæxima matinâ.
I protagonisti Aprêuvu questi fæti l'ëa stætu concessu e "Medàgge de Benemerensa Mainâ”
- ou cap. Giuliano Telmon ("Capitaneria" d'u Pòrtu) : Öu
- ou cap. Rinaldo Enrico (Pompê) : Öu
- ou pilòttu Giovanni Santagata (Còrpu Piloti-Pòrtu) : Argéntu
- ou pilòttu Aldo Baffo (Còrpu Piloti) : Argéntu
- ou pilòttu Giuseppe Fioretti (Corpo Piloti-Porto) : Brónzu
Epílogu Ascì semmu arîvæ a l'ûrtimu attu de questa tragèdia mainâ da no credde. Nisciún, mêgiu d'u Cumandànte Charly d'a Torregrande u ne pœ accompagnâ inte questu morteiu tûttu particulâ, a concluxún de 'na stôia tristìscima che - ou vuémmu ò no - a ne appartegne arrëu.
“Scìben ch'u ténpu u l'êa bun, int'u momentu d'a partensa da Zêna, u buletìn méteo u se puéiva guæi accapî, saiéiva a dî ch'u lasciâva spaçiu a quella paroll-a “variabilità” che scin i ciû zuèni lôi de mâ imprenden fîtu e mâfiaddi a piggiâ in grinta perché no a sà piggiâ 'na posiçiún ciæa e donca no a pœ prevedde guæi 'n belin …
Ma l'afâre ciû sérriu, scin da l’iniçiu d'u viægiu, u l'êa tûttu psicológicu:
Difæti u l'êa diffiçile controlâ a navegaçiún de prôa, quande ou tràinu gh'êa 'n relittu ch'u pescâva 22 metri, comme 'na superpetrolêa d'ancheu, e d'u quæ se puvéivan vedde sôu e colonne d'i bîghi, che appaîvan gianchi e veui comme fantàximi pronti tùtt'assemme a spaî.
UTorregrande e u Genua avéivan 'n tîu màscimu de 4.500 cavalli de rassa, e questi êan stæti fîtu desligæ, cuâ inluxún de sciortî ou ciû fîtu da quellu seunnu grammu!
Ma pe sfortûnna a lestìxe a l'êa pocu ciû de tréi noddi. Ad avéighene âtri 10.000 de potensa - 'na magra consolaçiún - no se puéiva aumentâ l'andatüa mancu de'n déximu, a caxun d'a mancansa de idrodinamiçitæ d'a sò massa informe e sòtt'ægua.
Tra i nostri òmmi a bòrdu, tùtti cuâ sò esperiénsa, a parolla d’ordine a l'êa: “éuggi ben ben avèrti, figgeu!”, intantu che mi avéiva zà piggiòu tûtte e mezûe d’urgensa, tra e quæ l'avéi missu 'n mainâ de guardia int'u locâle d'u muinélu outomàtticu (u "Troller", N.d.A.), prontu a taggiâ u câvu de remorcu cuâ sciamma ossídrica, int'u câxu d’affondamentu incontrolòu d'u relittu.
Insciû fâ da séia, doppu 'na giurnâ de navegaçiún mâi tantu coiosa, u ténpu u s'êa míssu ou pêzu e int'a neutte 'n ciüvascu fòrte e-e sò rammæ d'ægua no-e lasciâvan u controllu visîvu cunplètu d'u remorcu, ch'u páiva protezûu da 'na miâgia gianca d'ægua e scciumma, insce quæ anâva a infrânzise i fâsci gianchi fòrtiscimi de duì proiettûi da 1000 watt ciaschedún.
U Stætu Maggiôre Olandéize, ch'u l'avéiva in man a regîa intræga de l’operaçiún, u s'êa installòu insciû Torregrande. U sò travaggiu u l'êa de controllâ u bunn-a andeiua d'a navegaçiún scin-ou puntu prestabilîu, pe poi passâ u relittu a piccu metténdughe e càreghe de dinamite.
Pe sfortùnna, éimu sôu ou tersu d'a rótta e tûttu u ne lasciâva pensâ ou sò passâ a piccu fîtu. Ma l’esperiénsa a ne dîxe che tante vòtte, int'i momenti diffiçili, no-u vegne a mancâ 'n momentu tûttu da rîe! A bòrdu, i nostri olandéixi, famûzi pe-e sò tradiçiúin mainæ, no êan arriêscî arrêze a-i primi còrpi de mâ e quæxi fîtu l'êan sparî sottacòverta, portânduse derê u sò presumî e tûtti quelli arneixi ræi, cuî quæ s'êan imbarcæ a Zêna …
Int'a séiann-a mi avéiva de lungu tentòu de destanâli perché i fuîsen informæ de 'na scituaçiún che a niâtri a páiva ormâi irreverscìbile, a caxún d'u fætu ch'u relittu u s'asbasciâva cian cianin e che a lestìxe a s'êa redûta quæxi a zeru.
Dappeu l'ûrtimu invîu a montâ insciû pònte, u nostrommu Zeppin, de riturnu da-e cabinn-e, u m'àveiva dîtu co'inna vôxe ch'a no ammettéiva indulgense:
“Se o bon mainâ o se conosce a-o cattivo tempo… sti chi se treuvan a bordo pe sbagliu; se né battan u belin du periculu, du relittu e de Baleari, pensan sulu a raccâ cumme bestie marotte…! Ma ghe lo ditu in sciu muru au capu: loda o mâ e stanni a ca, besûgu! Ma chi v'a imbarcou?
L'êa quæxi l’ûnna e mêza de neutte e u cumandànte d'u Genua, G.Negro, u m'avéiva ciammòu pe radio: “pe niâtri i zœghi sun fæti, e de zûgâ no gh'avémmu ciû cuæ…” Mi gh'avéiva respostu che niâtri ascì éimu d'u mæximu avvîzu e che lê u puéiva “destaccâ” quande u vuéiva, ma ch'u continuasse a inluminâ [a scena] cu-u proiettû scinn'ou “finâle de l’incompiuta”…
Mi avéiva tentòu ancun 'n'âtra vòtta d’avéi l’OK da-i olandéixi, ma pòi con carma avéiva missu in attu 'n ciàn pe repiggiâme i angæsi de remorcu perché no-i se perdesse cu-i resti d'a "London Valour".
Versu e 02.30, doppu avéi viròu a bòrdu a primma parte d'u remorcu (250 metri de câvu d’âsâ), avéivimu comensòu a repiggiâ ascì i 220 metri de câvu de nylon ligæ ou relittu.
Éimu martirizzæ da'n' neuvu ciüvascu, ma éimu arrentî scinn-a pochi metri da quella visiún dantesca…pòi, mi êa arîvòu a-a fin d'a poppa e u Zeppin u m'avéiva passòu l'ascia de bòrdu.
Donca m'avéiva fætu destende u câvu da 90 m/m insciû ciàn d'u bòrdo d'a poppa e avéiva dætu 'n còrpu decìzu e precìzu ch'u ne avéiva liberòu de mainêa dûa, da quella funesta anscietæ ch'a ne avéiva frustòu u cheu e a mente pe mâi tante ùe …
U scaffu d'a ex-näe britànnica "London Valour" u l'êa passòu a piccu a-e 02.58 d'u 13 ötobre 1971, int'en gràn scciummassu, spûandu miggiea e miggiea de ballette de polistirolo e salûandu u mondu con un rumô da no credde.
Dappeu 'n annu de stûddi e de progetti sensa resultati, u relittu u l'êa stætu remorcòu ou largu da due barcasse da mâ fundu sòtta u mæ comandu.
A "London Valour" no a l'êa arîvâ a-a Fossa d'ê Baleâri, ma a l'ê passâ a piccu pe-a seconda vòtta, sotta i còrpi de 'na boràsca a 90 miglia a sud de Zêna, insce'n fundu de 2640 metri, int'a latitudine 43°02’N e longitudine 08°06’E, a 'na quarantenn-a de miggia da Imperia e quæxi çinquanta a Ponente d'u Câu Còrsu.
A reua d'u timun a l'êa stæta regallâ a l'Ûspiâ San Martin ch'u l'avéiva ascistîu i superstiti. La campann-a a l'é servâ int'a Gêxa Anglicann-a de Zêna. A bandêa a l'êa stæta consegnâ a-a 'Capitaneria' d'u Pòrtu.
A l'êa stæta 'na tragedia da no credde, a poche brasse da-a costa, sotta i éuggi smaxî de 'na çitæ mainâ.
Inte quellu giurnu quarchedun u l'avéiva scrîtu: a "London Valour" a l'é anæta a fundu pe de lungu, e a l'ha turna refuòu de sottométtise a-u vuéi de l’òmmu, çernénduse pe sò cuntu u fundu ch'u ghe faiâ da seportûa, 2640 metri sotta a superfiçie de quellu mâ che mâi tantu sarvægu u l'avéiva feîa.=
Carlo Gatti (tradotto da E. Granara - foto B. Malatesta/immagini della Chiesa Anglicana Holy Ghost di Genova)
GENOVA-LIBECCIO, Vento di Eroi e di Morte...
LONDON VALOUR
GENOVA-LIBECCIO, VENTO DI EROI E DI MORTE ...

Foto n.1 Il traghetto “ Fantastic” in difficoltà sull’imboccatura del porto di Genova
Una mareggiata da libeccio, tra le più violente degli ultimi trenta anni, ha colpito la settimana scorsa le coste tirreniche e nel porto di Genova si è sfiorata la tragedia: un traghetto della “Grandi Navi Veloci” con 439 passeggeri e 75 membri d’equipaggio, ha rischiato di finire sulla diga foranea mentre, investito da raffiche di oltre 60 nodi, stava entrando in porto. Una manovra rocambolesca e fortunosa ha consentito di evitare la catastrofe, tuttavia 37 persone sono rimaste ferite o contuse. L’avventura a lieto fine del traghetto Fantastic, se così si può definire, ci ha riportato indietro con la memoria di quasi quaranta anni.
Era il 9 aprile 1970.
Sul porto di Genova si era abbattuto un fortunale da libeccio che aveva alzato onde eccezionalmente alte e violente. Il mercantile britannico London Valour era ancorato da un paio di giorni a circa 1300 metri a sud della diga foranea Duca di Galliera. Verso le 14.30 cominciò a scarrocciare sottovento verso l’argine portuale, l'ancora non mordeva più il fondale e in pochissimi minuti la poppa della nave si schiantò contro la scogliera frangiflutti a ridosso della diga.

Foto n.2 La London Valour in agonia sugli scogli della diga. La parte poppiera é già affondata.
Sul posto arrivarono i piloti portuali, rimorchiatori e motovedette della Capitaneria, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia, Alle 14.45 i Vigili del Fuoco misero in funzione un va e vieni, vale a dire una doppia cima di nylon tesa tra la diga e il ponte di comando, sulla quale scorreva una carrucola munita di cintura a braga per consentire il salvataggio di un naufrago per volta.
La nave si spaccò in due tronconi e i membri dell'equipaggio si trovarono divisi in due gruppi, tutti muniti di giubbotto salvagente. Dorothy, la moglie del comandante Edward Muir, fu sbalzata dall’imbragatura e precipitò tra gli scogli spazzati dalle onde, sotto gli occhi del marito, nonostante i tentativi di salvataggio di un Vigile del Fuoco che si tuffò invano più volte. I depositi di nafta cedettero e il combustibile, nero e denso come catrame, si sparse in mare e avviluppò i naufraghi caduti in acqua. Tra questi, il comandante del mercantile, che rifiutò l'aiuto di un soccorritore, si slacciò il giubbotto e si lasciò andare.


“Volteggiava sulla scena del disastro, sfidando la bufera, il leggendario elicottero dell'ardimentoso capitano Enrico, eroe dei Vigili del Fuoco, che poco tempo dopo non sarebbe rientrato da un'ennesima operazione di salvataggio”.
Nonostante la mobilitazione dei soccorsi in mare e a terra, le vittime furono venti e la nave andò perduta. Dopo un anno d’inutili studi e progetti andati in fumo, il relitto fu rimorchiato al largo da due rimorchiatori d’altomare al comando dello scrivente.
La London Valour non raggiunse la Fossa delle Baleari, ma affondò per la seconda volta, sotto i colpi di una violenta burrasca a 90 miglia a sud di Genova, su un fondale di 2640 metri.
Il ruota del timone fu donata all'Ospedale San Martino che aveva assistito i superstiti.
La campana è oggi conservata presso la Chiesa Anglicana di Genova.
La bandiera è stata consegnata alla Capitaneria di Porto.
Fu una tragedia inverosimile, a poche bracciate dalla costa, sotto gli occhi attoniti della città impotente.
UN MITO
Il Cap. RINALDO ENRICO


Foto n.3 Il capitano Rinaldo Enrico durante una simpatica cerimonia
7.1.1971 - “Personaggio dell’anno”
L’investitura di “personaggio dell’anno” il capitano Rinaldo Enrico l’ha ricevuta al Grand Hotel Bristol di Rapallo. A festeggiare il coraggioso e popolare Ufficiale elicotterista dei VVFF c’erano le più importanti Autorità della Regione. Il direttore del Secolo XIX, Piero Ottone ha poi spiegato perché i lettori hanno scelto R.Enrico tra tanti uomini noti come “Personaggio dell’Anno”. “Vi sono stati nella storia recente tanti uomini coraggiosi o temerari come Lindberg, Chichester, Hillary, ma a differenza di loro, Enrico opera non per battere primati, ma per salvare vite altrui”. Alla fine ha preso la parola il personaggio premiato: “E’ un’impresa ardua dover rispondere. E’ l’impresa più ardua di tutto per me e per i miei uomini qui presenti. Mi sento commosso, sono frastornato, mi sembra di volare sopra un banco di nubi, come in paradiso”.
8.5.1973
UN’ALTRA INDELEBILE TRAGEDIA
Precipita in mare l’elicottero del magg. Enrico tradito dalla nebbia.

Foto n.4 Questo é l’elicottero che il Maggiore Rinaldo Enrico aveva sognato per i suoi salvataggi e con il quale ha trovato la morte.
Il mare non ha ancora restituito i corpi del maggiore Rinaldo Enrico, del secondo pilota Ugo Vignolo, del motorista Elio Mignanego e del pilota civile Ugo Roda, i quattro occupanti dell’elicottero Agusta Bell (vedi foto) precipitato in mare a circa cinque miglia a sud di Arenzano, nel tardo pomeriggio di domenica mentre tutta la zona era avvolta da una fitta nebbia; un fenomeno che, se non può essere indicato come la causa principale della tragedia, certo n’è stato un componente. Tra le ultime parole trasmesse dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, vi sono infatti le segnalazioni sulla visibilità ridottissima che ostacolavano il rientro dei quattro uomini da un volo d’addestramento compiuto su Albenga. Nelle mani degli uomini, che dalle 19.20 di domenica hanno iniziato una battuta di ricerca senza precedenti, per ora ci sono soltanto vari rottami del velivolo.

Foto n.5 - Questa foto è stata scattata dal Marconista Gino Pernice quando l’autore, al comando del rimorchiatore d’altura “Torregrande”, scortava il peschereccio con i piani di coda recuperati dell’elicottero Agusta Bell del Maggiore Rinaldo Enrico.
Carlo GATTI
13.05.11
LONDON VALOUR - La nave che affondò due volte
“LONDON VALOUR”
LA NAVE CHE AFFONDO’ DUE VOLTE
Prima Parte
Risacca eccezionale, presagio di tempesta!
Nel gergo dei bordi il termine mare lungo fa drizzare le antenne! Si tratta di quel sintomo ancestrale che localizza, in una zona non troppo lontana, un vento tempestoso che avanza inesorabilmente e con il quale, presto, si dovranno fare i conti…

1969 - La T/n Michelangelo in uscita dal porto di Genova scortata dal M/r Torregrande. In primo piano cinque rimorchiatori di guardia sulla caletta dei Piloti.
Era ancora notte fonda quando Charly, arrivando dalla placida Riviera di Levante, percepì, camminando, una strana sensazione d’inquietudine: il Torregrande era attraccato in fondo al molo Ovest del Porto Petroli di Multedo, ma i colpi dei bottazzi contro i parabordi di legno della banchina si sentivano da lontano ed erano secchi, regolari e si sommavano a quelli più tenui degli altri mastini: Messico, Canada, Nuraghe e Casteldoria, che completavano la squadra di guardia quel 9 Aprile 1970. I fanali di via di tutti i rimorchiatori portuali, perfettamente allineati in banchina, erano accesi e i loro alberi disegnavano nervosi balletti aerei. I tozzi scafi, pur essendo legati, spiattellavano e roteavano all’esterno con un lasco uguale all’imbando dei cavi. Quando le cime e gli stroppi di catena venivano in forza, ringhiavano minacciosi in un coro squinternato e lamentoso. Il nostromo Zeppin, si sa, aveva fiuto e già da qualche ora aveva rinforzato gli ormeggi e quando vide Charly affrettarsi in fondo al molo, attese l’attimo giusto e balzò in banchina come un felino, gli si fece incontro mostrando una cima spezzata e disse nel suo strambo dialetto carlofortino: -“Cumandante questa a l’è a segunda…sa continua sta risacca duvemmu scappà cumme levri”- Trad. “Comandante, questa è la seconda cima che si spezza…se continua questa risacca dobbiamo lasciare l’ormeggio come lepri!” Nella notte, La Direzione del Porto Petroli aveva allertato i servizi portuali e le maestranze di guardia, quindi, verso le tre, ordinò ai Comandanti delle petroliere d’interrompere la discarica, di staccare le manichette dai manifolds (mar.attacchi) di bordo e raddoppiare i cavi d’ormeggio. Charly salì sul Ponte di Comando, diede una ditata al barometro e lo mise a confronto con il barografo. Si trattava di un antico rituale imparato nelle traversate invernali del Nord Atlantico, quando la nave si trovava all’interno di una vastissima area ciclonica ed il Comandante cercava d’individuarne il centro per poterlo evitare. La depressione in avvicinamento sul golfo ligure era profonda e, per l’occasione, si faceva annunciare da un mare lungo molto atipico e da una sconcertante lettura barometrica: 749 m/m; valore piuttosto basso e che, fatto ancor più grave, tendeva a diminuire. L’equipaggio si radunò in Stazione Radio, mentre Gino inforcava le cuffie per ricevere i bollettini meteo di Roma radio in grafia, e quello di Grasse radio in fonia. La situazione era preoccupante. Le previsioni annunciavano una forte libecciata sul golfo di Genova. L’alba spazzò il buio con decise folate di tramontana che diedero soltanto una tenue speranza di contrasto a quel mare gonfio che, in modo così ineffabile e silenzioso montava la diga, si riversava sull’aeroporto e rimaneva lì, sospeso come un lenzuolo cupo, pietoso, immobile. La pista, così come la diga, non affioravano più. Tutto rimaneva coperto e poi ricoperto dal rimbalzo del mare che dalle calate del porto ritornava verso il largo. Tutto si svolgeva in assenza di vento, in modo meccanico, silenzioso e pur tuttavia dava un senso di soffocamento, provocato da una forza incontenibile che attanagliava e bloccava qualsiasi movimento teso a liberarsi da quella morsa anomala e spettacolare. Verso le dieci il cielo di ponente era pulito, mentre a levante montavano nuvole strane che, oscurando il sole, proiettavano in mare ampi coni di luce giallastra. Il vento improvvisamente prese forza e definì la sua direzione: veniva da scirocco. “Lo scirocco non ha mai fatto danni qui a Genova. Se rimanesse così… Disse con poca convinzione Bobby, il 1° ufficiale. -“Si, è vero, lo scirocco entra in porto, ma dalla porta di servizio, crea correnti strane, rovina le manovre, ma poi se n’esce dalla finestra senza sfondare”- sostenne Gian, il direttore di macchina. “A volte i bollettini sbagliano tutto. Lo ammetto! ma oggi la depressione è troppo forte e avanza rapidamente” - Ribatté Gino con scarso ottimismo - Zeppin, stranamente silenzioso, se ne stava appoggiato al vetro centrale, teneva le gambe e i gomiti divaricati, in quella tipica postura che i naviganti assumono quando il mare è burrascoso. Zeppin, aveva lo sguardo fisso verso sud, alla ricerca di quel bandolo che gli sfuggiva; intuiva il pericolo, lo inseguiva e forse lo sfidava con il magnetismo dei suoi occhi neri che tante tempeste avevano visto. Poi, un sobbalzo dello scafo lo scrollò da quell’idea fissa, e lo fece venire improvvisamente allo scoperto: “Stu sciocu u nu me incanta pe un bellu belin! U ventu u ghe ripreuva, fascendu u giu du follo, poi u pigia a rincursa, pe vegnine in tu cu… Trad. : “Questo scirocco non m’incanta per niente! Il vento poi ci riprova facendo il giro del Fullo, (noto circuito stradale genovese) poi prende la rincorsa, cioè si rinforza per venirci nel c…” Zeppin, a suo modo, aveva disegnato perfettamente il quadro meteorologico. Verso le 11.00, infatti, il vento girò nuovamente a libeccio, rinforzando d’intensità. Fu a quel punto che dalla prima petroliera in porto giunse la chiamata d’assistenza. Alcuni cavi si erano spezzati, ed urgeva la spinta di un robusto rimorchiatore per tenere affiancata la nave al pontile per ricomporre l’ormeggio. Nel giro di mezz’ora, i cinque rimorchiatori di guardia si posizionarono a spingere le pance semi-scariche di quegli enormi cetacei che pendolavano lungo la banchina, ed erano a stento trattenuti dai doppi springs. (mar. cavi a batticulo) Al Torregrande, che era il più potente rimorchiatore in servizio nel porto di Genova quel giorno, giunse l’ordine di andare a mettere la prua, provvista di un enorme paglietto (parabordo) al centro della Esso Liguria. Si trattava della prima gasiera italiana di grandi dimensioni, che era in allestimento lungo la banchina nord-sud della Fincantieri di Sestri Ponente. La nave era vuota e quindi completamente esposta al vento, non solo, ma la sua larghezza sommata alla lunghezza del Torregrande lasciava a quest’ultimo soltanto un metro di spazio dall’altro molo. Quest’ultimo particolare ebbe la sua importanza ogni qual volta la gasiera, sotto la spinta della risacca, rimbalzava di qualche metro ed il Torregrande, spingendo con i suoi 2500 cavalli, doveva accostare di almeno 20° per non danneggiare la poppa contro la già citata banchina contigua e parallela. E’ inutile dire che questa strana manovra avveniva ad ogni flusso e riflusso del moto ondoso. La situazione peggiorò quando, verso mezzogiorno, il vento aumentò ancora ed un paio di maone, (vecchie imbarcazioni portuali di legno) adibite alla pitturazione esterna delle carene e provviste di alti e luridi ponteggi, ruppero a loro volta gli ormeggi e scarrocciarono addosso al Torregrande che rimase imbottigliato in quel cul de sac fino a tarda sera, quando finalmente si liberò il Nuraghe e venne a sbrogliare quel fatale groviglio di tubi, legni e cavi. Già, forse quell’impensabile ingorgo portuale fu davvero fatale, perché impedì al Torregrande d’intervenire nel salvataggio dei naufraghi della London Valour.
La London Valour in uscita da un porto nordico.
La tragedia della London Valour
Quanto riportato finora è la fedele ricostruzione della grave ed anomala situazione meteorologica, che era già in atto nella nottata di quel fatidico 9 Aprile, a ponente della Lanterna. Come si è visto, in mattinata si verificò un ulteriore peggioramento del tempo e la gente del porto, e non solo quella, come vedremo, ne seguì l’evoluzione con grande trepidazione e partecipazione.
1° Testimonianza
Com’era la situazione a levante della Lanterna? Per rispondere a questa domanda lasciamo la parola ad un testimone d’eccezione: Il signor Pietro Pacino, ex marittimo e funzionario del Registro Navale di Genova, all’epoca del disastro della London Valour fu il primo genovese a rendere testimonianza davanti alla Commissione d’Inchiesta del Tribunale Marittimo di Londra nel 1972. Tra le tante deposizioni rese alle svariate Autorità italiane e straniere, incaricate di svolgere le indagini sull’accaduto, abbiamo scelto quella del signor Pacino perché ci è sembrata, senza il minimo dubbio, la più attendibile poiché precisa, competente e quindi la più aderente alla realtà pur nella sua inevitabile drammaticità. Alle sue tempestive segnalazioni si deve, tra l’altro, la rapida messa in moto del coordinamento dei soccorsi.
Mr. Phillips (Giudice della Commissione, N.d.A): Si ricorda il giorno in cui la London Valour scarrocciò contro la diga? - Pacino: Si. Mi ricordo era il 9 Aprile. - Vide lei stesso l’evento? -Si. Lo vidi io stesso. - Dove si trovava alle 13.00 del 9 aprile - Stavo arrivando a casa. - Vedeva il mare dal suo appartamento? - Si. - Vedeva anche la diga Duca di Galliera? - Si. Sig. Pacino ora leggerò il suo rapporto dall’inizio. “Evento London Valour, 9 Aprile 1970. Ricostruzione dell’osservazione fatta da Piazza Rossetti (Foce), dalle 13.00 alle 15.30. La ricostruzione è il risultato di una consultazione fatta tra tutti i componenti la mia famiglia. Aggiungo che gli orari sono stati scrupolosamente ricostruiti, ma che ovviamente debbono essere considerati approssimati. Alle 13.00 arrivo a casa e noto lo stato del mare. Maltempo da sud e vento forte. Molte navi sono all’ancora, fuori della diga esterna. La prima di queste è una bulk-carrier, (London Valour, N.d.A) molto carica con la prora al vento. Ho la sensazione che sia troppo vicina e che addirittura possa ostacolare l’entrata in porto alle altre navi…………… Alle 13.30 mi accorgo che il tempo tende a peggiorare. Il vento sta aumentando e tende a girare da SSW a SW. Valuto la forza del mare 5/6. La nave precedentemente segnalata sembra aver messo la prora a SW; è in questa posizione che la sua poppa si trova a circa mezzo miglio dal fanale rosso della diga; ha l’ancora di sinistra in mare. Una seconda nave, in rada, ha salpato l’ancora e si allontana.”
Mr. Phillips: Ciò avvenne prima o dopo l’impatto della London Valour sulla diga?
Pacino: Questa nave lasciò l’ancoraggio alle 13.00. Alle 13.45 guardo il barometro: segna 748 mm. E tende a scendere. Devo specificare che il mio barometro non è professionale, ma domestico. Il vento sta ancora aumentando d’intensità, anche il mare è peggiorato; ora il mare lungo e alto arriva sulla spiaggia (ridossata dalla diga, N.d.A.). Stimo che la sua forza sia intorno a 6/7. La nave è sempre ferma nella stessa posizione, ma sembra leggermente più vicina alla costa; sul momento ho l’impressione che abbia allascato un po’ di catena, ma con i binocoli mi rendo conto che a prora non c’è nessuno. Alle 13.55-14.00, mare forza 7, in aumento, con onde alte e bianche che si rompono sulla diga della Foce. Osservo la nave e ne leggo il nome sulla poppa: London Valour, perché la nave ha girato a ponente a causa della forte corrente che in queste circostanze, sotto costa, spinge in quella direzione.
Mr. Phillips: Lei conosce le correnti di quella zona?
Pacino: Si, quando navigavo, con il libeccio forte, mi sono trovato in grande difficoltà nell’imboccare l’entrata del porto. Facevamo sbandate notevoli…….( il libeccio soffia di traverso all’imboccatura, N.d.A.) La sua distanza in diminuzione dalla diga, mi fa pensare che la nave abbia dragato l’ancora e che tuttavia mi sorprende che non sia stata usata anche l’ancora di dritta, che è tuttora al suo posto in cubia. La distanza della nave dalla diga sembra ora essere 300/350 metri. Valuto che questa posizione sia molto pericolosa. Guardo con il binocolo: nessuno è in coperta, né a prora, né sul ponte e neanche a poppa. La nave sembra abbandonata. Il barometro è ancora sceso ulteriormente 745. Il vento è ancora più forte. Alle 14.00/14.10 abbiamo la netta sensazione che a bordo non si stiano rendendo conto del pericolo in cui si trovano. Prendo il telefono e chiamo la Torre dei Rimorchiatori (ubicata al Molo Giano, vicina all’imboccatura, N.d.A.) al numero 282766 ed informo della situazione il capo servizio. Chiamo il 683068, Ponte Parodi (Sede dei Rimorchiatori, N.d.A.) e ripeto la precedente comunicazione di pericolo. Chiamo il 67451 e contatto l’ufficiale di guardia della Capitaneria, sig. Telmon. Chiamo nuovamente il 67451 e chiedo del secondo ufficiale di guardia; purtroppo non ottengo risposta. Allora chiamo il generale Carfì e gli spiego brevemente la situazione, che penso sia molto urgente. Alle 14.10 l’ancora di dritta è sempre in cubia. A bordo non si vede nessuno. La nave si trova a circa 250 metri dalla diga e quasi parallela ad essa. Il vento è molto forte…e ci meravigliamo, con grande ansia, che non mettano in moto la macchina ..! Alle 14.15/14.20 finalmente si vede qualcuno a bordo, sia a poppa che sul ponte di comando. Sembra che siano stati avvertiti da qualcuno dell’imminente pericolo. Alle 1420/14.25 la nave, spinta dal vento, si sta avvicinando ancora di più alla diga. Alle 14.25 udiamo un debole e prolungato fischio accompagnato da alcune nuvolette di vapore. Immagino che la pressione della caldaia non era giunta al punto giusto.” Mr. Phillips: Perché immagina questo? Pacino: Perché il fischio si sarebbe sentito più forte. “Subito dopo, per almeno dieci secondi, vediamo una densa nuvola di fumo nero levarsi dalla ciminiera; poi più nulla. Noi non vediamo più muoversi la nave. Capisco che si tratta di una turbina, e che il motore non sufficientemente riscaldato, non è pronto. Tutto ciò è veramente strano per una nave all’ancora e con quel mare…La nave sembra ora trovarsi a 50 metri dalla diga e sembra scarrocciare verso est, nella nostra direzione. La tragedia appare inevitabile, se non è gia avvenuta! Anzi, alcune particolari rollate ci fanno pensare che la nave sia ormai incagliata. Si vedono ora alcune persone muoversi in diverse parti al centro ed a poppa, ma veramente poche. Il mare, sotto la spinta del vento è aumentato a forza 7/8; la Foce e il piazzale della Fiera sono spazzate dalle onde. Sulla diga cadono onde violentissime. Il barometro sembra fermo su 744 mm. Mare lungo da SW. Alle 14.25/14.30 ….riconosco il rimorchiatore India e mi chiedo come possa affrontare un mare forza 8 con i suoi rotori Voith-Schneiders sotto lo scafo. (Che fuoriescono dall’acqua, N.d.A.) Alle 14.35 l’India ha accostato a sinistra e torna indietro. Poco dopo un rimorchiatore più grande esce dal porto, è il Forte, credo, sembra che ce la faccia e lentamente guadagna posizioni in una lotta coraggiosa contro i marosi. Poco dopo ci prova un altro rimorchiatore l’Iberia, poi ci riprova l’India. Alle 14.40 nel frattempo notiamo una piccola imbarcazione portuale che si è messa a ridosso della diga in corrispondenza della nave. L’imbarcazione riesce a sbarcare numerose persone, che si possono vedere molto bene, sulla diga spazzata dai colpi di mare….Ci chiediamo come questi uomini possano fare qualcosa in quelle condizioni.

9.4.1970, la London Valour flaggellata dai marosi
Alle 14.40/14.45 osserviamo l’arrivo di numerose imbarcazioni che si fermano all’interno della diga; la ben nota imbarcazione dei Piloti, la Teti sta operando in mare aperto, all’altezza della poppa della nave…mentre cinque imbarcazioni hanno lasciato il porto per portare aiuto alla nave. Ma come? Cosa possono fare? Tutte rimangono con la prora al vento ed al mare in un raggio di 200/300 metri. Vediamo chiaramente che esse non possono avvicinarsi e non possono fronteggiare gli elementi a causa della loro scarsa potenza di macchina. Ci appare chiaro che la gente a bordo di queste imbarcazioni stanno facendo il possibile, quanto meno per salvare tutti coloro che si tufferanno in mare.


In queste due immagine non troppo chiare, il leggendario Cap. Rinaldo Enrico volteggia con la sua ciambella sulla London Valour nel tentativo di salvare i superstiti del naufragio.
Alle 14.50 l’elicottero dei pompieri arriva sul posto e rimane in hovering sulla nave. Ma due cose appaiono subito chiare:
(1) che la nave ha troppi ostacoli alti: alberi, colonne, bighi, radar e segnali sugli alberi, ecc.. per permettere all’elicottero di avvicinarsi e prendere gli uomini;
(2) il vento molto forte rende troppo pericolose le manovre di avvicinamento sopra la nave con ciambelle e scale di corda che possono agganciarsi facilmente a qualche struttura della nave.
Nello stesso momento in cui appare l’elicottero, molti altri veicoli di soccorso e ambulanze arrivano rapidamente in Piazzale Kennedy….. Alle 15.00 il tempo è ancora in peggioramento. Il barometro segna 742. Vento fortissimo. Mare forza 8. Onde lunghe arrivano come frustate dal mare aperto. La nave appare ormai ferma, stabile e affondata con la poppa ricoperta dal mare; la prora è ancora visibile, così come parte del cassero e del ponte di comando. Si possono vedere gli uomini dell’equipaggio sparsi qua e là. I soccorritori sulla testata della diga si affannano… Alle 15.00/15.30 assistiamo con grande ansia agli svariati tentativi di raccogliere i naufraghi che hanno avuto il coraggio di gettarsi in mare e ci rendiamo conto di quanto sia estremamente difficile rimanere in mare in quelle condizioni, così come non possiamo che ammirare lo spirito di abnegazione che spinge i soccorritori genovesi che, lottando contro la furia del mare e del vento, rischiano la loro vita per salvare quella di altri marittimi in un momento di supremo bisogno………………”
2° Testimonianza
Relazione del pilota del porto Giovanni Santagata
Verso le 13.35 del 9 Aprile c.a. mi trovavo nella Sala Operativa della Stazione Piloti con il collega Aldo Baffo. Improvvisamente notammo la nave inglese London Valour molto vicina (200-300 metri) alla diga foranea. Percepii la situazione di pericolo con vento e mare in un improvviso crescendo. Chiamai immediatamente l’Ufficio Marittimo del CAP (Consorzio Autonomo del Porto, N.d.A.) comunicando che a mio giudizio la nave in oggetto era in grave difficoltà, che provvedesse per l’allarme e che io sarei uscito immediatamente con la pilotina. Diedi pure l’allarme alla Stazione Rimorchiatori che immediatamente ordinò al Rm. Forte e ad altri di uscire. Alle 13.40 i piloti Giovanni Santagata e Aldo Baffo s’imbarcano sulla pilotina Teti condotta dal timoniere Barone e dal motorista Fanciulli e dirigono all’imboccatura. Alle 13.45 la pilotina esce in mare aperto tentando di mettersi in contatto con la London Valour senza esito. La forza del vento e del mare ha assunto le caratteristiche della tempesta da libeccio. Vediamo la nave ancora ad un centinaio di metri dagli scogli della diga. L’equipaggio ha già indossato le cinture di salvataggio. Vediamo la nave quando impatta la scogliera. Alle 14.00 il comandante Lai, Ufficiale Tecnico della Capitaneria, mi chiede la mia posizione. Mi ordina di passare con il VHF sul canale 16 e di assumere la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso. Mi ordina di tenerlo costantemente informato; cosa che ho fatto per tutto il tempo che sono rimasto a bordo della Teti. Con la pilotina a lento moto, data la violenza del vento e del mare, pendoliamo tra la poppa della London Valour ed il suo ponte di comando, a sud della nave. Vediamo l’equipaggio diviso in due gruppi, uno a poppa ed uno sul cassero centrale che con le mani ci fanno ampi gesti. La minima distanza, cui ci siamo riusciti ad avvicinare, è stata una cinquantina di metri. Sentiamo per VHF quanto si sta facendo a terra per organizzare i soccorsi. Vediamo uscire la C.P.233 (La vedetta della Capitaneria di Porto del Cap. Telmon, N.d.A.)

Foto n.6 Un’altra piccola imbarcazione tenta l’uscita in mare aperto. Si tratta della m/vedetta della Capitaneria al comando del Cap. Telmon.
Dirigo di nuovo in mare aperto. La situazione sulla London Valour sta precipitando. La nave sta affondando flagellata dai colpi di mare, i doppi fondi adibiti alla nafta si sono sfondati. A poppa della nave gettano a mare un battello pneumatico autogonfiante su cui saltano purtroppo soltanto tre naufraghi. Detto canotto munito di tenda fortunosamente si scosta dalla nave e scarroccia verso gli scogli della Fiera del Mare. Con la Teti mi porto sottovento al mezzo che, essendo molto leggero, mi scarroccia addosso facilitandomi l’aggancio. A lento moto per non perderlo, mi porto a ridosso della diga foranea. Prendo a bordo i tre naufraghi, indi ne trasbordo due sulla m/barca del CAP. Uno di loro, un giovane ufficiale ritengo, chiede di restare con noi ad aiutarci. Essendo in ottime condizioni, dico di sì. Alle 16.15 usciamo di nuovo fuori del porto e avvistiamo quasi subito un altro naufrago letteralmente coperto di nafta ed allo stremo delle forze. L’Ufficiale inglese credo riconosca in lui un amico e generosamente si tuffa in suo soccorso. Gettiamo un salvagente a ciambella cui si avvinghiano entrambi. Il recupero in mare aperto risulta impossibile causa i bruschi e violenti movimenti della pilotina. Li rimorchiamo in una zona di relativa calma a ridosso della diga. Tento con il motorista di issarli a bordo, ma essendo completamente ricoperti di nafta ci scivolano via. Mi viene in aiuto il Rm. India al comando del cap. Ragone cui passo la cima, li recuperano e li portano a terra. Alle 16.40 dirigiamo con la Teti di nuovo in mare aperto. Avvistiamo un altro naufrago in buone condizioni di forze. Ci portiamo sopravvento e ci lasciamo scarrocciare a ridosso del molo. Agguanta il salvagente che gli gettiamo e lo rimorchiamo a ridosso del molo. Ci viene in aiuto il Rm. Alghero al comando del cap. Fanciulli che lo recupera e lo porta a terra. Ci avviamo di nuovo fuori, alla ricerca di altri naufraghi. Incontriamo due cadaveri. Uno per volta, con il mezzo marinaio, li rimorchiamo a ridosso del molo. Non so dire da chi sono stati recuperati e avviati a terra. Alle 16.45 la pilotina Preve mi viene incontro ed il com.te Tanlongo mi fa cenno di rientrare a ridosso della diga. Ci affianchiamo ed avviene il cambio dell’equipaggio e del sottoscritto. Imbarcano sulla Teti i piloti Ragazzi e Fioretti, il timoniere Grillo ed il motorista Mortola; si dirigono fuori a continuare le ricerche. Di quanto sopra descritto ho tenuto costantemente informati, tramite VHF, sia il comandante Lai sia il mio capo pilota Giovanni Raimondi. Alle 18.15, incombendo la sera, il sottoscritto pilota Santagata con il pilota Baffo ed il conduttore Fanciulli c’imbarcavamo sulla pilotina Preve e dirigevamo fuori per ulteriori ricerche di naufraghi. Giunti presso il fanale rosso della diga foranea il s.capo Tanlongo, dalla pilotina Teti, mi comunica dell’avvistamento di tre naufraghi lungo la scogliera della Fiera, invitandomi ad andare a vedere. Costeggiando la suddetta scogliera per un centinaio di metri, arriviamo sino alla foce del Bisagno, purtroppo senza risultato. Si dirige per il rientro. Alle 19.30 attracchiamo alla Stazione Piloti.
In fede
Pilota cap. Giovanni Santagata
A seguito di questi avvenimenti furono concesse:
LE MEDAGLIE DI “BENEMERENZA MARINARA”
al cap. Giuliano Telmon (Capitaneria di Porto) : Oro
al cap. Rinaldo Enrico (Vigili del Fuoco) : Oro
al pilota Giovanni Santagata (Corpo Piloti-Porto) : Argento
al pilota Aldo Baffo (Corpo Piloti : Argento
al pilota Giuseppe Fioretti (Corpo Piloti-Porto) : Bronzo
LONDON VALOUR
|
Nave |
Varo |
Ristr. |
Stazza L. |
Lungh. |
Largh. |
Eq. |
|
London Valour
|
1956 Havert U.K. |
1967 La Spezia |
15.875 |
174 mt |
21 mt
|
56 58 * |
* La cifra è riferita al momento del naufragio. Essa comprende la moglie del Comandante e quella del Marconista che erano ospiti a bordo e non facevano parte dell’equipaggio.
Luogo del Naufragio: L’estremità di levante della diga foranea del porto di Genova.
I Fatti: Il 2 Aprile 1970 la nave era partita da Novorossisk diretta a Genova con 23.606 tonnellate di cromo.
Il 7 Aprile la nave giunse a Genova e diede fondo l’ancora in rada, nell’attesa dell’ormeggio. Alle 12.00 del 9 Aprile la pressione barometrica era molto bassa 748 mm. Il mare, in assenza o quasi di vento, era gonfio e montava la diga. Nessun avviso di burrasca, secondo le testimonianze di bordo, era stato emesso via radio o segnalato nell’ambito portuale. Alle 13.00 il vento girò a SW ed andò via via aumentando d’intensità. Ci fu una riunione sul ponte di comando, ma il Comandante D. M. Muir non diede particolari disposizioni e si ritirò in cabina con sua moglie. Alle 13.30 l’ufficiale di guardia sul ponte avvisò il Comandante e l’Ufficiale di guardia in macchina che il tempo era in netto e rapido peggioramento, ma fu il 1° Ufficiale di coperta che, scorgendo dal suo oblò la diga estremamente vicina, diede l’Allarme Generale. Il C. Macchinista recepì l’emergenza e si prodigò per accelerare al massimo l’avviamento della turbina. Purtroppo la prontezza a manovrare la macchina fu data soltanto pochi minuti dopo l’impatto della nave contro la diga. Alle 13.50 il vento da libeccio era forza 8 ed il barometro segnava il valore più basso della giornata 742 mm.
L’Impatto
Alle 14.22 la London Valour, dopo un rapido scarroccio, fu spinta dalle onde contro gli scogli della diga Duca di Galliera.
Le operazioni di Salvataggio
Nella fase iniziale della tragedia, una parte dell’equipaggio si era concentrato presso il cassero centrale della nave. Questa era la zona più pericolosa perché battuta e schiacciata tra le onde e la diga.
Un razzo ed una cima furono comunque sparati sulla diga ed i Vigili del Fuoco riuscirono ad approntare il Va e Vieni, una sorta di sistema funicolare che poté salvare tre marinai indiani. L’apparato sembrava collaudato ed il Comandante convinse la moglie a mettersi in salvo, ma subito dopo s’inceppò.

Foto n.7 – La foto mostra il recupero di alcuni naufraghi ricoperti di nafta
Alla signora Muir mancarono le forze per resistere aggrappata alla teleferica e precipitò tra gli scogli dinanzi agli occhi atterriti dell’equipaggio e del marito che, incurante del pericolo, volle darle l’estremo saluto con la bandiera inglese (Union Jack, N.d.A.).
Poco dopo, un’onda gigantesca spazzò via il marconista Mr. Hill e sua moglie che sparirono insieme ed annegarono tra i flutti. Il 2° Macchinista Mr. Carey fu strappato dalla stessa onda e scaraventato in mare, ma fu miracolosamente salvato dalla ciambella dell’elicottero del Cap. Enrico. In quell’occasione il Comandante fu visto per l’ultima volta, era ferito gravemente ad una gamba.

In questa drammatica istantanea si notano alcuni membri dell’equipaggio assiepati sulla “normale” della nave in cerca di salvezza. L’imbarcazione dei piloti Teti, a sinistra, affronta il mare in posizione quasi verticale sulla cresta dell’onda.
La stessa incredibile onda aveva sollevato il 1° Ufficiale di coperta Mr. Kitchener, 31 anni, di due piani, sino alla Monkey Island (il ponte della “bussola normale”, ubicata sopra la timoneria, N.d.A.), dove già si trovavano il Cadetto Mr. Lewis ed altri marinai indiani. Questi ultimi, sebbene sollecitati dai loro superiori, rifiutarono il tuffo della speranza e perirono massacrati tra gli scogli.
Gli Ufficiali inglesi furono invece salvati dai Piloti del porto e dalla vedetta del capitano Telmon della Capitaneria di porto. Una parte del personale che si era concentrato a poppa si salvò per due fattori principali:
a)- per il coraggio e l’iniziativa dimostrata dal 2° Ufficiale inglese, Mr. Donald Allan McIsaac, 25 anni. (L’ufficiale che era di guardia sul ponte di comando nel momento del naufragio, N.d.A.)
b)- nell’impatto con il terminale della diga, la poppa della nave risultava libera e sporgente. Da quella posizione più esterna, i più coraggiosi tra l’equipaggio si gettarono in mare e subito dopo furono raccolti dai soccorritori.


Altri provvidenziali salvataggi avvennero tramite collegamento nave-diga con il già citato va e vieni, approntato con estremo coraggio dai Vigili del Fuoco e dai marinai della nave.
Tra i tanti atti di coraggio e di grande valore compiuti dai genovesi, desideriamo ricordare quello che si verificò alle 16.17 quando, sulla cresta di un’onda gigantesca, arrivo un naufrago, tutto nero, al di là della barriera di protezione del canale di calma. Italo Ferraro, un pallanuotista-sub di quasi due metri, pioniere della vita subacquea, (quello stesso che visse, proprio sul fondo del canale di calma, per una settimana, in una campana d’aria, N.d.A.), si tuffò con muta e pinne dal terrapieno della Fiera e, come un angelo calato dal cielo, sollevò il marinaio, lo mise in salvo e poi sparì.
Nell’impatto della nave contro gli scogli appoggiati alla diga, lo scafo subì notevoli spaccature, dalle quali straripò il fuel oil, con cui venivano accese le caldaie. Il prodotto combustibile si sparse in mare, la cui superficie divenne una lastra nera che imbrattò completamente i naufraghi tanto da renderli irriconoscibili, estremamente scivolosi e quindi difficilmente catturabili dai soccorritori.
Le vittime: Nel disastro perirono 22 persone. Si salvarono 38 membri dell’equipaggio: i più coraggiosi, coloro che si tuffarono in mare e furono spinti dalle onde tra le braccia dei soccorritori che si erano appostati un po’ ovunque, in quelle acque vorticose, schiumose ed impazzite.
Nei giorni successivi, gli stessi media Inglesi definirono eroico il comportamento dei soccorritori genovesi che intervennero in quelle drammatiche operazioni di salvataggio
Le Responsabilità La Corte Reale di Giustizia del Tribunale Marittimo di Londra, il 17 Maggio 1972 emise la seguente sentenza:
Il naufragio e la conseguente perdita della London Valour fu causata dall’errata condotta del comandante Cap. Donald Marchbank Muir, 57 anni….
Emerse pure che: il comandante dimenticò di avvertire i suoi Ufficiali di coperta che, alla Sezione Macchina della nave, (C.Macchinista, Mr. Samuel Harvey Mitchell, N.d.A.) necessitava un congruo preavviso prima di dare la tradizionale “prontezza”, a causa d’ordinari lavori di manutenzione ai motori ausiliari che erano, comunque terminati in mattinata.
Una delle Verità: Quando, dopo il naufragio, i sommozzatori s’immersero per ispezionare lo scafo, notarono che le sette lunghezze di catena (ogni lunghezza misura 25 metri, N.d.A.) erano distese ed intatte. L’ancora poggiava sul fondale melmoso di 25 metri, però le unghia delle marre erano rivolte verso l’alto e tra loro passava un cavo d’acciaio. Questa circostanza fu la fatale spiegazione del cedimento dell’ancora della nave e del suo rapido avvicinamento alla diga, nel momento di massima forza del mare e del vento. Le marre si capovolsero nell’impatto con l’insospettata presenza di un cavo d’acciaio e non poterono mordere il fondale, fare presa nel fango e porre quindi resistenza all’effetto di quella libecciata devastante.
Conclusione: Nonostante l’eroico comportamento di tutti i soccorritori intervenuti in mare, in terra ed in aria, a rischio della propria vita, il bilancio delle vittime fu grave:
il 9 Aprile 1970
perirono
22 persone
travolte dalle onde e schiacciati contro gli scogli posti a suo tempo a protezione della diga. Il naufragio, vissuto in diretta con la partecipazione di una folla incredibile di genovesi, fu e rimane, a distanza di 35 anni, una pagina di storia sconcertante per l’indifferenza e l’assenteismo dell’equipaggio di fronte ai ripetuti avvertimenti che segnalavano l’avvicinarsi della fortissima libecciata, della quale la nave fu vittima.
Fonte Bibliografica: Report of the: “OFFICIAL INQUIRY”
INTO THE LOSS BY STRANDING OF S.S. LONDON VALOUR
Terza Parte
LA LONDON VALOUR AFFONDA DURANTE L’ULTIMO VIAGGIO
Il relitto della London Valour, con le sue sovrastrutture emergenti, rimase per diciotto mesi come simbolo e monito di quanto il dio-mare, al di là d’ogni tecnologia, sia ancora l’invincibile peso massimo, posto al centro di un immenso ring e sempre pronto a decidere il destino di chi non lo tema a sufficienza o non lo rispetti secondo le sue regole. Appoggiata a pochi metri dal vecchio fanale rosso d’entrata, la ex-nave britannica non impedì la costruzione dell’ultimo pezzo di diga verso levante. Per la verità, fu lasciato un varco navigabile per il transito delle imbarcazioni addette alla risoluzione dei vari problemi creati dal relitto. La London Valour fu liberata del carico ed in parte fu demolita sul posto. Numerose le traversie e non facili furono le decisioni prese dalle Autorità Marittima e Portuale. Nessun Cantiere di demolizione, infatti, era in grado di ospitare un relitto con un simile pescaggio, né tanto meno era facile trovare un porto che rischiasse la paralisi del traffico a causa del suo affondamento, magari sull’imboccatura… Dopo qualche mese dal disastro, entrò in scena la ditta olandese Smit Tak International Bergingsbedriff, specialista a livello mondiale in operazioni di Recuperi Navali, che vantava un originale sistema per rendere galleggiante i resti della London Valour, tramite l’immissione di milioni di palline di polistirolo nelle sue capienti stive.
La Smit Tak non riuscì a riportarla interamente a galla, ma le garantì, tuttavia, una discreta galleggiabilità, che avrebbe dovuto assicurare il suo rimorchio in mare aperto e quindi l’affondamento, con l’uso di dinamite, nella zona delle Baleari, ad est di Minorca, su un fondale di circa 3500 metri, denominata “Fossa delle Baleari”. L’abisso marino, destinato ad accogliere le spoglie della London Valour, era stato accuratamente scelto dalle Autorità competenti, con il preciso intendimento di rendere sicura la navigazione in Mediterraneo, oltre che salvaguardare le attività marinare dei Paesi limitrofi, legate alla pesca, turismo ecc… da possibili problemi d’inquinamento.

Foto n.11 - Il 12 ottobre del 1971, ai primi chiarori dell’alba, il rimorchiatore oceanico Vortice disincagliò il relitto dalla diga e lo fece con molta accuratezza per non creare superflue lacerazioni sotto lo scafo, quindi lo consegnò ai rimorchiatori d’altomare Torregrande, capo convoglio, (in primo piano) e Genua (secondo piano) per il traino prestabilito.
Epilogo: Siamo così giunti all’epilogo di questa incredibile tragedia marinara e forse nessuno, meglio di Charly, il Comandante del Torregrande, può accompagnarci in questa specie di rito funebre a conclusione di una storia tristissima che, volenti o nolenti, ci appartiene completamente.
“Nonostante il tempo fosse buono, al momento della partenza da Genova, il bollettino meteo era pressoché indecifrabile, nel senso che lasciava spazio a quella parola “variabilità” che anche i più giovani lupi di mare imparano presto a detestare e a diffidare per la sua incapacità di prendere una posizione chiara e quindi di non prevedere proprio nulla…Ma il problema più serio, fin dall’inizio del viaggio, era del tutto psicologico: era infatti difficile controllare serenamente la navigazione di prora, avendo al traino un relitto che pescava 22 metri, come una superpetroliera dei giorni nostri, e del quale si potevano vedere soltanto le colonne dei bighi, che apparivano tra l’altro bianchi e fatui come fantasmi e, come tali, capaci di sparire in qualsiasi momento.
Torregrande e Genua avevano un tiro complessivo di 4.500 cavalli di razza, che furono subito totalmente sbrigliati, nell’illusione d’uscire al più presto da quell’incubo! Purtroppo la velocità era poco superiore ai tre nodi. Altri 10.000 cavalli di potenza, magra consolazione, non avrebbero aumentato di un decimo l’andatura, a causa dell’inesistente idrodinamicità della sua massa informe e sommersa. Tra i nostri equipaggi, cui non difettava certo l’esperienza, la parola d’ordine era: “occhi aperti ragazzi”, mentre avevo già preso tutte le misure d’emergenza, tra cui l’aver predisposto un marinaio, di guardia nel locale del verricello automatico (chiamato Troller, N.d.A.), pronto a tagliare il cavo di rimorchio con la fiamma ossidrica, in caso d’affondamento improvviso del relitto. Dopo il tramonto di quell’insolita giornata di navigazione, il tempo andò via via peggiorando e nella notte, forti piovaschi impedivano il pieno controllo visivo del rimorchio, che appariva protetto da una barriera bianca di pioggia e schiuma, sulla quale andavano ad infrangersi i potentissimi fasci bianchi di due proiettori da 1000 watt ciascuno. Lo Stato Maggiore Olandese, che aveva la regia dell’intera l’operazione, era ospite sul Torregrande. Il suo compito era di controllare il buon andamento della navigazione del convoglio sino al punto prestabilito, per poi procurare l’inabissamento del relitto con l’impiego di cariche di dinamite. Ci trovavamo, purtroppo, ad un terzo soltanto del percorso e tutto lasciava pensare ad un suo imminente affondamento. L’esperienza insegna che anche nei momenti difficili ci sia, quasi sempre, un momento di comicità! I nostri ospiti olandesi, celebri per le loro tradizioni marinare, non ressero ai primi colpi di mare e, quasi subito, sparirono sottocoperta, portandosi dietro la puzza sotto il naso e tutti quei strani strumenti, con il quali si erano imbarcati a Genova… Durante la serata cercai di stanarli ripetutamente per renderli edotti della situazione che, a nostro avviso, era ormai irreversibile, a causa del graduale abbassamento del relitto e della velocità quasi del tutto azzerata. Dopo l’ennesimo invito a salire sul Ponte, il nostromo Zeppin, di ritorno dai loro alloggi, mi disse con un tono che non ammetteva indulgenze: “Se o bon maina o se conosce a-o cattivo tempo… sti chi se treuvan a bordo pe sbaglio; se né battan u belin du periculu, du relittu e de Baleari, pensan sulu a racca cume bestie marotte…! Ma ghe lo ditu in sciu muru au capu: loda o ma e stanni a ca, besugu! Ma chi va imbarcou Zagallo? (Trad. Se il buon marinaio si vede nel cattivo tempo…questi qui si trovano a bordo per sbaglio; se ne fregano del pericolo, del relitto e delle Baleari, loro pensano solo a vomitare come animali ammalati! Ma gliel’ho detto a muso duro al capo: loda il mare, ma stattene a casa…Ma chi vi ha imbarcati, Zagallo? Zagallo; ne abbiamo già parlato altrove. Ricordate il comico folletto-clandestino imbarcato sui rimorchiatori d’altura? Il troll che naviga, parla, mangia, dorme, prende tutti per il sedere… perché lui è sempre lì, tutti lo intravedono , ma nessuno riesce mai ad agguantarlo…Zagallo non è a ruolo, quindi è senza paga. Gli Armatori sopportano la sua presenza a bordo perché porta fortuna…ed alleggerisce la tensione. Intorno all’una e trenta di notte, Giovanni Negro, il comandante del Genua, mi chiamò per radio e disse: “per noi i giochi sono fatti, e di giocare non n’abbiamo più voglia…” gli risposi che anche noi eravamo dello stesso parere e che poteva “staccare” quando voleva, e di continuare a scortarci con il proiettore sino al “finale dell’incompiuta”… Cercai ancora una volta, invano, d’aver l’O.K. degli olandesi e poi misi in atto, con calma, il piano di recupero dell’attrezzatura di rimorchio per evitare che andasse persa con i resti della London Valour. Verso le 02.30, dopo aver virato a bordo la prima parte del rimorchio (250 metri di cavo d’acciaio), iniziammo a recuperare anche i 220 metri di cavo di nylon collegati al relitto. Eravamo flagellati dall’ennesimo piovasco, ma ci avvicinammo fino a pochi metri da quella visione dantesca…poi, mi portai a poppa estrema e Zeppin mi passò la mannaia di bordo, che era stata affilata dal boia-motorista Spalla. Mi feci quindi appoggiare il cavo da 90 m/m sul piatto bordo poppiero e diedi un colpo deciso e preciso che ci liberò, brutalmente, da quella funesta angoscia che ci aveva attanagliato per molte ore il cuore e la mente… Il troncone della ex-nave britannica London Valour colò a picco alle 02.58 del 13 ottobre 1971, sbavando schiuma, eruttando migliaia e migliaia di palline di polistirolo e salutando il mondo con un fragoroso rigurgito. La sfortunata nave giace ora ad una profondità di 2640 metri, in latitudine 43°02’N e longitudine 08°06’E, ad una quarantina di miglia da Imperia e circa cinquanta ad Ovest di Capo Corso. Quel giorno qualcuno scrisse:
"La London Valour si è inabissata definitivamente, rifiutando ancora una volta di sottomettersi al volere dell’uomo e scegliendosi da sola il fondale che è divenuto la sua tomba, 2640 metri al disotto della superficie di quel mare che così selvaggiamente l’aveva ferita".
Carlo GATTI
Rapallo, 12.05.11
Il Romanzo della LONGITUDINE
IL ROMANZO DELLA LONGITUDINE
UNA SOLUZIONE ATTESA MILLENNI
Il buon Dio e la natura hanno dato, fin dagli albori, la possibilità al navigante di stabilire la latitudine misurando la latitudine misurando di notte l’altezza della stella Polare, oppure misurando di giorno l’altezza massima che il sole raggiunge sopralasuatesta.
Quando i Velieri si arenavano sugli scogli perché non conoscevano la Longitudine.

Per la soluzione della longitudine c’è stato invece il buio totale fino alla metà del 1700.
E’ impossibile sapere quante navi sono naufragate nei millenni per l’errata valutazione della longitudine.
Questo fantastico capitolo della storia della navigazione ha inizio, pensate, con la soluzione trovata da un orologiaio, l’inglese John Harrison che affermò:
“E’ sufficiente che ogni nave sia equipaggiata con un cronometro in grado di misurare l’ora esatta, quella di Londra per esempio, ed un semplice confronto con l’ora locale del punto dove si trova la nave, fornirebbe istantaneamente il “FUSO ORARIO”, cioè quanti gradi e primi, e dunque la longitudine della nave e quindi anche la sua distanza dal meridiano 0° convenzionale-politico di riferimento”. Ma ci mise tutta una vita per fare accettarequesto semplice concetto ai grandi astronomi del 1700".

Il Comandante Ernani Andreatta mostra il cronometro navale della “Texaco Arizona” varata nel 1949 presso il celebre Cantiere Navale Bethlehem Steel Corporation di Quincy, Massachusetts (USA)
Ci troviamo in compagnia del Comandante Ernani Andreatta, fondatore e conservatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari.
Comandante, nel 1999 siamo stati entrambi folgorati dal piccolo libro “Longitudine” di Dava Sobel, non tanto per l’aspetto scientifico che avevamo già analizzato al Nautico, ma per la storia “sofferta” di Harrison che ignoravamo totalmente.
E’ vero! Del piccolo libro di Dava Sobel, “Longitudine”, mi affascinò soprattutto l’argomento trattato che mi stimolò per avviare ulteriori ricerche sull’argomento che culminarono con una conferenza, della quale fui relatore nello stesso anno alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari.
Sicuramente abbiamo in comune un ricordo: il primo ordine che veniva impartito all’Allievo ufficiale di coperta del dopoguerra, fino all’avvento del GPS, era quello di dare la carica, ogni mattina, al cronometro di bordo.
Questo fa parte della nostra storia di naviganti. Per anni abbiamo navigato usando il sestante per trovare la posizione della nave, misurando cioè l’altezza degli astri e soprattutto usando quel famoso cronometro, da lei accennato, a cui occorreva dar la carica tutte le
mattine. Lo ritenevo un normale strumento che, come la bussola, faceva parte della strumentazione di bordo. A quel tempo non sapevo che il cronometro di bordo era stato, dopo infiniti anni di naufragi e disastri, la soluzione ai fondamentali problemi del calcolo della posizione della nave.
A pensare che Harrison era nato falegname…
John Harrison, nato falegname e non orologiaio, ebbe ragione addirittura su certi Astronomi Reali che non credevano anzi, guardavano con sospetto alla sua “piccola scatola magica”. Quel piccolo oggetto meccanico rappresentava la scoperta scientifica più importante della storia marittima e mai più avrei immaginato che dietro a quel cronometro che maneggiavo quasi con fastidio, si era consumata una durissima vicenda esistenziale per un uomo straordinario e testardo come il nostro eroe.
Spieghiamo ai nostri lettori la principale necessità di dover calcolare la longitudine.
Agli inizi del 1700, il problema di tutte le navi era il calcolo della longitudine, in pratica la distanza lungo un parallelo, da un meridiano di riferimento, e di conseguenza la posizione esatta della nave Questo era il vero problema che assillava tutti i naviganti. Agli occhi degli uomini del settecento, il mondo aveva un aspetto molto lontano da quello chegli atlanti, i mappamondi e le fotografie scattate dai satelliti ci hanno reso familiare. Non si contavano i capitani ed i loro equipaggi che avevano perso la vita schiantandosi sugli scogli avevano perso la vita perché le loro navi si erano schiantandosi sugli scogli di una costa che secondo i calcoli sbagliati dei loro piloti non doveva essere lì.
Per fortuna dei marinai, all’orizzonte apparve John Harrison il quale fornì la soluzione e la sostenne fin da subito: ogni nave fosse equipaggiata con un cronometro in grado di segnare sempre l’ora “esatta” di Londra ed un semplice confronto con l’ora locale-solare, avrebbe istantaneamente fornito il “Fuso Orario” e dunque la Longitudine della nave.
Purtroppo, trovata la soluzione teorica, si presentava un altro problema di ordine pratico: un cronometro così preciso non esisteva nemmeno sulla terraferma.
Quanto tempo impieghò J. Harrison a vincere la sua personale scommessa?
E’ la storia avvincente di quarant'anni di sforzi che furono necessari a John Harrison non solo per costruire e perfezionare quel cronometro, ma soprattutto per persuadere la comunità scientifica dell’efficacia del suo metodo, semplice e definitivo.
I grandi astronomi dell’antichità insegnarono a calcolare la latitudine, ma poi indirizzarono le loro ricerche nei meandri dell’universo. Forse la longitudine non era così importante nei limiti geografici della navigazione costiera conosciuta prima delle grandi scoperte geografiche.
Già nel 150 D.C. il cartografo e astronomo Tolomeo aveva tracciato le latitudini e le longitudini nelle ventisette carte geografiche che rappresentano una pietra miliare e un punto di riferimento importantissimo.
Per far capire meglio ai nostri lettori, ci può definire la differenza cruciale tra la Latitudine, misurata a partire dall’equatore, verso nord e verso sud e la Longitudine, misurata invece da un meridiano 0° convenzionale?
Il parallelo di Latitudine di grado ZERO vale a dire l’equatore è fissato da leggi della natura; infatti, osservando i moti apparenti dei corpi celesti, il sole, la luna e i pianeti passano quasi esattamente sopra l’equatore. L’identificazione del meridiano fondamentale Zero, invece, è una decisione squisitamente politica. Nel tempo, da Tolomeo in avanti si stabilirono come meridiano Zero, di volta in volta: le Canarie, l’arcipelago di Madera, Le Azzorre, Le Isole di Capo Verde, Roma, Copenaghen, Gerusalemme, San Pietroburgo, Pisa, Parigi, Filadelfia, prima di fissarlo, in modo universale, a Londra e precisamente a Greenwich.
L’esempio più eclatante d’errore di Longitudine ce lo diede C. Colombo che Salpò il Parallelo e credette di essere arrivato a Cipango. Ci può chiarire il rapporto tra tempo orario, longitudine e distanza geografica?
Cristoforo Colombo nel 1492 “Salpò il Parallelo” ed è fuor di dubbio che, sulla sua rotta, se non ci si fosse messa di mezzo l’America, avrebbe sicuramente trovato le Indie. Pertanto, la misura della longitudine è fortemente influenzata dall’ora e per calcolare la longitudine in alto mare bisogna sapere non soltanto che ora è a bordo della nave in un dato momento, ma anche che ora è, in quello stesso istante, nel porto di partenza o in un altro luogo di cui si conosca la longitudine. Le ore segnate dai due orologi rendono possibile al navigante la trasformazione di differenza oraria in distanza geografica. Poiché la terra impiega 24 ore per completare un’intera rotazione di 360 gradi, un’ora equivale a un 24esimo di giro, ovvero a 15° (gradi). Quindi, la differenza di un’ora tra la posizione della nave e il punto di partenza indica un avanzamento di quindici gradi di longitudine verso oriente o verso occidente. Quando in mare, il navigante, regola l’orologio della sua nave sul mezzogiorno - il momento in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, cioè lo Zenit - e quindi consulta l’orologio del punto di partenza, sa che la discrepanza di un’ora si traduce in 15 gradi di longitudine. Quegli stessi 15° (gradi) corrispondono anche ad una certa distanza percorsa. All’equatore, dove la circonferenza della terra è massima, equivalgono a mille miglia nautiche. A nord e a sud di tale linea, il valore di ciascun grado misurato in miglia diminuisce. Un grado di longitudine equivale a quattro minuti in tutto il mondo, ma in termini di distanza si contrae dalle 68 miglia all’equatore ad uno zero virtuale ai poli.
Un orologio preciso e trasportabile è stato quindi il “segreto” che ha rappresentato la vera svolta nella sicurezza della navigazione?
La conoscenza simultanea dell’ora esatta di due luoghi diversi – un pre-requisito del calcolo della longitudine - che oggi, riusciamo ad ottenere con economici orologi da polso, era una meta irraggiungibile sino a che non furono inventati gli orologi a pendolo. Ma sul ponte di una nave, che stava rollando, tali orologi diventavano pressoché inservibili perché acceleravano o rallentavano enormemente e non parliamo poi dell’influenza della temperatura tra le zone fredde e i tropici.
Possiamo affermare che la sola conoscenza della latitudine non solo fu un grande limite per i grandi navigatori, ma possiamo aggiungere che essi arrivarono dove arrivarono per “benevolenza della fortuna”?
Quasi tutti i grandi navigatori, da Vasco de Gama a Vasco Munez de Balboa, da Ferdinando Magellano a Sir Francis Drake, arrivarono dove arrivarono, volenti o nolenti, per grazia di Dio e benevolenza della fortuna. Anche il Re Giorgio III d’Inghilterra e lo stesso Luigi XIV cercarono di risolvere questo problema ed il grande James Cook fu uno dei primi esploratori a dar fiducia a Harrison con ben tre lunghi viaggi sperimentali, prima d’incontrare una morte violenta alla Hawai.
Che parte ebbero nella vicenda Longitudine i famosi astronomi dell’epoca?
Astronomi famosissimi s'ingegnarono in ogni modo e maniera per risolvere il problema del calcolo della longitudine. Ne cito alcuni come G. Galilei, Jan Dominique Cassini, Cristian Huygens, Sir Isaac Newton, Edmond Halley (lo scopritore della cometa…) ma tutti sbagliarono, perchè rivolsero i loro studi alla luna e alle stelle, forse travisati dal calcolo squisitamente astronomico della latitudine. In realtà, Galileo studiò un metodo per calcolare la longitudine, ma era complicatissimo e del tutto inapplicabile a bordo alle navi.
Non c’è dubbio che questa ricerca portò anche ad altre straordinarie scoperte come il peso della terra, la distanza delle stelle e la velocità della luce.
Comandante, ci racconti alcune tragedie marinare che furono causate dalla pessima conoscenza della longitudine.
Il problema era sempre lo stesso! Soltanto attraverso il calcolo della longitudine si sarebbe arrivati alla conoscenza della “vera” posizione della nave. Nel 1707, l’ammiraglio di Sua Maestà Sir Clowdisley perse quattro navi (su cinque), e oltre duemila uomini d’equipaggio in prossimità delle Isole Shilly a sud dell’Inghilterra (Lands End). Quando l’Alto Ufficiale scoprì con sgomento d’aver calcolato male la longitudine, era già tragedia… E pensare che un membro dell’equipaggio li aveva insistentemente avvertiti che stavano sbagliando e fu impiccato per insubordinazione.
C’è da notare che la non conoscenza della longitudine allungava i viaggi a dismisura, dipanandosi in mille episodi orripilanti di uomini uccisi dallo scorbuto e dalla sete, di spettri fra il sartiame, di approdi di navi ridotte a relitti con le chiglie frantumate sulle rocce e cumuli di cadaveri di annegati a imputridire sulle spiagge. In moltissimi casi l’ignoranza della longitudine portava un vascello ad una rapida fine. Infine possiamo aggiungere che l’incapacità di calcolare la longitudine influiva negativamente sull’economia: le navi erano costrette a seguire solo determinate rotte conosciute e così, sulle stesse rotte, si affollavano baleniere, mercantili, navi da guerra e corsari naturalmente, cadendo preda uno dell’altro.
Personalmente fui colpito dalla tragedia del Madre de Deus. Ci può raccontare brevemente quel tragico episodio?
Nel 1592, il gigantesco galeone portoghese Madre de Deus, armato con ben 32 moderni cannoni di ottone, mentre si trovava al largo delle Azzorre, di ritorno dall’India, s’imbattè al largo delle Azzorre nella flotta inglese che lo colò rapidamente a picco. Da notare che la flotta Inglese stava aspettando quella spagnola e non il Madre de Deus.
Il galeone trasportava sotto coperta ogni ben di Dio: oro, argento, perle, brillanti, ambra, arazzi, ebano, tela di cotone stampata e le preziose spezie, quantificate in quattrocento tonnellate di pepe, quarantatrè di chiodi di garofano, trentacinque di cannella e tre di noce moscata e macis. Il carico del Madre de Deus valeva circa mezzo milione di sterline che era la metà del gettito fiscale di tutta l’Inghilterra a quell’epoca.
Nel 1641 il Commodoro Anson, al comando del Centurion, perdette ben tre navi delle cinque che erano al suo comando, oltre agli equipaggi di circa 600 uomini. La sua disavventura nel passare dall’Atlantico al Pacifico, attraverso Capo Horn, fu causata dal non conoscere la longitudine quindi la posizione della sua nave, ma fu anche straordinariamente aggravata da 58 giorni di terribili burrasche.
Gli uomini migliori, insomma, perdevano l’orientamento una volta che la terra non era più visibile ed il mare non offriva nessun indizio utile a calcolare la Longitudine. A causa dei numerosi naufragi e delle perdite di uomini e navi si diffuse persino il timore, o la superstizione che alla soluzione di quel problema si opponesse qualche divieto divino.
Il Parlamento Inglese, con il celebre “Longitude Act” del 1714, stanziò l’astronomica somma di 20.000 sterline, circa 20 miliardi di vecchie lire, a chi avrebbe inventato un sistema pratico e utile per il calcolo della longitudine. Qui cominciò l’avventura di J. Harrison?
L’orologiaio inglese John Harrison, un genio della meccanica, fu il pioniere della scienza della misurazione del tempo, mediante strumenti precisi e portatili. Il tecnico dedicò la sua vita a questa ricerca realizzando ciò che Newton riteneva impossibile: inventò un orologio che, come una fiamma eterna, avrebbe trasportato l’ora esatta dal porto di partenza ad ogni remoto angolo della terra. Senza preparazione teorica né apprendistato pratico presso un orologiaio, Harrison costruì una serie di orologi quasi del tutto privi di attrito, che non abbisognavano di lubrificazione o pulizia, fatti di materiali inattaccabili dalla ruggine, in grado di mantenere le parti mobili in perfetto equilibrio reciproco, a prescindere da come, intorno a loro il mondo si impennava o rollava. Abolì naturalmente il pendolo e accostò differenti metalli all’interno del suo congegno in modo che quando un componente dell’orologio si espandeva o contraeva per variazioni di temperatura, l’altro componente ne neutralizzava gli effetti mantenendo costante il ritmo dell’orologio.
Harrison ebbe molti nemici che fecero carte false contro di lui a tutti i livelli!
Infatti, i risultati conseguiti dal nostro eroe furono vanificati dai membri della comunità scientifica, che diffidavano della “scatola magica” di Harrison. I commissari, incaricati di assegnare il premio stanziato, Nevil Maskelyne tra loro, cambiavano le regole della gara tutte le volte che lo ritenevano opportuno, così da favorire sempre gli astronomi rispetto a Harrison e ad altri meccanici. Alla fine, la precisione e l’efficienza dei cronometri di Harrison trionfarono. I suoi seguaci migliorarono la splendida e complessa invenzione con qualche modifica che consentì in seguito di produrla in serie e di diffonderne l’uso.
Il Re d’Inghilterra, un monarca illuminato, intervenne in soccorso di Harrison!
E’ vero! Nel 1773 un Harrison vecchio e sfinito reclamò, al riparo dell’ala protettiva di Re Giorgio III, il premio che gli spettava di diritto. Erano trascorsi quarant’anni tumultuosi, segnati da intrighi politici, guerre internazionali, ripicche accademiche, rivoluzioni scientifiche e crisi economiche.
La vita di Harrison fu costellata di delusioni e colpi bassi di ogni specie. Gli ammiragli e gli astronomi della Commissione per la Longitudine appoggiarono sempre apertamente il metodo delle distanze lunari di Maskelyne perché lo vedevano come lo sviluppo logico delle esperienze in mare e negli osservatori. Dopo il 1750, grazie agli sforzi congiunti dei molti che contribuirono a questa grande impresa internazionale, sembrava finalmente che il sistema fosse applicabile a bordo.
Ci parli ora della produzione dei cinque prototipi di Harrison.
Harrison costruì cinque prototipi di orologi che identificò con lae sigle H-1, H-2, H-3, H-4 e negli ultimi anni della sua vita l’H-5. Per l’H-3 soltanto impiegò ben 19 anni. Ne uscì una macchina perfetta che sgarrava di appena un secondo, dopo numerosi giorni. Durante tutti questi anni di durissimo lavoro non accettò mai altre commissioni più redditizie, ma costruì soltanto qualche “volgare” orologio per sbarcare il lunario. Soltanto il 30 novembre del 1749, Harrison lasciò il suo banco da lavoro per ricevere un’alta onorificenza che era la Copley Gold Medal, una medaglia d’oro che fu in seguito assegnata a personaggi come Benjamin Franklin, James Cook e Albert Eistein, tanto per citarne alcuni. Il penultimo di una stirpe di questi gioielli in ottone, l’H-4 ha un diametro di soli dodici centimetri e pesa soltanto un chilo e trecento grammi; sembra più un grosso orologio da taschino che non un cronometro di bordo. All’interno delle sue due custodie d’argento finemente decorate c’è la meraviglia delle sue minuscole parti con rotelle dentate che girano sorrette da rubini e diamanti per evitare l’attrito. Come Harrison sia riuscito ad inserire i gioielli nell’Orologio, rimane a tutt’oggi un mistero del quale non fornisce spiegazioni della tecnica usata, per dare alle gemme la loro caratteristica e cruciale configurazione.
L’H-4 è tuttora esposto al National Maritime Museum di Londra e attira ogni anno, assieme all’H-1- 2 e 3 circa otto milioni di visitatori.

I Cronometri di Harrison
Eccoci arrivati al primo esperimento del cronometro di Harrison. John delegò il figlio William?
Finalmente, nel 1762 ci fu la prova del nove per l’H-4. Fu imbarcato sulla nave di sua Maestà il Deptford. Sulla nave s’imbarcò il figlio minore di Harrison, William. La traversata Atlantica durò quasi tre mesi, il 19 Gennaio del 1762 il Deptford arrivò a Port Royal in Jamaica. Salì a bordo il rappresentante della commissione che doveva giudicare l’orologio di Harrison. Robinson e William Harrison confrontarono i due orologi per stabilire la Longitudine. Dopo 81 giorni di mare, l’H-4 aveva perduto soltanto 4 secondi! Ma Nevil Maskeline, l’alto prelato amico degli astronomi e nemico dichiarato del “nostro” orologiaio, per ironia della sorte, era lì ad aspettare il cronometro per giudicarne l’efficienza nel calcolo della longitudine! Le discussioni con William furono interminabili. Pensate! Il calcolo della longitudine si era ridotto ad una discussione tra un astronomo e un orologiaio su una desolata spiaggia delle Barbados.
Come si concluse il viaggio?
L’orologio ritornò a Londra, sempre ben custodito da William Harrison sul Merlin. Il viaggio di ritorno fu altrettanto disastroso per il mare in burrasca e spesso William, che soffriva il mare, doveva avvolgere l’orologio in un plaid e tenerlo al caldo col proprio corpo. Il 26 Marzo, giorno dell’arrivo a Londra l’H-4 ticchettava ancora.
Che fine fece il tanto agognato Premio?
Invece delle 20.000 sterline Harrison ne ricevette soltanto 1.500 con la scusa che, disse la commissione, “gli esperimenti finora condotti sull’Orologio non erano stati sufficienti per determinare la Longitudine”. Avrebbe ricevuto altre 1000 sterline quando l’H-4 fosse tornato dalla sua seconda missione in mare. Un certo Bliss, astronomo, che faceva parte della commissione giudicante, affermò che la cosiddetta precisione dell’orologio, era stata una “fortunata coincidenza”. Cosi, l’orologio di Harrison dovette subire ancora numerose prove e controprove sotto la diffidenza dei grandi astronomi del tempo. Poi Harrison, finalmente, sempre per intercessione di re Giorgio III riuscì ad ottenere tutto il premio messo in palio dal Longitude Act.
Ha inizio una nuova era. L’Inghilterra diventa la “Signora dei Mari”, grazie all’orologio di Harrison.
Quando John Harrison, il 24 Marzo del 1776 morì, esattamente a 83 anni dopo la sua nascita avvenuta nel 1693, egli assurse allo stato di “martire degli orologiai”. Per interi decenni era rimasto in disparte, praticamente solo, come l’unica persona al mondo seriamente impegnata a risolvere il problema della Longitudine facendo ricorso alla misurazione del tempo. Poi all’improvviso, sulla scia del successo dell’H-4, legioni di orologiai cominciarono a dedicarsi alla costruzione di orologi marini. Dopo tre secoli di “sicura navigazione” per i sette mari, la totalità degli studiosi sostiene che Harrison ha favorito la conquista dei mari da parte dell’Inghilterra, e quindi contribuito alla creazione dell’impero britannico, perché fu grazie al cronometro che le navi inglesi divennero le signore degli oceani.
Si sciolse la commissione per la Longitudine. Il cronometro, nonostante l’antipatia degli astronomi, venne assegnato a tutte le navi e, nel giro di pochi decenni, entrò negli inventari di bordo e vi rimase fino ai giorni nostri. Comandante ci avviamo alla conclusione di questo revival storico, ma prima di ringraziarla, lasciamo ancora a lei la parola per trarre alcune conclusioni.
Nel 1828 la Commissione per la Longitudine si sciolse e l’assegnazione dei cronometri a bordo passò all’Istituto Idrografico della Marina, vale a dire ai cartografi. Era un compito non da poco, dato che oltre all’assegnazione, l’Istituto era anche incaricato di ritirare e riparare i vecchi cronometri. Spesso a bordo alle navi idrografiche incaricate dei rilievi se ne potevano imbarcare anche una quarantina in modo da avere dei calcoli di longitudine più precisi. Evidentemente l’idea del cronometro aveva finito per fare breccia. L’estrema praticità dell’approccio del nostro John Harrison era stata dimostrata in modo tanto esauriente che tutta la concorrenza di astronomi e scienziati era svanita come per incanto. Una volta installatosi stabilmente a bordo, il cronometro finì ben presto nell’inventario, come ogni altra cosa essenziale compresa la bussola. La sua storia controversa insieme con il nome del suo inventore venne molto presto dimenticata dagli uomini di mare, che ne facevano uso ogni giorno.
Oggi, il calcolo della Longitudine è finalmente venuto agli onori della storia e reso finalmente giustizia a quel fuoriclasse che fu John Harrison!

Dal Corriere Mercantile del 21 Maggio 2011 apprendiamo che al Comandante Ernani Andreatta é stato assegnato il Premio Nazionale "Nonno dell'Anno". Il famosissimo riconoscimento arriva dall'Associazione "O Leudo" di Sestri Levante e la motivazione sulla targa "Un salvataggio per i posteri" si riferisce alla grande opera di salvataggio, restauro e catalogazione di migliaia di reperti marinari del Tigullio che ora sono conservati nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che ha trovato finalmente ospitalità e grandi spazi presso la Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate, Caserma Leone di Chiavari.
Carlo Gatti
Rapallo - 23.05.11
Dalle Isole LOFOTEN arrivò lo stoccafisso
Dalle isole LOFOTEN
arrivò uno dei piatti preferiti dai genovesi….
Quel naufragio alle Lofoten che ci ha regalato lo stoccafisso (Tørrfisk)
Da millenni, immensi banchi di merluzzi provenienti dalle gelide acque della zona popolata più a nord della terra, si dirigono verso mari più temperati per deporre le uova. Una parte di essi, seguendo la Corrente del Golfo, termina il viaggio di nozze nell'ambiente più adatto a riprodursi, lungo le coste del Vestfjord della Norvegia, in particolare nelle acque che circondano le isole Lofoten.
Foto n.1 Carta Lofoten
Possiamo considerare un miracolo della natura il fatto che il merluzzo lasci il suo habitat naturale e si rechi alle isole Lofoten per deporre le uova esattamente nel periodo climatico ideale per l'essiccazione, quando il gelo si ritira lasciando il posto al vento, alla pioggia ed al sole che hanno il compito di trasformarlo in ottimo stoccafisso. In questa zona, la pesca ha luogo da gennaio fino alla fine d’aprile, al termine di questo periodo, ossia in primavera, i pescatori si spostano verso il nord, sulla costa del Finnmark dove continuano a pescare il merluzzo.

Foto.2 Merluzzo in pescheria
Alle Lofoten c’è il miglior stoccafisso del mondo perché solo qui, sospinta dalla calda Gulf Stream, arriva lo “Skrei”, il merluzzo originario del Mare di Barents. Più in generale, questa tipica ricchezza dei mari nordici, per fortuna dell’umanità, è diffusa su tutta l’estensione della platea continentale dell’oceano Atlantico settentrionale, sia su quella europea raggiungendo come massime punte meridionali il golfo di Biscaglia e la Nuova Scozia, sia sul lato americano fino alle coste del Labrador e di Terranova (Canada).
Røst, l’isola dei merluzzi, dove circola un po’ di sangue italiano.
Nel lontano 1432, sulla scia delle scoperte geografiche, una Cocca (700 tonnellate) della Serenissima, comandata dal capitano veneziano Pietro Querini, solcando i freddi e tempestosi mari del nord, naufragò a Røst (oggi ha 700 abitanti), un’isoletta delle Lofoten (Norvegia), che amò definire in modo alquanto pittoresco: “culo mundi”. Mai un naufragio fu tanto prodigo di novità… e nacque col tempo un fiorente commercio e l'inizio di una nuova cucina. Nei suoi otto mesi di sosta forzata oltre il Circolo Polare Artico, Querini ebbe modo di “esplorare” un mondo ricco di contrasti: fiabesco e nello stesso tempo difficile da penetrare, dalla natura affascinante, ma dura da domare; le donne erano bionde e bellissime, più forti che furbe, erano libere e battagliere nell’attesa dei loro uomini che per mesi pescavano in mari lontani. Poi vide qualcosa di curioso, che descrisse nel suo rapporto per l'ammiragliato della Repubblica di Venezia: …I socfisi seccano al vento e al sole e perché sono di poca humidità grassa, diventano duri come legno. Quando li vogliono mangiare, li battono col roverso della mannara che li fa diventare sfilati come nervi, poi compongono butirro e spetie per dargli sapore, et è grande et inestimabile mercanzia per quel mare di Alemagna……Ma il passo delicatissimo che giustificherebbe la presenza di molte chiome brune sull’isola è il seguente: Uomini purissimi che non curano di chiudere alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medesime dove dormivano mariti e mogli e le loro figliole alloggiavamo ancora noi, e nel cospetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedì, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d’un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi a noi.
L’essicazione del merluzzo.
Se si pensa che fin dai primordi, uno dei principali problemi dell'uomo di terra e di mare fu quello di conservare il cibo che faticosamente era riuscito a procurarsi, per il comandante veneziano dovette essere una scoperta sensazionale imparare da quella piccolissima comunità il più naturale sistema di conservazione: l'essiccamento al sole e al vento.
Nulla è cambiato dall’epoca in cui approdò la cocca veneziana nelle isole Lofoten e, ancor oggi, l'esposizione del merluzzo all’aria aperta mantiene tutte le sue caratteristiche originali: dura circa tre mesi, variando con le condizioni atmosferiche del vento e delle dimensioni del merluzzo.

Foto n.3 Filari di merluzzo al vento
L'essicamento all'aria del merluzzo artico fu concepita per la necessità che i Vichinghi avevano di trasportare sulle loro veloci imbarcazioni (drakkar), alimenti molto leggeri che potessero fornire il massimo delle energie per sfamare le ciurme addette ai remi. (100 grammi di merluzzo fresco forniscono 68 calorie, mentre lo stesso peso essiccato ne fornisce 322).
Leggerezza, facilità di trasporto e consumo senza la necessità di essere cucinato, contribuirono in maniera decisiva al successo dello stoccafisso nei secoli. Nel Medioevo, il commercio del merluzzo ebbe una così grande importanza che il Re di Norvegia per poterlo controllare completamente proibì alle navi della Lega Anseatica di salire a nord del parallelo di Tromsø. Dopo l’anno mille lo sviluppo dei trasporti delle merci via mare, fu enormemente favorito dalla possibilità di usare in cambusa lo stoccafisso che ben sostituiva la carne salata in barili, facilmente deteriorabile. All’epoca del rinascimento lo stoccafisso in Italia cominciava ad essere abbastanza conosciuto, se non diffuso, mentre il baccalà era ancora una rarità.
Si ricorda che durante il Concilio di Trento (1545-1563), tra i piatti poveri consumati dai numerosi prelati, c'era quello di stoccafisso. Oltre ai principi etici e religiosi di carattere generale, il nuovo corso stabiliva, infatti, che in materia di feste e banchetti, il mangiar di magro fosse esteso in molte altre ricorrenze, oltre il venerdì.
L’obbligo di questa osservanza significò, nel mondo cattolico, soprattutto una cucina a base di pesce. Iniziò così nel nostro Paese una progressiva importazione di pesce nordico: aringhe (affumicate), stoccafisso (merluzzo essiccato), baccalà (merluzzo sotto sale) e salmone (affumicato). Il merluzzo, come la storia insegna, fu il più richiesto dagli italiani negli ultimi cinque secoli.
La storia ci tramanda, inoltre, che anche il baccalà fu un piatto apprezzato da molti personaggi illustri e in occasioni memorabili. Si racconta che Carlo V (1530), mentre era in viaggio verso Bologna per essere incoronato Imperatore da Papa Clemente VII, si era trovato a sostare a Sandrigo (nella splendida Villa Sesso Schiavo), quando venne a sapere che i condannati a morte chiedevano, come ultimo desiderio, una porzione di polenta e baccalà; per la gran curiosità, il futuro Imperatore volle assaggiare questo piatto e rimase talmente soddisfatto da quel piatto di cucina locale da nominare “cavaliere” tutti i presenti al banchetto.

Foto n.4 Merluzzo norvegese fuori misura….
Da questo connubio, nacquero nel nostro Paese numerosi piatti di straordinaria saporosità e invitante golosità. Liguria e Veneto se ne contendono il primato, seguite dalla Sicilia, Campania e Calabria. Ancora oggi, passando nei carroggi di Genova, si può sentirne l'intenso e maschio profumo che esce prepotente, da affollate trattorie e ristoranti.
Sia il costo contenuto del prodotto che la sua facilità di conservazione, hanno contribuito, nel passato, al notevole consumo di stoccafisso e baccalà nelle classi meno abbienti.
Non a caso nei versi dell'antica poesia genovese "Pescio conca", si legge: “O loasso di povei e di mainae”, vale a dire - riferito a stoccafisso e baccalà - "Il branzino dei poveri e dei marinai". Il termine pesce conca deriva dall'uso di farlo ammollare nell'acqua. Da quelle necessità e osservanze religiose, che proibivano la carne in certi periodi dell'anno, nacquero succulenti piatti come lo “stoccafisso al verde”, “all'agliata”, lesso con le patate o con le fave “stocche e bacilli” (piatto di reminescenze Romane), "accomodato" (d'origine araba), in “buridda”, alla “badalucchese”, fritto e in frittelle, alla marinara e, non ultimo, il brandacujun, conosciuto anche in Provenza.
L'Italia acquista oggi più dei 2/3 della produzione dello stoccafisso norvegese. Il mercato italiano si divide per motivi culturali e storici, in cinque principali regioni: Veneto, Liguria, Campania, Calabria e Sicilia. Nelle altre regioni italiane lo stoccafisso è meno conosciuto. Esiste tuttavia un'antica tradizione di consumo nella zona di Livorno e di Ancona.
DALLE ANTICHE TRADIZIONI ….. In ogni paesino delle Lofoten, accanto alle case, c’è il magazzino della lavorazione del pesce dove i marinai scaricano i merluzzi e dopo la selezione delle varie specie, prende il via la lavorazione. Non ci crederete, ma la prima fase della lavorazione passa, quando è possibile, attraverso le piccole e abili mani dei bambini, che recuperano lingue e guance, vere prelibatezze (fritte in pastella) della cucina locale. I ragazzini fanno a gara per lavorare un paio d’ore il giorno dopo la scuola, così da guadagnare 30-40 euro. Durante il weekend, nelle piazze dei paesi, può capitare di assistere a vere e proprie competizioni tra agguerriti marmocchi che armati d’affilati coltelli sezionano grossi merluzzi. Si prosegue poi con il taglio delle teste e delle interiora destinate ai più poveri mercati africani, con le stesse tecniche dei Vichinghi che usavano il merluzzo come moneta di scambio. I pesci, lavati e asciugati, sono legati a coppie per la coda e messi ad essiccare per circa tre mesi su stenditoi di betulla che occupano tutto il paese. Il periodo d’esposizione del merluzzo si chiude da mille anni con il Solstizio d’estate, e il 24 giugno, il giorno di S. Giovanni, i pescatori delle isole Lofoten accendono grandi fuochi e la tradizione vuole che si cominci a togliere dai tralicci a piramide i merluzzi ormai secchi. A questo punto sono stivati in costruzioni di legno che ricordano l’epopea dei vichinghi. Qui lo stoccafisso è suddiviso in 20 diverse classi di qualità e Ë pressato in balle da 25, 45 o 50 Kg secondo i mercati di destinazione, con i nomi suggestivi di Westre, Ragno, Olandese, Bremese, Lub. Le spedizioni iniziano in luglio. In Italia arriva il migliore (3,5 mila tonnellate) insieme al baccalà (7 mila tonnellate importate nel 2005).
IL Baccalà - Un’altra storia. Le popolazioni basche del Golfo di Biscaglia (Guascogna) erano cacciatori di balene ed inseguendole verso il nord-Atlantico fino ai Grand Banks, si trovarono intrappolati tra immense colonie di merluzzi, che per catturarli bastava affondarci le mani dentro. Da quel giorno, i Baschi organizzarono campagne stagionali di pesca, ma per conservarlo, lo mettevano sotto sale come facevano con le balene, invece di esporlo all’aria che in Spagna è meno fredda che in Norvegia.

Foto n.5 Baccalà essicato
Così i Vichinghi persero il monopolio della pesca del merluzzo. Così nacque il Baccalà. Così i Vichinghi impararono dai Baschi questo nuovo sistema di conservazione del merluzzo e lo fecero anche conoscere in molte parti del mondo, ma furono poi gli americani a creare un vero e proprio business commerciale a livello planetario. Nel 1620 i Pilgrims Fathers, protestanti in fuga dall’Inghilterra, sbarcarono con la Mayflower su un promontorio del “Nuovo Mondo” che aveva un nome profetico: Cap Cod (Capo Merluzzo), che ci fa capire di quale pesce fossero pieni quei mari e furono proprio loro ad organizzare le prime spedizioni di baccalà americano verso l’Europa. Col tempo, il baccalà era scambiato con prodotti coloniali (zucchero, melassa, spezie, ecc..) e anche con gli schiavi, che erano trasportati in America per lavorare nelle piantagioni. Presto anche gli Inglesi s’inserirono in questo lucroso commercio e ci fu persino una specie di guerra del baccalà fra le navi di Sua Maestà Britannica e i veloci schooner americani che nel frattempo si erano dotati di cannoni. Ancora nell’ottocento, la classe operaia inglese sopravviveva nutrendosi di fish and chips, (merluzzo e patate). Il mercato inglese assorbe ancora oggi 170.000 tonnellate di baccalà l’anno ed è al primo posto nel mondo. Ancora di recente, nel 1973 gli Inglesi presero a cannonate gli Islandesi e nel 1994 gli Spagnoli per il controllo nelle varie zone di pascolo dei merluzzi. Identikit: gadus morhua, della famiglia dei Madidi, ordine dei Teleostei, volgarmente merluzzo, è verdastro, con delle macchiette gialle sul dorso e una linea laterale bianca lungo tutto il corpo. Il ventre è bruno. Lunghezza fino al metro e mezzo. Peso, fino a 50 kg. Perde il suo nome per com’è trattato. Se il pesce è subito pulito, messo in un barile e coperto di sale, è chiamato Baccalà, dalla parola fiamminga Kabeljaw. Questo nome è rimasto pressoché invariato in tutte le lingue Scandinave. Come abbiamo già visto, il Grand Bank, la piattaforma continentale di 3,500 kmq, rappresenta l’habitat più ricco di merluzzi al mondo e c’è un motivo: in quelle acque poco profonde, la tiepida Corrente de Golfo incontra la corrente fredda del Labrador, dando vita ad una splendida piscina particolarmente gradita ad alcune specie di pesci di cui i merluzzi sono particolarmente ghiotti. Fu il grande navigatore Sebastiano Caboto a finirci dentro e a darne notizia nel 1497, mentre cercava una rotta più a nord di quella seguita da Colombo. Un’utile precisazione: Nel Mediterraneo si pesca invece il nasello, che è una varietà di merluzzo meno pregiata e che non ha mai l’onore di diventare baccalà e neppure stoccafisso. Si mangia fresco oppure congelato. Il baccalà è un po' meno presente nella cucina genovese e ligure, sebbene siano sempre diffusi i frisceu (frittelle), all'agliata, fritto, al latte, lesso con o senza patate, con i cavoli, al verde, in zimino, in agrodolce, al forno, ripieno (anche in versione coda di baccalà ripiena). Nei secoli scorsi, il baccalà in frittelle, costituiva il mangiare veloce, ma nutriente degli scaricatori di porto. A proporli erano i frisciolae, fumose e chiassose friggitorie di Sottoripa, situate di fronte al porto antico. L'Italia e la Norvegia condividono una lunghissima storia di commercio iniziata proprio con l'esportazione del merluzzo in Italia, nelle due versioni fin qui descritte.
Carlo GATTI
Rapallo, 07.05.11
Porto di TRAIANO-Echi di MANOVRE di Roma Antica
IL PORTO DI TRAIANO

ROMA
Echi di manovre dal porto di Roma antica...
Testimonianze del servizio di pilotaggio si trovano in documenti del IV millennio avanti Cristo.
Nell'antica Ur, in Caldea, una delle più importanti città-stato della civiltà Sumerica, ai tempi d’Abramo, esistevano i piloti. Ur con i suoi moli e banchine, fu il grande scalo marittimo di quello Stato.
Nella più antica raccolta di leggi marittime, il Codice di Hammurabi, re di Babilonia (2285 a.C.), è stabilito sia il compenso per le prestazioni del pilota: due sicli, sia le sanzioni cui i piloti medesimi andavano soggetti in caso di naufragio o danni colposi. Il testo legislativo è giunto fino a noi inciso in caratteri cuneiformi su una stele scoperta a Susa (Persia) nel 1901 e conservata al Museo del Louvre a Parigi.
Coinvolti dal fascino del mondo antico, ci portiamo ora nel centro del mare nostrum per scoprire qualcosa di più concreto e ci caliamo in un sito archeologico del Lazio per una breve, ma “curiosa” escursione attraverso l’antica marineria di Roma.
Milioni di turisti hanno visitato le imponenti rovine del Porto fluviale di Ostia Antica. Al contrario, molto meno frequentata risulta essere quella zona archeologica attigua a Fiumicino che è visibile alcuni istanti prima d’atterrare all’aeroporto, quando l’occhio è catturato da un lago esagonale, non lontano dal mare.
La vasta area che fu dei Torlonia, appartiene da qualche decennio al Comune di Roma ed è visitabile: si tratta del Porto di Claudio (ancora parzialmente interrato) e del lago artificiale, chiamato Porto di Traiano che fu per cinque secoli l’approdo di favore della capitale dell’Impero.
Ciò che s'identifica oggi del complesso portuale, è soltanto il perimetro formato dalle sue linee banchinate, che tuttavia, è sufficiente a regalarci qualche emozione quando proviamo ad immaginare ciò che poteva essere sia il funzionamento degli impianti che l’organizzazione del lavoro.
Il prezioso monumento di “archeologia commerciale” ante litteram rappresenta, almeno per noi marittimi, il primo esempio di “portualità integrata” della storia.
La sua nascita ebbe luogo per superare il declino dello scalo di Ostia.
Lo straordinario progetto fu concepito e realizzato dall’ingegneria romana (tra cui il celebre architetto Vitruvio) per risolvere un duplice problema: gli approvvigionamenti della sempre più popolosa metropoli e i danni provocati dagli straripamenti del Tevere, dalle sue inevitabili deviazioni e insabbiamenti cagionati ai bacini portuali della regione.
Nel periodo di massimo splendore, Roma doveva sfamare un milione d’abitanti e le navi dell’epoca, provenienti dalle province Imperiali, convergevano verso il modesto ed insicuro porto fluviale di Ostia. Fu l’imperatore Claudio che in seguito ad un’ennesima carestia di grano diede inizio verso il 42 d.C. a quello che sarebbe stato il più grande porto dell’Impero: il Porto di Claudio che in seguito si allargherà nella splendida opera che prenderà il nome di Porto di Traiano.

F.1 - Cartina con la posizione del porto di Claudio e di quello di Traiano rispetto alla città di Ostia, alla Foce del Tevere e all’Isola Sacra.
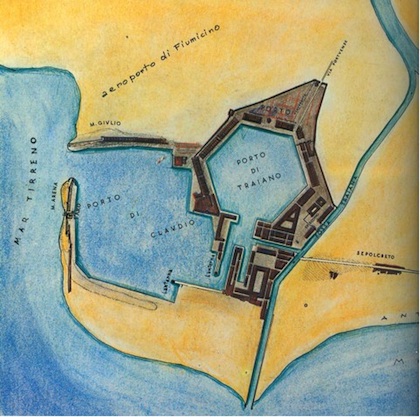
F.2 - Porto di Roma - Ricostruzione planimetrica (arch. I. Gismondi)
L’opera di Claudio consisteva in un bacino ricavato per la maggior parte su terraferma con grandi scavi e prolungato sul mare con la costruzione di lunghi moli. Il bacino aveva un fondale sabbioso variante tra i 4 o 5 metri, che permetteva l’ancoraggio e l’ormeggio delle grandi navi da carico.
Completava l’opera portuale una grande “fossa”, il braccio destro del Tevere, più tardi chiamata anche Fossa Traiana.
L’apertura dei canali di collegamento col Tevere fu provvidenziale non soltanto per il trasporto fluviale a Roma delle merci, con l’alleggerimento del traffico lungo la Via Portuense, ma anche perché favorì il deflusso del fiume, liberando Roma dal pericolo di periodiche inondazioni, come dice un’iscrizione in onore di Claudio trovata in situ.
Lo spazio d’acqua racchiuso nella grandiosa opera di Claudio, aveva una superficie di circa 900.000 mq. - un’ampiezza di circa 1100 m. - le banchine dovevano sviluppare nel loro assieme 2500 m. - permettendo l’ormeggio di oltre 300 navi.
Per dare un’idea della vastità dell’area riportiamo, per un rapido confronto, l’Area totale del porto di Voltri (Genova) = 1.050.000 metri quadrati.
I moli a tenaglia che chiudevano l’ampio bacino erano costituiti da enormi blocchi di travertino, uniti tra loro da robuste grappe di ferro e da perni. Ciascun blocco aveva un peso medio di 6 o 7 tonnellate. L’imboccatura aveva un’apertura di 200 metri.
I lavori per il porto di Claudio durarono quasi 12 anni.
Plinio il Vecchio racconta che il Faro del porto di Claudio aveva una struttura a tre o più ripiani, poggiava su una specie d’isola artificiale realizzata con l’affondamento della nave di Caligola che era servita per il trasporto dell’obelisco vaticano dall’Egitto.
I rilievi eseguiti dopo il ritrovamento del sito hanno contribuito al riconoscimento della nave e delle sue caratteristiche, coincidenti peraltro con l’antica documentazione storica. La nave aveva una lunghezza di 110 metri, una larghezza di 20,30 e sei ponti. Il suo dislocamento era di 7.400 ed aveva un equipaggio di 700-800 uomini.
Le misure di questa nave, in verità molto speciale per l’epoca, ci richiamano alla mente i celebri “Liberty” che, partendo da quell’incerto dopoguerra, scalarono il nostro porto ancora per due decenni e siamo in tanti a ricordare che quei “brutti anatroccoli” di Roosevelt prendevano il Pilota, due rimorchiatori e due squadre di ormeggiatori, sia all’arrivo che alla partenza.
Chapeau! Ai nostri avi romani per la loro organizzazione portuale, l’abilità nautica e per l’invenzione di quelle tecniche operative che gli permisero di compiere le stesse manovre che noi oggi ripetiamo con tanta sufficienza….!
Entro pochi decenni, purtroppo, le strutture del porto di Claudio non furono più adeguate a sostenere la violenza del mare; il bacino non offriva sufficiente protezione alle navi ed era continuamente soggetto ad insabbiamento per i sedimenti che si accumulavano nella foce del Tevere. Tutto ciò mise in crisi il suo funzionamento, e già nel 62 d.C. Tacito ricordò che “duecento navi andarono distrutte nel porto per una violenta tempesta”.
Tutto ciò non deve meravigliarci più di tanto: anche noi genovesi, esposti al libeccio, siamo stati testimoni di quanto successe nel 1955, allorché una tempesta da SW distrusse 400 metri di diga dello scalo genovese e causò l’affondamento di due navi, l’esplosione di una terza, oltre agli innumerevoli danni alle strutture portuali.
Il porto di Traiano, completamente artificiale, fu realizzato circa cinquant'anni dopo il porto di Claudio, in un primo tempo per completarlo e poi per sostituirlo definitivamente; esso fu il risultato di grandi scavi realizzati nell’entroterra allo scopo di assicurare un assoluto riparo alle navi. Era in comunicazione col mare attraverso il porto di Claudio, che venne così ad assumere la funzione di porto esterno, e fu collegato al fiume per mezzo di un canale navigabile e banchinato.
Il bacino interno ebbe forma esagonale con una profondità di 5 metri ed una superficie di 330.000 mq.

F.3 - Il Porto di Traiano. Ricostruzione plastica di I. Gismondi. (Museo di Porta S.Paolo)
Oggi, una moltitudine di pescatori si aggira lungo le banchine d’ormeggio, ancora corredate di bitte e golfali e forse, nonostante la presenza di ruderi importanti, soltanto qualche studente prossimo alla laurea riesce ad immaginare l’imponenza di quei magazzini alti cinque o sei piani (horrea), che facevano da sfondo ai cantieri per le riparazioni e l’allestimento delle navi ed assistevano alle operazioni di sbarco ed imbarco delle merci sulle grandi navi onerarie dei naviculari.
A diretto contatto con le strutture portuali si sviluppò un centro abitato, che divenne grande quanto la stessa Ostia: la città di Porto.

F.4 - Il Porto di Traiano. Ricostruzione grafica dei magazzini. Disegno di G.Caraffa. (Museo della Civiltà Romana)
Le navi cariche di merci contenute in migliaia di anfore, i containers dell’epoca, ormeggiavano sia nel porto di Claudio che in quello di Traiano. Lo stoccaggio avveniva nei magazzini e la mercanzia era trasportata a Roma, sia risalendo il fiume tramite il piccolo cabotaggio, oppure via terra sulla Portuense, fino ai depositi fluviali del Testaccio, Ripetta ecc…
Se si pensa che il commercio marittimo dell’antichità si svolgeva soltanto nei mesi di “tempo assicurato” possiamo immaginare quanto dovevano essere congestionate le banchine, i moli, le calate e i canali di quell’immenso bacino portuale.
A partire dal 44 d.C., quando furono nominati due procuratores annonae, i quali dipendevano direttamente dal Prefetto dell’Annona di Roma, le imprese private furono gradualmente assorbite dall’organizzazione ufficiale dello Stato.
Una numerosa schiera di dipendenti aveva i compiti di provvedere al controllo delle merci in arrivo, alla verifica delle qualità e della quantità, di sovrintendere alle distribuzioni, al magazzinaggio, alla conservazione, di provvedere ai pagamenti e curare i contratti con le numerose agenzie di trasporto navale e terrestre, di mantenere i rapporti con le provincie produttrici di mercanzie primarie quali il grano, l’olio, il vino ecc.
Ai dipendenti dello Stato faceva riscontro un gran numero di lavoratori autonomi: muratori e carpentieri attendevano alla manutenzione del porto e delle banchine, alla riparazione delle navi e alla costruzione d nuove; altri operai erano addetti al carico e allo scarico delle merci, i barcaioli ai traghetti sul Tevere e al piccolo cabotaggio. I palombari erano presenti ed adibiti al recupero delle merci affondate.
Questi lavoratori, artigiani ed operai, ottennero il permesso di associarsi e di scegliersi un rappresentante tra i cittadini più influenti, a volte anche fra gli stessi senatori; nacquero così le corporazioni, associazioni a carattere sindacale sorte per proteggere i diritti del lavoratore. Questo termine è tuttora in uso, proprio tra i piloti dei porti italiani.
In questo settore, alle notizie degli antichi storici si aggiunge ad Ostia una fonte archeologica, rappresentata da quel monumento unico nel suo genere, che è il cosiddetto Foro delle Corporazioni, il grande piazzale porticato che sorge alle spalle del Teatro.
Il porticato comprendeva in tutto 78 intercolumni ognuno dei quali era sede d’altrettanti uffici di Agenzie Marittime, imprese commerciali ecc..
Davanti a ciascun ufficio, sul pavimento del porticato, un mosaico indicava il genere di commercio ed il paese d’appartenenza dell’impresa.
Per un altro curioso raffronto, aggiungiamo che le Agenzie Marittime presenti oggi nel porto di Genova non superano il centinaio.
Ulpiano (III sec.d.C.) riferisce che “nessuna nave poteva entrare in un fiume senza il gubernator”, e dal contesto si capisce che con tale termine intendeva il pilota portuale, la cui attività ben si differenziava dal “magister navis”, dal “nauta”, dal “proreta”, dallo “stratico”.
Piloti-mare, piloti-canale, piloti-porto, piloti-fiume? Conoscendo la razionalità degli antichi romani, ma soprattutto la loro pragmaticità, è molto probabile che le prestazioni di pilotaggio siano state diversificate per specializzazione ed espletate nei vari flussi di traffico portuale.
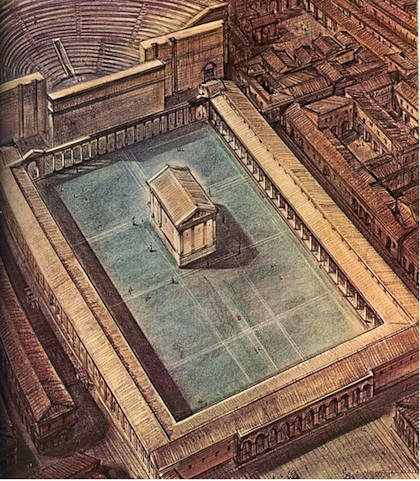
F.5 - Ostia – Foro delle Corporazioni: ricostruzione grafica dell’arch. C.A. Carpiteci, vista dal lato verso il Tevere.
Qui termina la nostra escursione e questo battito di ciglia verso le nostre radici mi suggerisce una breve riflessione:
Il comandante ed il pilota vengono da lontano e si tengono per mano sin dall’antichità. La loro lunga esistenza permane nel tempo per due semplici motivi, il loro impiego è legato al buon senso che è tipico della gente di mare; il loro destino è quello di cavalcare insieme, sempre, la tecnologia del tempo.
Carlo GATTI
Rapallo, 30.05.11
... LE NAVI DI ROMA ANTICA
LE NAVI ANTICHE
Studi inediti di Silvano Masini
30.05.11
Il tempo antico...
Le notizie navali del mondo antico occorre cercarle su epigrafi, ritrovamenti archeologici, reperti, saggi ecc. che comunque storicizzavano la notizia rispetto ad eventi spesso non legati al mare: per esempio spedizioni militari e commerciali, narrazioni belliche e commerciali, miti, ecc.
Di quello che accadeva nei porti poco traspare e molto occorre immaginare sulla base del tipo di naviglio e delle sue necessità.
Un lavoro compiuto dal Com.te Gatti per tentare di scoprire il ruolo del Pilota partendo da un importante porto dell’Antica Roma può essere utile anche in questa circostanza per immaginare le esigenze della nave:il Porto di Traiano (Forum16).
Il Porto di Traiano, un porto completamente artificiale per sopperire al progressivo insabbiamento del Porto di Ostia da parte del Tevere e per organizzazione non si discosta dagli altri porti del Mediterraneo simili per importanza.
Uno spazio ricavato in una insenatura protetta, un banchinamento ed una serie di magazzini (horrea) per il ricovero della merce…un pò come adesso se vogliamo ma con dimensioni diverse.
Notizie dell’epoca, forse enfatizzate, parlano di fari di grandi dimensioni posti all’entrata, tipico il mitico colosso Rodi sotto il quale passavano persino le navi.
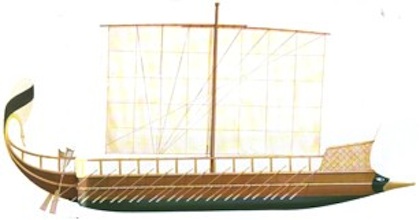
F.1 - Nave Greca 500ac
Ma come erano le navi di allora ? Oggi diremmo barche, o leudi,
La loro lunghezza non superava i 15 metri, il pescaggio limitato a un metro o poco piu e la propulsione principale esclusivamente a remi.
Uno straccio di vela quadra su un alberetto aiutava con vento favorevole chè la bolina non farà la comparsa prima del 1400 e non nel Mediterraneo: l’introduzione di un fiocco a prora fu una invenzione determinante.
Probabilmente in ogni caso la nave entrava in porto con la forza del remo ed in quel modo si avvicinava alla banchina e qui di sicuro la lunghezza e il numero dei remi ne impedivano un agevole attracco.
Su navi antiche i remi erano lunghi circa cinque metri ma diventavano dieci sulle galere veneziane (lunghe fino a 40 metri), ed il numero da una ventina saliva fino a ottanta per un peso che poteva arrivare a 55 chili.

F.2 - Tipologia di nave usata fino all’antica Roma
La manovra non deve essere stata molto agevole, inoltre era sempre in agguato il pericolo della rottura dei remi, che tranquilli nell’acqua diventavano fragili contro ostacoli massicci..
Una notizia che può interessare i liguri.
Nel’400 a Chiavari c’è una florida industria per la costruzione dei remi venduti specialmente in tutto il Mediterraneo, esclusa Venezia che provvedeva in proprio (e per le zone di influenza) con l’Arsenale.
C’è un documento del 1456 dove si legge una spedizione di 300 remi Chiavaresi diretti alla flotta Catalana.

F.3 - Galera veneziana: Arrivo a Venezia
C’è da credere che molto opportunamente il Capitano (o Patrone, come si chiamava) preferisse mettere a mare una lancetta con una doppia funzione : rimorchio ed ormeggio.
Questa lancetta (di servizio diremmo noi oggi, un po’ il gommone di Barcacciante memoria) la troviamo sulle rappresentazioni d’epoca rizzata in coperta, e non pensiamo fosse per salvataggio: a quel tempo la vita non valeva niente ed in caso di sinistro qualche pezzo di legno galleggiava sempre.
Ne abbiamo conferma nel dipinto che ci mostra una galera in arrivo a Venezia (XIII sec.) dove si puo’ notare una lancetta sulla destra con un cavo che scende da bordo. Certo un aiuto alla nave in arrivo, resta da scoprire se apparteneva alla Nave stessa oppure è fornita dal Porto, in questo caso il Magistrato delle acque ( una specie di Presidente del Consorzio del Porto, ma a Venezia con poteri enormi), oppure libera iniziativa di un barcaiolo assoldato. E’ importate questo particolare non essendo questa una foto (siamo nel ‘300 !) scattata in qualsiasi momento, è’ un dipinto che il pittore non ha creato in un attimo ma ha ragionato sulla situazione e se ha colto questo particolare è segno della usualità di questa funzione. Non una-tantum che puo’ sfuggire all’osservazione, ma un dato costante che accompagna la nave nella manovra portuale tanto da meritare l’onore della cronaca pittorica.
Nella nostra ricerca storica questa è l’unica testimonianza che abbiamo trovato, ma sicuramente testimonia un fatto da tempo in uso e che possiamo applicare anche a tempi piu antichi. Ci sono a Genova documenti notarili del 1300 e avanti (Archivio Storico del Comune di Genova) che attestano la costituzione di associazioni di barcaioli per operare all’interno del Porto con mansioni varie che vanno dall’aiuto generico alle navi al pilotaggio (pratico, lo indicano). C’è quindi da ritenere che, almeno nei porti maggiori, la nave fosse dispensata dall’uso della sua barca. Avrete compreso come ci sia una enorme carenza riguardo al rimorchio nel tempo antico, ed anche a ridosso dei secoli seguenti a le notizie non saranno molte. Molto quindi affidiamo alla verosimiglianza del racconto, che peraltro riteniamo attendibile sulla base delle nostre esperienze quando arrivavamo in località prive di ogni servizio e non erano poche in giro per il mondo. Ci si doveva arrangiare, come mille anni fa. La povertà di informazioni ci lascia spazio per alcune notizie rigorosamente documentate circa la galera e che non sono nell’usuale immaginario collettivo e che può essere curioso apprendere. Le galere, tipica nave mediterranea, erano armate in Primavera e rimessata in Ottobre, partivano in gruppi (“mude” le veneziane,”maone” le genovesi) un po’ per sicurezza ed un po’ perché il tempo favorevole era comune per tutte. A bordo vivevano financo 250 persone, due terzi incatenate ai banchi di rema impossibilitati al movimento e comunque con spazio limitato a tutti per necessità di carico.
Abbiamo una ricostruzione storica della galera in piena operatività che ci va di proporre per rendere l’idea dell’affollamento della gente a bordo fra marinai, rematori e pellegrini.

F.4 - Una galera grande sulla via di Gerusalemme Sec.XII
E’ facilmente intuibile come la situazione igienica a Bordo fosse molto approssimata ad onta delle “bugliolate” di acqua che giornalmente erano distribuite con generosità in coperta.
Il cassero poppiero, dimora degli ottimati (patrone, scrivano, capitano, uffiziali, e gentiluomini) era perennemente incensata nel tentativo di coprire gli effluvi della copertata. anche se il concetto di pulizia dell’epoca era molto diverso dal nostro. E mentre ci è facilmente possibile ricostruire il modo di vestire e le abitudini del tempo tramite i dipinti, ci è impossibile immaginarne l’odore del tempo antico non solo a Bordo. Diversi autorevoli studiosi si sono cimentati a supporre questo aspetto e c’è un bel libro “Parfume” di Patrik Süskind (1985) ed un film di Tom Tykwe (2006) che trattano il tema olfattivo negli aspetti piu diversi, cimentandosi a ricostruirlo. Qualcosa però ci illumina sull’argomento, vediamolo. Dunque la galera.
Per il suo arrivo al, diciamo cosi, Porto di Armamento a missione compiuta, a Bordo ferveva una eccezionale operazione di pulizia che iniziava già giorni prima e si estendeva anche alla stiva con relativa caccia ai topi. (v. Forum/7)
Non molto diversamente a quello che si fa oggi sulle Barcacce (topi esclusi, ovviamente) di ritorno a casa anche per cancellare i segni del viaggio difficile e presentarsi col vestito buono della festa. Un po’ di orgoglio per ben apparire non guasta. La Sanità Marittima Veneziana era inflessibile, troppo vicino (siamo nel 1300) era stata la conseguenza dei topi giunti a Genova (cosi dice la storiografia) con la peste bubbonica, la famosa peste nera, un‘epidemia che in una generazione ridusse ad un terzo la popolazione europea. Il rischio di lunghe quarantene era in agguato. Sul fanale di Bocca di Lido c’era appostata una vedetta che riportava prontamente a S.Marco la notizia dell’approssimarsi della muda. Ma come ne avvertiva l’arrivo? Dagli alberetti spuntare all’orizzonte ? Da una veloce feluca che incrociava nei pressi ? Niente di tutto questo.. Si narra che, specie nelle giornate di scirocco sempre presente in autunno al tempo del ritorno, l’arrivo era annunciato con largo anticipo dall’odore (!) proveniente dalla flotta in arrivo e non era un dolce effluvio.
E questo la dice lunga sulla situazione di Bordo dell’epoca e per lungo tempo ancora.
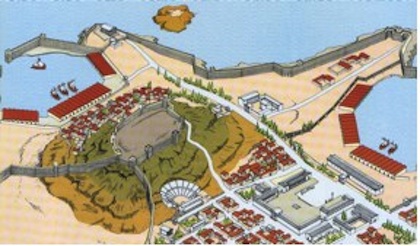
F.5 - Il grande complesso del Pireo nel V Sec.AC
Capitolo 3
…il tempo di mezzo.
E’ il tempo dello sviluppo della navigazione a vela come si presenta nell’immaginario collettivo e come è giunta fino a noi come “arte navale” per eccellenza. Dalla Caravella ai Galeoni fino ai mitici Clipper una evoluzione costante durata trecento anni: dal XIV al XVII secolo. L’epoca delle grandi scoperte geografiche e dallo sviluppo dei Porti Atlantici: subito Siviglia, Lisbona, Cadice e poco dopo Londra ed i Porti Olandesi. Il commercio cambia rotta ed il Mediterraneo si marginalizza dalla grandi vie marittime, Genova e Venezia lentamente modificano i loro assetti navali per vie diverse ma vanno in progressivo decadimento.

F.6 - Caravella 1400
La nave a remi regge poco in Atlantico. Il canto del cigno della galera sarà a Lepanto nel 1571 e pochi anni dopo sparirà definitivamente con la Invincible Armada Spagnola nella Manica contro l’Inghilterra nel 1588.
Genova mette in conto un particolare poco noto e portato alla giusta luce da uno studioso francese amante della nostra città, Jaques Hees, e che ha suscitato la nostra curiosità. Nel XIV secolo Genova, stretta fra Venezia principale mediatrice con l’Oriente ormai chiuso dagli Arabi e un Occidente Atlantico in prorompente sviluppo seppe per un secolo volgere a proprio vantaggio una difficile situazione. A differenza di Venezia, Genova non utilizzò molto la galera puntando di piu sull’uso della vela e del maggior spazio per il carico. Nel ‘400 si inventa una nave grandissima per l’epoca (fino a 1000 tonn.) e con questa si attrezza con viaggi tuttofare (una specie di rinfusiera) per il trasporto di carichi non pregiati (allume specialmente) fra il Mediterraneo ed il Nord Europa, favorita anche dalla difficoltà nelle vie terrestri. Viaggi non ambiti dai paesi Atlantici impegnati oltremare ed in parte snobbati da Venezia tesa alle merci piu pregiate. Erano navi grandi e di scarsissima manovrabilità, toccavano pochi porti quasi sempre allibando. Il loro utilizzo e la loro costruzione non ebbero duratura fortuna: scarsa era la reperibilità del legname a Genova, le vie di terra andavano migliorando ed inoltre il commercio oceanico richiedeva navi piu manovriere ed adatte al trasporto di merci pregiate (spezie da oriente, oro e argento dall’America).

F.7 - Una bellissima ricostruzione di Cutter Olandese del XVI secolo.
Non c’è traccia di questo barco genovese se non uno scorcio nelle rappresentazioni guerresche nei porti di Terrasanta e dalle scarse cronache del tempo. Possiamo solo registrare lo stupore degli osservatori del tempo che nelle loro cronache mostravano meraviglia per la grande mole di qesto barco genovese inusuale per l’epoca. Una differenza notevole fra Genova e Venezia nella gestione della flotta è un dato da conoscere per capire il diverso evolversi delle due grandi Repubbliche Marinare. Venezia aveva una gestione statalizzata (oggi si direbbe cosi) della flotta mentre quella genovese era completamente lasciata alla libera iniziativa. Questo fece si che Genova, all’aumento delle difficoltà nei commerci e alla carenza di legname, si concentrasse di piu sugli investimenti finanziari…visto che i denari non mancavano. Venezia si concentrò sul residuo commercio con Medio Oriente e si espanse verso terra giungendo fino ai confini della Lombardia. Impensabile per Genova stretta fra monte e mare.

F.8 - Galeone 1500
Liquidare con qualche paginetta secoli importantissimi e decisivi di Storia è sempre una operazione difficile, monca e pericolosa, ma a noi serve unicamente per inquadrare un angolo che ci riguarda da vicino : le navi, i Porti, i servizi portuali. Queste navi hanno un tonnellaggio di circa 250/300 tonn.per una lunghezza intorno ai 40 metri, molto manovriere in mare, procedono anche di bolina stretta, adottano le tecnologie piu recenti (timone centrale,fiocchi, forme di carena in pieno sviluppo idrodinamico).
I Porti si ampliano: Cadice, Siviglia, Lisbona e poi Londra e Olanda. Porti Atlantici influenzati dalle ampie escursioni di marea alle quali si affida la Nave per scegliere l’entrata in porto o la risalita dei fiumi sui quali erano situati gli empori piu importanti

F.9 - Bastimento per le Indie 1600
Non si hanno notizie particolari su servizi di rimorchio, ma sappiamo per certo che quelle navi venivano rimorchiate da lance per uscire dal Porto e presentarsi alla marea od al vento favorevole.
Dato il regime autarchico della gestione-nave non è difficile supporre che il compito fosse affidato ai marinai di Bordo e che anche all’arrivo tale pratica fosse di uso comune. D'altronde il traino a remi era praticato nelle bonacce equatoriali e persino serviva a posizionare i battelli da guerra in battaglia quando il vento non era favorevole. Quel barcone genovese di cui abbiamo parlato faceva documentato largo uso di braccia alla bisogna e sicuramente necessitava di “rimorchiatore” . Nella nota spese del Padrone, fra buglioli e cime, troviamo talvolta “barcaiolo”. A che serviva? Non certo per la franchigia nel caso la nave sostasse alla fonda (chè c’era il gozzetto di bordo, caso mai) piu facile pensare al costo per un servizio indispensabile reso alla nave: per esempio ormeggiatore o una mano ad attraccare, od entrambi allo stesso tempo. Non è un’ipotesi azzardata.

F.10 - la Victory di Nelson a Trafalgar (seconda metà XVII sec)
Nel Capitolo precedente abbiamo citato documenti notarili del ‘300 attestanti la costituzione di Associazioni di Barcaioli (Corporazioni) a Genova..
Le stesse fonti testimoniano uno sviluppo ed una articolazione maggiore in questo servizio citando : Barcaiolo della Compagnia dei Soccorsi Marittimi, Barcaioli avventizi, Barcaioli “tollerati” (si suppone semi-abusivi), Barcaioli al servizio delle Navi (anche con compiti di allibo), Barcaioli Piloti Pratici (una prima menzione di Pilotaggio ante-litteram, e forse derivato da Barcaioli fra piu abili). Da qui si intuisce una regolamentazione Portuale che prende forma, si sviluppa, si specializza e che crediamo si possa estendere per similitudine ai maggior porti Mediterranei ed Atlantici che stavano assumendo importanza ben maggiore di Genova nel panorama commerciale mondiale.
Abbiamo citato il Clipper solo come esempio della massima espressione raggiunta dalla vela, in realtà questo magnifico gabbiano opera in un’epoca in cui il vapore si è già affacciato alla ribalta ed il “Rimorchiatore” è già parte della scena anche fotografica del panorama portuale. Ne parleremo nel prossimo capitolo.

F.11 - I Clippers “Ariel” e “Taeping” si sfidano sulla rotta del te (1850)
Foto a cura di Carlo GATTI
I CLIPPERS, le "Ferrari" dell'800
I CLIPPERS
le “FERRARI” dell’800

La Grande Corsa del Té del 1866
Foto n.1 - La cartina mostra la rotta principale dei Tea-Clippers da Foochow (Cina) a Londra che fu teatro di epiche regate commerciali. Le frecce nere indicano i venti predominanti nel periodo compreso tra maggio e settembre. In condizioni favorevoli i Clippers raggiungevano 20 nodi di velocità, come un traghetto di oggi, ma erano spinti dal vento e manovrati da superbi marinai.
Clipper, (dall’inglese to clip=tagliare, il vento, le onde, i primati ecc...) fu il nome attribuito all’ultimo esemplare, il più perfezionato dell’evoluzione della nave a vela. Nacque in America nel 1820 sull’onda di una profetica intuizione mercantile: “il commercio prenderà le vie del mare”. Ma i Cantieri americani ebbero un’altra intuizione, questa volta d’ingegneria navale: “lo spostamento della sezione maestra dello scafo verso prua conferirà al veliero una maggiore stabilità in navigazione”. Tuttavia, la caratteristica principale del clipper doveva essere la velocità derivante dalle più affinate linee d’acqua dello scafo e dalla maestosa superficie velica ben superiore alle unità equivalenti dell’epoca. Il clipper fu quindi progettato per essere un autentico levriero degli oceani, e per raggiungere tale obiettivo fu persino diminuita la capacità di trasporto del carico. I risultati raggiunti ripagarono questo sacrificio. Il clipper raggiungeva, infatti, una velocità di 15 nodi con punte di 20 nodi quando la velocità massima degli altri velieri e delle stesse navi a vapore era di 5-7 nodi in condizioni ottimali. I clippers furono costruiti da cantieri inglesi, olandesi, francesi e americani, ma i primi a scendere in mare furono i piccoli Clippers di Baltimora (USA) che entrarono in scena durante la guerra (USA-UK) del 1812, proprio per le tensioni commerciali. La storia di questa categoria di velieri si usa suddividerla in cinque periodi dell’800:
1830-1850: I Clippers dell’Oppio. La Compagnia delle Indie manteneva il monopolio sulla vendita della droga. Erano velieri di limitate dimensioni, ma particolarmente ben costruiti e soprattutto veloci. Armati di qualche cannone ed esperti equipaggi, andarono scomparendo intorno al 1860, quando venne abolito il monopolio ed il traffico della droga divenne meno redditizio.
1845-1860: I Tea-Clippers americani. Nel periodo aureo ne furono costruiti ben 137 per fronteggiare l’aumento del consumo del tè negli Stati Uniti. Furono varati a New York e nella Nuova Inghilterra, tuttavia, a causa della forte richiesta, il legname impiegato per la loro costruzione non poteva raggiungere una buona stagionatura, e questa limitazione diminuiva la resistenza alle forti sollecitazioni dell’alta velocità. Per questo motivo, i clippers americani furono meno longevi dei loro rivali inglesi. Dopo il 1849, con la scoperta dell’oro in California, i Tea-Clippers furono adibiti al trasporto dei cercatori d’oro che si trasferivano dalla costa atlantica degli Stati Uniti a San Francisco via Capo Horn. Il viaggio lungo e pericoloso proseguiva nel Pacifico verso la Cina per l’imbarco del tè. Da qui i clippers ripartivano con rotta a ponente e, doppiato il Capo di Buona Speranza, affrontavano l’Atlantico puntando su New York dove si concludeva il giro del mondo. Nel 1850 giunse a Londra il primo clipper americano carico di tè cinese. La cantieristica inglese fu messa in allarme di fronte al “vascello” che aveva impiegato solo 97 giorni da Hong Kong a Londra. Questo periodo si concluse con l’apparire delle prime navi a motore e gli affondamenti provocati dai corsari sudisti durante la guerra di secessione. I clippers superstiti furono venduti ai portoghesi di Macao e agli Armatori Liguri del Callao (Lima) che li adibirono al trasporto di emigranti cinesi in Perù per la raccolta del guano, ottimo fertilizzante naturale molto richiesto in Europa.
1850-1875: I Tea-Clippers Inglesi. Costruiti con solido e stagionato teak birmano, avevano la linea dello scafo più lunga, aggraziata e filante di quelli americani. I maggiori costruttori di Clippers inglesi furono: A.Hall, H.Hood, Connell, R.Steele di Aberdeen-Scozia, Pile di di Sunderland, Chaloner di Liverpool, Laurie di Glasgow e infine Scott & Linton di Dumbarton, i costruttori del celebre Cutty Sark. In coperta avevano un piccolo castello a prua ed una tuga a poppa. Il cassero accoglieva invece gli alloggi del Capitano e degli ufficiali. Nel 1863 i clippers inglesi adottarono una tecnica mista di costruzione che prevedeva l’ossatura in ferro, mentre rimaneva invariato l’impiego del legno per il ponte di coperta ed il fasciame esterno. I migliori Tea-Clippers furono costruiti proprio in quegli anni, e con quella tecnica innovativa segnarono l’apogeo della vela nel trasporto rapido delle merci. Erano tutti sotto le 1.000 ton. di stazza e i loro nomi divennero celebri: Serica (1863), Taeping (1863), Young Lochinvar (1863), Chinaman (1865), Ariel (1865), Sir Lancelot (1865), Titania (1866) e, naturalmente, molti altri.
1820-1865: I Clippers-Passeggeri. Noti come “packets”, (da cui Paquebot in Francia e Pacchetti in Italia), furono pur sempre comodi e veloci clippers adibiti al trasporto passeggeri. Collegavano i porti atlantici USA: New York, Boston, Filadelfia e Baltimora con il Nord Europa. Rimasero in attività un cinquantennio e precedettero di un secolo “i famosi transatlantici di linea” che continuarono quel flusso regolare fino al 1970. Comandati da esperti uomini di mare, e manovrati da equipaggi sceltissimi, questi clippers offrivano comode e lussuose sistemazioni per una cinquantina di passeggeri. Per il viaggio di ritorno trasportavano emigranti in cerca di fortuna negli States. La traversata durava in media 15-20 giorni. Una singolare testimonianza d’efficienza dei “packets” ci fu lasciata da un romantico epitaffio dedicato al ritiro di un clipper della Black Ball Line: “Era uno dei più veloci e lussuosi. In 29 anni effettuò 116 traversate complete. Non aveva mai perduto gente in mare, né subito avarie notevoli. Trasportò 30.000 passeggeri e vide 1200 nascite e 200 matrimoni”.
1865-1890: I Colonial o Wool-Clippers. In ordine di tempo fu l’ultima categoria di quei velieri veloci che furono costruiti in Inghilterra e negli USA per assicurare i collegamenti commerciali con l’Australia, la Nuova Zelanda e la Tasmania. Gli scafi dei colonials furono dapprima in legno, in seguito vennero costruiti con la “tecnica mista” già descritta, che permise di realizzare unità estremamente solide e di notevoli dimensioni facendo così fronte alla grande richiesta di navi per le rotte australiane. Fu proprio il ferro usato per la loro costruzione che permise ai colonials di resistere ancora per un ventennio dominando su tutti i mari fino alla fine del secolo.

Foto n.2 - Il Cutty Sark é conservato ancora intatto nel “CUTTY SARK CLIPPER SHIP MUSEUM” nel bacino del Maritime Greenwich World Museum Heritage di Londra.
Gli Inglesi la definirono: “La grande corsa del tè del 1866”
Nella “Londra Vittoriana”, con il consumo del tè, ci fu un vero cambiamento di costume nazionale, in pratica s’instaurò una moda che ebbe molte ripercussioni persino nei trasporti marittimi. L’annuale arrivo del primo carico di tè primaverile cinese, considerato il migliore (una pianta dava tre raccolti), veniva pagato 10 scellini ogni 50 piedi cubici, e 100 sterline di premio erano destinate al Capitano del clipper che arrivava per primo sui mercati. Questo tangibile riconoscimento diede il via ad una vera e propria “corsa del tè” che coinvolse navi e capitani famosi, in primo luogo il “Cutty Sark” che, ironia della sorte, non riusciva ad imporsi sul diretto concorrente “Thermopylae”, malgrado la sua meritatissima fama. Molte furono le coppie rivali di clippers che divisero l’opinione pubblica mondiale in vere e proprie tifoserie di scommettitori e appassionati che investivano somme ingenti sulle vittorie di questi “levrieri d’altura”. Qui si aprirebbe un capitolo lunghissimo e affascinante, purtroppo, per ragioni di spazio, non possiamo che fare riferimento soltanto a quella che fu la gara più spettacolare che sublimò le grandi corse dei clippers.
Fu sicuramente per ragioni di mercato che, alla fonda nella rada della Pagoda a Foochow-Cina, si trovassero quell’anno ben 16 Tea-Clippers in attesa di caricare i nuovi raccolti: l’Ada, l’Ariel, il Belted Will, il Black Prince, il Chinaman, il Coulnakyle il Falcon, il Fluing Spur, il Fieri-Cross, il Golden Spur, il Pakwan, il Serica, il Taitsing, il Teaping, il White Adder, lo Yahgtze. Fra i protagonisti più attesi c’erano: il Serica di 708 T. varato nel 1863 e comandato dal Capitano Gorge Innes; il Fiery-Cross da 888 T. comandato del Capitano Richard Robinson, già vincitore di regate precedenti; il Taitsing da 815 T. al suo esordio col Capitano Daniel Nutsford; il Teaping 767 T. comandato del Capitano Donald Mckinnon ed in fine l’Ariel da 853 T. al comando del suo famoso Capitano John Keay, il quale, riferendosi al suo clipper diceva: “Posso contare su di lui come su un essere vivente”.
L’Ariel fu il primo a chiudere i boccaporti delle stive, a chiamare il pilota e a discendere il fiume Min al traino di un rimorchiatore. Ma la sua rapida partenza fu rallentata dalle manovre sbagliate del comandante del rimorchiatore. Purtroppo in mare gli errori si pagano subito e il Fiery-Cross n’approfittò per attuare un clamoroso sorpasso che gli diede un notevole vantaggio in mare aperto. Di quella rallentata partenza se n’avvantaggiarono anche il rivale Teaping, il velocissimo Serica ed il Taitsing che ormai lo tallonavano a qualche centinaio di metri. I clippers erano velieri molto sensibili all’assetto del carico e cap. Keay ben presto s’accorse che la sua nave era troppo appruata e perdeva velocità. Fece spostare pani di ghisa di zavorra, ancore, catene e persino delle casse dentro la sua cabina. Finalmente il primo di Giugno, Keay spiegò al vento tutte le vele del clipper e, lasciato lo stretto di Formosa, mise la prua verso il Mar della Cina meridionale, costeggiò la Malesia, Sumatra e infilandosi nello stretto della Sonda entrò nell’oceano Indiano. Erano trascorsi 21 giorni dalla partenza e in quel momento Keay non sapeva che il Fiery-Cross lo precedeva di un giorno. Spinti dagli Alisei di Sud-Est entrambi volarono verso le Isole Mauritius. Pochi giorni dopo anche il Teaping, il Serica e il Taitsing attraversarono lo stretto lanciandosi al loro inseguimento sull’oceano indiano. Qualcuno da terra li vide e la notizia del loro passaggio rimbalzò a Londra suscitando l’entusiasmo di migliaia di scommettitori Inglesi. Il 25 Giugno Capitan Keay annota sul giornale di bordo che l’Ariel deve rallentare per imbarco d’acqua nello scafo e per la rottura di alcuni alberetti a causa dell’eccessivo sforzo. La sua ansia aumentava non avendo la minima idea di chi fosse in testa alla gara. Doppiato il Capo di Buona Speranza, l’Ariel mise la prua a Nord-Ovest con gli Alisei in poppa, lasciò l’Isola di S.Elena sulla sinistra e si trovò il 4 di Agosto nelle calme equatoriali in compagnia del Fiery-Cross e del Teaping.
Lasciato di poppa lo “scoglio delle bonacce”, i Clippers navigarono verso Nord lasciandosi Capo Verde sulla dritta e puntarono sulle Azzorre alla ricerca di vento gagliardo da ponente. Il Golfo di Guascogna fu clemente e l’approaching alla Manica avvenne intorno ai primi di settembre. Quando cap. Keay giunse il giorno 5 in vista della costa meridionale dell’Inghilterra, credette d’aver vinto il race fino a quando, all’improvviso, intravide sottovento la sagoma inconfondibile del Taeping che avanzava sospinto da forti colpi di vento.
La suspence giunse al massimo stadio quando i due Clippers, attraversato lo stretto di Dover, si presentarono appaiati alla foce del Tamigi, agganciarono contemporaneamente il rimorchiatore portuale per risalire il fiume e si diressero verso i rispettivi Docks d’attracco. Ma nel finale di questa “nevrotica quanto appassionante” traversata accade ancora qualcosa d’imprevisto. Il capitano Keay dell’Ariel decise di rallentare il suo clipper per evitare d’incagliarsi durante il riflusso della bassa marea. Il Taeping aveva un pescaggio inferiore ed il suo capitano McKinnon non solo sorpassò il rivale ma lo precedette di circa un’ora, ma fu costretto a dare fondo l’ancora a causa della bassa marea. A questo punto l’Ariel, convinto per l’ennesima volta d’aver vinto, anche perché la sua banchina era più vicina di quella del rivale, sopraggiunse sorpassando l’avversario che stava salpando l’ancora. Purtroppo il calcolo dell’ora di marea fu impreciso: il momento dell’inversione della marea, e quindi l’altezza dell’acqua non era ancora sufficiente per consentirgli l’attracco. L’attesa delle giuste condizioni durò ancora un’ora, giusto il tempo di permettere al Taeping di ormeggiare per primo.
Il Teaping aveva vinto per soli 23 minuti. Ma ciò che rese “storico” quel viaggio fu la coincidenza che vide tre clippers, partiti insieme dalla Cina, entrare quel giorno nel porto di Londra con la stessa marea. Il Serica attraccò un’ora dopo.

N.3 - I Clippers inglesi ARIEL (1865-1872) & TAEPING (1863-1871)
Immortalati in un celebre quadro
L’apertura del Canale di Suez (1869) e quello di Panama (1914) ridussero di mesi i percorsi marittimi e segnarono, insieme al progressivo perfezionamento dei motori marini, la fine di una grande epopea velica.
Carlo GATTI
Rapallo, 26.05.11
SAMUEL MORSE - ALFRED VAIL
SAMUEL MORSE - ALFRED VAIL
AMICI NELLA VITA, DIVISI NELLA STORIA
Questa specie d’epitaffio potrebbe rappresentare la sintesi di quanto è emerso recentemente negli Stati Uniti sulla storia delle telecomunicazioni.

Foto n.1 Samuel Morse
Il mito di Samuel Morse inventore del Codice Telegrafico è stato smontato. Un altro americano, Alfred Vail è salito improvvisamente sugli scudi come l’inventore del cosiddetto Alfabeto Morse reso celebre dalle combinazioni: punto e linea.
In seguito a questo accertamento della verità, si sono registrate molte reazioni che hanno oscillato tra la delusione e il tradimento da parte d’intere generazioni di naviganti, per non parlare del senso di frustrazione che ha attanagliato gli addetti ai lavori di numerosi settori delle radiocomunicazioni tra cui i bravissimi radioamatori.
In ogni caso, siamo sicuri che l’umanità intera, al di fuori dei “discussi” personaggi che l’hanno inventato, si sente ancora debitrice di tanta riconoscenza a questo velocissimo sistema di trasmissione, al quale, oltretutto, è accreditato il salvataggio di un numero enorme di naufraghi e sopravvissuti, sia in tempo di guerra che di pace.

Foto n.2 Alfred Vail
La Storia
Nel 1830 Samuel Morse è un docente d’arte all’università di New York e si diletta di pittura. Subisce alcuni tracolli finanziari e si dedica alla scienza. Nel 1837 tiene una dimostrazione pubblica con l’intento di propagandare e forse realizzare un sistema elettrico che invia messaggi via cavo.
Purtroppo Morse è un artista che non sa nulla d’elettricità ed il suo primo congegno telegrafico risulta essere un sistema complesso, ingombrante e poco funzionale. Ma il progetto attira l’attenzione di Alfred Vail, figlio di un ricco industriale di Morrison (New Jersey), che è laureato in giurisprudenza, ma disoccupato a causa della depressione che ha colpito l’America. Il giovanotto si offre di aiutare Morse, ma soprattutto convince suo padre a finanziare l’impresa e a concedergli l’utilizzo dei suoi laboratori. A questo punto della vicenda, emerge la prima curiosità storica: mentre Vail lavora sodo per migliorare l’efficienza del telegrafo, Morse preferisce dedicarsi ai suoi affari e non partecipa neppure alle ricerche.
Morse ha creato un complicatissimo codice che associa un numero ad ogni parola. Quando arriva il segnale, l’operatore deve scorrere tutto il codice scritto, contenuto in un grosso librone, per trovare il significato del numero ricevuto. Per Vail è un sistema troppo lento e inefficiente, perciò riprogetta il telegrafo e apporta una decisiva e definitiva.

Foto n.3- Il grosso codice inutilizzato di Morse
Con l’aiuto di un certo William Bafter, cerca le lettere alfabetiche più usate sui giornali e le assegna i segnali più corti.

Foto n.4 - Immagine suggestiva del “Tasto Morse”
Scoprono che la lettera “e” è la più usata, quindi l’associano al segnale più corto: il punto. Nasce così l’alfabeto basato sul “punto e linea”.
Il Brevetto per il telegrafo elettromagnetico è assegnato il 20 Giugno 1840. La motivazione descrive entrambi i codici, ma il sistema di Vail si rivela molto più semplice da usare.
Siamo giunti alla spiegazione del misterioso “falso storico”: Vail non riceverà alcun riconoscimento, perché il suo nome non compare sul brevetto. Nel 1837, la famiglia Vail aveva ceduto ufficialmente tutti i diritti delle scoperte a Morse. Probabilmente i Vail avevano soggezione del professore perché aveva 20 anni più di Alfred ed era una persona alquanto rinomata e stimata. Samuel Morse diventa ricco e famoso grazie al telegrafo, mentre Alfred Vail muore povero.
La morale della storia sta nella differenza tra l’umiltà di Vail nel sentirsi realizzato senza alcun riconoscimento, e l’astuzia di Samuel Morse che ha saputo mettere a frutto onori, fama e ricchezza. Il tempo ha fatto giustizia. Ora sappiamo che fu Alfred Vail e non Samuel Morse, l’inventore del Codice Telegrafico che porta il suo nome.
Carlo GATTI
Rapallo, 15.11.11
Si ringrazia il Comandante Ernani Andreatta, Curatore del Museo Marinaro di Chiavari, per il supporto iconografico.








