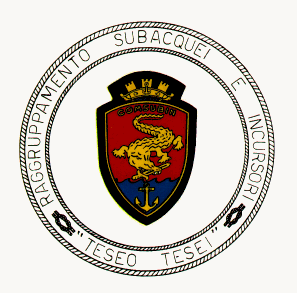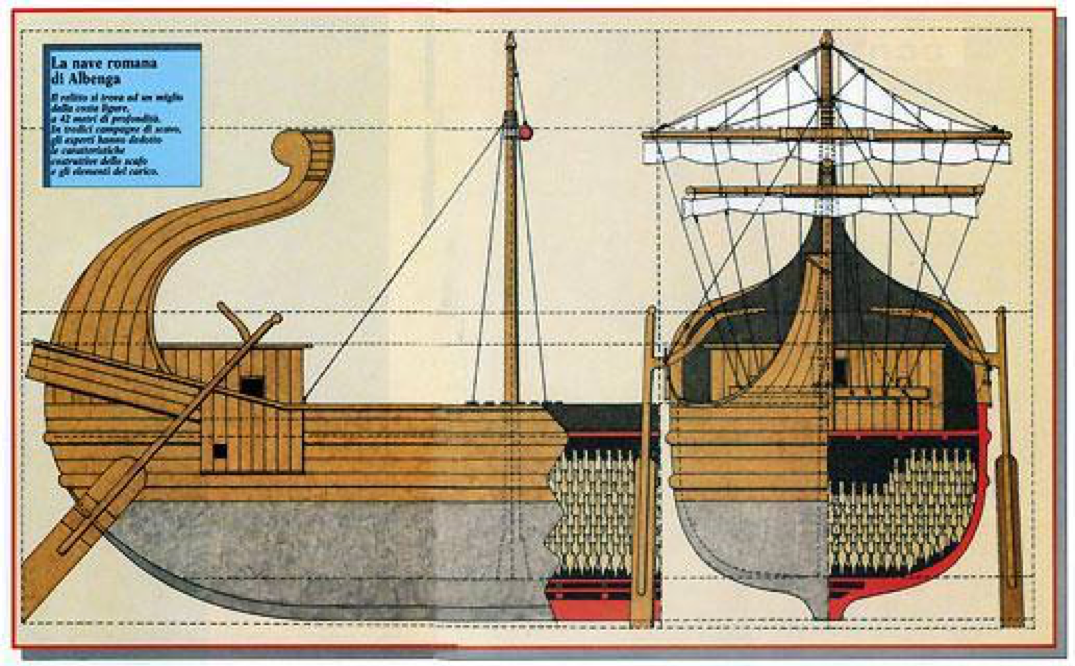IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA -
IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA
LA REPLICA RECA CON SE'
ECHI EVANGELICI DAL MARE DI GALILEA

«È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta». (P.Giordani)

Il 15 marzo 2023 - Papa Francesco ha benedetto la simbolica costruzione, ricevuta in dono dalla famiglia Aponte, armatori di Nlg – Navigazione Libera del Golfo, con la collaborazione e il supporto dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma.

Nella foto, da sinistra a destra, rivolti verso Papa Francesco, i coniugi Aprea, il direttore di NLG Maurizio Aponte e il presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, Paolo Giordani.
Il Papa ha disposto che nei MUSEI VATICANI venga collocata la copia di una imbarcazione di duemila anni fa
La riproduzione perfetta della barca da pesca
L’opera è stata realizzata dagli APREA, storica famiglia di maestri d’ascia della penisola sorrentina, dopo approfonditi studi archeologici con la partecipazione di esperti della marineria antica. In particolare, gli artigiani hanno utilizzato la tecnica dei “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi). Una tecnica importata dall’area mediterranea, operante già dal secondo millennio a.C.
Benedicendo l’imbarcazione prima dell’udienza generale, il Santo Padre ha sottolineato come quella ricevuta sia ‘la barca di tutti’, una frase che attesta la coerenza di un uomo che fin dalla sua elezione ha dimostrato una particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato.
YouTube
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/eventi-e-novita/iniziative/Eventi/2023/barca-di-pietro-approda-nei-musei-vaticani/video-barca-pietro.html
L’imbarcazione è la fedele “replica” - Made in Italy - dell’antico e originale peschereccio di Pietro venuto alla luce nel 1986 dalla melma del lago di Tiberiade in occasione di un improvviso abbassamento delle acque, e custodito nel museo Yigal Allon di Ginosar, luogo indicato dai Vangeli quale sede principale delle predicazioni di Gesù in Galilea di cui ci occuperemo tra breve.

L’imbarcazione è stata sistemata alla base della rampa elicoidale dei musei Vaticani
(come mostra la foto sopra)
La Barca di Pietro accoglie, con la sua forte carica spirituale, pellegrini e turisti di tutto il mondo nella “Casa di tutti”, secondo un’espressione cara a Papa Francesco, Timoniere della Chiesa e instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse.
La Barca di Pietro simboleggia quindi la Chiesa che è guidata dai suoi successori. Gesù invita i discepoli esitanti e dubbiosi a salpare, confidando in Dio. Allo stesso modo, la Chiesa deve misurarsi con le tempeste e le difficoltà del mondo per diffondere l’annuncio del Vangelo della Grazia.
La Barca di Pietro non è più soltanto una metafora
Il dono che la famiglia Aponte, gli armatori di NLG-Navigazione Libera del Golfo ha voluto fare, con la collaborazione dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma, al Santo Padre, “instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse”, come ha spiegato Paolo Giordani, presidente dell’IDI, la cui “particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato” corrisponde pienamente all’”antica legge del mare”. Non per caso il Papa, accettando il dono, l’ha definita “la barca di tutti”.
I Dettagli marinareschi spiegati da APONTE:
L’imbarcazione è una replica perfetta di quella conservata nel museo israeliano come doveva essere ai tempi di Gesù:
scafo: di 8,8 metri x 2,5,
albero: di 8 metri con pennone di 6,
due piccole coperte: a proravia e a poppa
velatura: vela quadra e cavi in fibra di canapa
governo: due timoni
equipaggio, in grado di trasportare fino a quindici persone.
materiale di costruzione: cedro e quercia
tecnica usata: “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi).
Una tecnica importata dall’area mediterranea, in vigore dal secondo millennio a.C. fino all’epoca bizantina esclusa, applicata non su un materiale ligneo unico, ma su materiali misti: cedro, quercia.

Nave EUROPA – graffito
Per le parti andate perdute, gli artigiani sorrentini si sono ispirati ai mosaici del piazzale delle Corporazioni di Ostia, al graffito della nave “Europa” di Pompei, al bassorilievo con veduta del Portus Augusti (collezione Torlonia).
“Desideriamo ringraziare - ha sottolineato Maurizio Aponte, direttore di NLG - Un grazie di cuore va al Governatorato dello Stato Città del Vaticano, che ha mostrato interesse per il progetto e ci ha consentito di realizzarlo, e all’Istituto Diplomatico Internazionale, che ha collaborato nella fase di ideazione e presentazione. Tutti ci auguriamo che il modello della Barca di Pietro possa regalarci nuove emozioni” – ha concluso il direttore di NLG.
“Con questo omaggio al Sommo Pontefice dopo dieci anni di ministero – ha dichiarato P.Giordani – abbiamo voluto dare corpo ad un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La Barca di Pietro che consegniamo oggi non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione. È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta”.
In particolare, viene ricordato l’episodio della tempesta sul lago narrato da Marco (4,38). “Mentre i discepoli erano nel panico perché imbarcavano sempre più acqua, Gesù – dice l’evangelista – se ne stava a poppa e, adagiato sul cuscino, dormiva. Lo svegliarono a furia di grida d’aiuto e lui, destatosi, comandò al mare»: «Taci! Calmati!» (Marco 4,39) «e le acque si placarono» (Luca 8,22-25).
“Sempre il Lago di Tiberiade - rammenta Giordani - fu testimone di un'apparizione pasquale di Gesù risuscitato. Dalla riva suggerì ai discepoli, estenuati per la notte passata senza pescar nulla, di calare la rete dalla parte destra della barca. In questa maniera pescarono una gran quantità di pesci e compresero che lo sconosciuto era il “Messia”. Pietro poi si tuffò per raggiungerlo e Gesù gli disse: «adesso pasci le mie pecorelle». “Questo dialogo è considerato come il momento in cui Gesù affida a Pietro la Chiesa (Giovanni 21,1-19) - commenta il presidente dell’IDI - È da questo testo che fu attinta l’immagine della chiesa come “Barca di Pietro”.
L’apostolo infatti sottolineava che: «se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il secondo timoniere».
Aggiunge Giordani: “Durante la pandemia da Covid-19, rivolgendosi al mondo costretto ad affrontare con dolore e sacrifici un momento storico così drammatico, il Papa, timoniere della Chiesa, ci aveva fatto sentire costantemente la sua vicinanza attraverso la preghiera, dandoci la certezza che ‘Dio non ci lascia in balia della tempesta’. Ebbene, con questo omaggio al Sommo Pontefice, dopo dieci anni di ministero, abbiamo voluto dare corpo a un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La ‘Barca di Pietro’ che consegniamo non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione”.
Il Papa ha risposto con un sorriso: “La barca di tutti…” e sarà meta di pellegrinaggio, di “nuovi pesci da portare sulla riva del Signore”.







Lago Tiberiade - Mar di Galilea
Il RELITTO originale dell’imbarcazione di Pietro fu ritrovato nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade
Chi scrive, nel 2000 andò con la famiglia in Israele.
Il nostro pellegrinaggio iniziò dal Lago di Tiberiade, dove tutto cominciò…
Giuseppe Flavio (Guerra giudaica, III,7) lo descrisse così:
«Il lago di Gennesar prende il nome dal vicino territorio. Misura 40 stadi in larghezza e 140 in lunghezza. Le sue acque sono dolci ma non buone da bere. Esse sono più leggere della pesante acqua di palude, e limpide perché le sue rive sono formate da ghiaia e sabbia; ha inoltre una temperatura mite: è meno fredda di quella di un fiume o di una sorgente, ma comunque più fresca di quanto si immagini, vista l'estensione del lago. Al centro di esso scorre il Giordano, che sembra nascere dal Panion, mentre in realtà giunge al Panion attraverso un percorso sotterraneo, e nasce invece dal bacino di nome Fiale, che si trova a 120 stadi da Cesarea, sulla destra, non molto distante dalla strada che porta alla Traconitide. [...] Non si sapeva che nascesse dal Giordano fino a quando non fu dimostrato da Filippo, tetrarca della Traconitide. Egli, gettando nella Fiale della paglia, la ritrovò trasportata al Panion, dove nell'Antichità si credeva nascesse il Giordano.
Tra i tanti YouTube che ho visionato, questo che vi propongo in visione è il migliore per chiarezza, bellezza e informazioni culturali geografiche-storiche ed Evangeliche.
Il mare di Galilea chiamato il lago di Gesù
di
Adrea Candore
https://www.youtube.com/watch?v=tUyoB-wObME
Le cartine orientative
Lago di Tiberiade




Il kibbutz di Ginnosar sul lago di Tiberiade e la scoperta della “barca di Gesù”
del prof.Giancarlo Biguzzi
https://www.gliscritti.it/approf/2007/papers/barca_gesu.htm

Il relitto originale, ben conservato grazie al fango del fondale che ricopriva le strutture lignee dello scafo, è stato datato alla seconda metà del I sec. A.C. dall’esame del Carbonio 14. Si tratta quindi di un battello a vela lungo 8,8 metri x 2,5 metri con un albero di 8 metri, risalente con ogni probabilità proprio all’epoca della predicazione di Gesù. L’imbarcazione, particolarmente adatta per la pesca costiera, poteva ospitare quattro rematori e circa una dozzina di persone. È plausibile quindi che il relitto del Lago di Tiberiade appartenga alla medesima tipologia della barca di cui raccontano gli evangelisti Luca (5,1-11) e Marco (4,35-41).
Il prezioso reperto è in mostra al centro Ygal Allon nel museo di Ginosar in Galilea (Israele), un museo che permette ai turisti di osservare da vicino questa semplice imbarcazione datata 40 avanti Cristo grazie a un test a radiocarbonio effettuato alla fine degli anni ottanta quando fu rinvenuta coperta da fango e melma nel lago di Tiberiade.
Gli archeologi riferirono subito che si trattava della tipica imbarcazione che usavano i pescatori ai tempi di San Pietro. Naturalmente non vi erano evidenze di sorta che si trattasse dell'imbarcazione dei Vangeli anche se l'umile costruzione lignea non ne diminuiva il valore archeologico.
CURIOSITA’ TECNICHE DELL’IMBARCAZIONE ORIGINALE
Dal sito: ![]() BibleWalks 500+ sites
BibleWalks 500+ sites
L’imbarcazione è stata datata, con il carbonio 14, intorno al 40 a.C. (più o meno 80 anni), o dal 50 a.C. al 50 d.C. sulla base delle ceramiche (tra cui una pentola ed una lampada) e dei chiodi ritrovati all’interno della barca. Questo fa ipotizzare che l’imbarcazione possa quindi risalire al tempo di Gesù Cristo. In effetti, si adatta alle molte descrizioni di barche delle Sacre Scritture, come quella nel Vangelo di Luca. Lunga 27 piedi e larga 7,5 piedi, la barca era costruita con dieci diversi tipi di legno e doveva consentire la pesca vicino alla riva. La tecnica costruttiva della barca risultò conforme altre barche costruite in quella parte del Mediterraneo tra il 100 a.C. e il 200 d.C. L’imbarcazione era stata costruita principalmente con assi di cedro, unite insieme da giunti e chiodi a mortasa e tenone fissati, adatta a navigare su bassi fondali grazie ad un fondo piatto, che le consentiva di avvicinarsi molto alla riva durante le operazioni di pesca. Gli archeologi hanno scoperto che la barca era stata costruita con dodici diversi tipi di legno, il che suggerisce diverse ipotesi: una carenza di legno o una costruzione in economia, fatta con legni di scarto, oppure che la stessa aveva subito riparazioni estese e ripetute. Delle 113 assi del fasciame della barca, 105 (92%) erano di cedro e uno di pino, entrambe conifere locali. Curioso il fatto che su 60 assi di quercia, 45 (75%) erano costituite da rami non lavorati. L’utilizzo del legno di conifere per le assi e di legno di latifoglie, di solito il rovere, per le intelaiature interne, era una pratica comune ed è seguito anche oggi nella costruzione di barche. Un interessante studio sulle tipologie di legno utilizzate può essere letto su questo sito.
La barca di pescatori era dotata di un albero, e quindi poteva alzare una vela, e aveva posto per quattro rematori sfalsati. Le sue dimensioni avrebbero permesso di trasportare 13 persone … Ovviamente, non c’è modo di sapere se questa particolare barca ebbe realmente un ruolo negli eventi raccontati nella Bibbia ma le sue strutture marinaresche trovano conferma in quanto raccontato nei libri sacri.
LA TEMPESTA SUL LAGO DI TIBERIADE (MARE DI GALILEA)

“Cristo nella tempesta sul mare di Galilea”
Rembrandt
Così si legge nel Vangelo di Matteo
« Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva.Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia.
|
Così si legge nel Vangelo di Marco
È interessante che, pur essendo un lago, l’evangelista Marco preferisca chiamarlo “mare”, a motivo della grandezza e della sua pericolosità, infatti spesso è battuto da venti che rendono difficile la navigazione.
La barca nella tempesta
Il Signore è a poppa, nella parte poppiera della barca, quella che affonda per prima; e dorme appoggiato ad un cuscino (Mc 4,38). La tempesta che incontra la barca non sveglia Gesù, sarà il cuore angosciato dei discepoli a far tremare la barca: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (v. 38). Di questa mancanza di fede è preoccupato Gesù.
Immaginiamo lo scompiglio su quella barca! Ma quale è il vero rischio di perdersi? Gesù non risponde alla domanda dei discepoli, ma, placato il vento e le acque, sarà lui a sollevare la domanda vera: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (v. 40).
Il mare non è una forza autonoma, come non lo è il Male, seppur ha una sua inspiegabile libertà di agire, come ci istruisce il testo “sapienziale” di Giobbe nella prima lettura: “Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso?” (Gb 38,8). C’è un limite invalicabile posto dal Signore, che è creatore e redentore: “Fin qui giungerai e non oltre, e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde” (v. 11).
La fede messa alla “prova” dal mare
L’immagine del mare, da sempre, rappresenta nella Bibbia una prova di fede.
Il popolo d’Israele liberato da Mosè è costretto a fermarsi davanti al Mar Rosso, apparentemente invalicabile. L’esercito egiziano incalza alle spalle ed è ormai vicino: “Non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto”? (Es 14,11). Con queste parole ricolme di angoscia, il popolo si rivolge a Mosè. E lui: “Non abbiate paura! Siate forti. Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli” (v. 13).
HO CHIESTO A DIO: PERCHE' MI HAI PORTATO SULLE ACQUE AGITATE?
MI HA RISPOSTO: PERCHE' I TUOI NEMICI (i demoni) NON SANNO NUOTARE ...
Papa: "siamo tutti sulla stessa barca"
Questo brano ci ricorda il momento straordinario di preghiera indetto da Papa Francesco il 27 marzo 2020, nel contesto della pandemia. Risuonano ancora le sue parole: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”.
Risulta essenziale la presenza del Signore. Con un rischio: che ognuno lo vorrebbe collocato secondo i propri schemi, alla guida, di vedetta, a rassicurare ognuno, ad evitare gli ostacoli… Ma il Signore è invece al suo posto e compie la sua opera. Lo aveva anticipato nelle parabole: il seme una volta gettato, non va perduto. “Dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce” (Mc 4,27).
Su questa barca con Gesù, che è la Chiesa
Con queste parole l’orazionale descrive la “via santa”, una vita non gettata nel nulla, non abbandonata a sè stessa.
Sulla barca della vita permane la presenza silenziosa ma efficace del Signore: “Taci, calmati!” (Mc 4,39). Al momento opportuno il Signore interviene, calma le acque e il vento, come ordina al male di non nuocere più.
Su questa barca, che è la Chiesa, possiamo attraversare sicuri il mare della vita; e la nostra fede, seppur debole e ferita, può ristorarsi alla “fonte” dei sacramenti.
La nostra fede poggia sicura sulla fede di Pietro e della Chiesa di Cristo. Lo ricorda il sacerdote nella celebrazione eucaristica: “Signore, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”.
PERCHE' GESU' SCEGLIE I PESCATORI
Lo spiega Sant’Agostino. Discorso 250
Dio preferisce i deboli e i poveri di questo mondo.
-
Il Signore Gesù ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti 1, sicché, volendo adunare la sua Chiesa da ogni parte del mondo, non cominciò con degli imperatori o senatori ma con dei pescatori. Se infatti fossero stati scelti in principio personaggi altolocati, essi avrebbero attribuito la loro scelta a se stessi e non alla grazia di Dio. Questo modo di procedere di Dio, a noi occulto, questa disposizione del nostro Salvatore ce la espone l'Apostolo quando dice:Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Sono parole dell'Apostolo. Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Poiché non molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti, e le cose ignobili e spregevoli del mondo ha scelto Dio, e le cose che non hanno consistenza - come se la avessero - per annichilire le cose dotate di consistenza; affinché nessun uomo possa vantarsi dinanzi a lui 2. La stessa cosa aveva detto il profeta: Ogni valle sarà colmata, e ogni monte e ogni colle sarà abbassato, perché si ottenga una pianura senza dislivelli 3. Veramente, oggi partecipano della grazia del Signore senza distinzione nobili e plebei, dotti e ignoranti, poveri e ricchi. Quando si tratta di ricevere questa grazia non avanza diritti di precedenza la superbia rispetto all'umiltà di chi nulla sa e nulla possiede 4 e nulla può. Ma cosa disse loro? Venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini 5. Se non ci avessero preceduto quei pescatori, chi sarebbe venuto a pescarci? Al giorno d'oggi uno è gran predicatore se riesce a presentare bene quello che ha scritto il pescatore.
Mescolanza di buoni e cattivi nella Chiesa terrestre
-
Il Signore Gesù Cristo scelse dunque dei pescatori di pesci e ne fece dei pescatori di uomini. Col fatto stesso del pescare poi volle darci degli ammaestramenti nei riguardi della chiamata dei popoli. Notate come le pesche furono due e come occorra distinguerle e separarle. Una fu quando il Signore scelse gli Apostoli e da pescatori li rese suoi discepoli 6; l'altra è quella che abbiamo ascoltato ora quando si leggeva il santo Vangelo, quella cioè che avvenne dopo la resurrezione del Signore Gesù Cristo. L'una dunque prima della resurrezione, l'altra dopo la resurrezione. E dobbiamo sottolineare con molta attenzione la differenza fra le due pesche, poiché questa duplice pesca è una nave piena di istruzioni per noi.
Almeno 4 erano pescatori di mestiere:
Simon Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo…
Non sono menzionati tutti i loro mestieri. Pietro e Andrea erano pescatori, probabilmente anche altri. Matteo era in esattore di tasse, Paolo fabbricava tende per mantenersi quando predicava ma a Gerusalemme era stato educato dal dotto fariseo Gamiliele. Sapeva parlare greco ed ebraico. Nonostante Matteo avesse molta esperienza riguardo il denaro e i numeri, furono affidate a Giuda le finanze e per questo si presume che avesse una certa istruzione. Tutti comunque si mantenevano con il loro lavoro.
Invece gli apostoli non credevano per fede, ma perché avevano incontrato e mangiato insieme a Gesù per 40 giorni dopo la sua morte.
Gesù appare ai pescatori
https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/libri/impariamo-racconti-bibbia/13/gesu-appare-ai-pescatori/
PIETRO Apostolo, santo
TRECCANI
https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-pietro-apostolo_(Enciclopedia-Italiana)/
https://www.culturacattolica.it/cultura/storia/storia-della-chiesa/il-primo-sbarco-dell-apostolo-pietro-in-italia
Tra gli scritti cosiddetti pseudo-clementini (preziosa fonte per gli studiosi dei primi secoli), composti poco dopo il 200 d.C., vi è un’opera denominata Viaggi di Pietro, che era stata adottata dai giudei ebioniti. Gli ebioniti credevano sia nell’ebraismo sia in Gesù come Messia (atteggiamento ancora oggi presente tra le migliaia di ebrei messianici d’Israele), e facevano riferimento ad un vangelo di Matteo rielaborato, ed anche all’opera Viaggi di Pietro. E’ da questo testo che fu attinta l’immagine della Chiesa come “Barca di Pietro”, perché l’apostolo ci teneva a sottolineare che, se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il “secondo timoniere”.
MARINAI E FEDE
https://www.marenostrumrapallo.it/cri/
Carlo GATTI
Rapallo, 26 Giugno 2024
YELLOW SUBMARINE - MARE NOSTRUM RAPALLO
YELLOW SUBMARINE
MARE NOSTRUM
RAPALLO
Navigando nelle Onde del Successo dei Beatles: La Leggenda di Yellow Submarine
Chiunque abbia mai sentito la melodia orecchiabile di "Yellow Submarine" dei Beatles non può negare il suo impatto indelebile nella storia della musica. È come se ogni nota trasportasse l'ascoltatore in un viaggio attraverso mari incantati, portando con sé un carico di gioia e nostalgia. Ma cosa rende questa canzone così speciale? Perché, nonostante gli anni passati dalla sua uscita, continua a far battere il cuore di milioni di persone in tutto il mondo?
Forse parte della magia risiede nel suo messaggio semplice ma potente. "We all live in a yellow submarine" - viviamo tutti in un sottomarino giallo. Le parole, così facili da canticchiare, celano un senso di unità e di comunità. È come se il complesso dei Beatles ci inviti a salire a bordo della loro bizzarra imbarcazione e a immergerci insieme in un'avventura senza tempo.
Ma è la musica o il testo che ha catturato l'immaginazione di così tanti? Forse entrambi. La melodia contagiosa, con il suo ritmo incalzante e le armonie perfettamente intonate, è sicuramente una parte fondamentale dell'attrattiva di "Yellow Submarine". Ma non possiamo ignorare il potere delle parole: il loro senso di giocosità e allegria, unito a una leggera vena di nostalgia, ha reso la canzone un inno generazionale.
Mentre ci immergiamo nelle note contagiose e nelle parole giocose di "Yellow Submarine", possiamo anche riflettere sulle connessioni sorprendenti che questa canzone ha con il mondo marittimo.
E se ci spostiamo dal mondo della musica a quello dell'esplorazione marina, possiamo trovare ancora più connessioni intriganti. Nel 1960, lo stesso anno in cui i Beatles iniziarono a dominare le classifiche musicali, il Batiscafo TRIESTE raggiunse profondità mai esplorate prima nella Fossa delle Marianne.
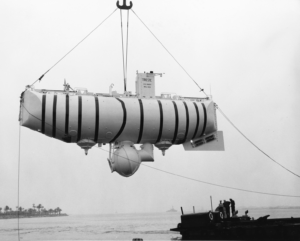
Batiscafo TRIESTE


Yellow Submarine - Museo Oceanografico di Monaco
(foto sopra e sotto)

NOTA TECNICA DELL’EX SOMMOZZATORE DEL CONSUBIN (Comando Subacquei Incursori) della Marina Militare Italiana JOHN GATTI
C'è un motivo specifico per cui molti sottomarini utilizzati per ricerche e scopi scientifici sono dipinti di giallo. Il principale motivo riguarda la visibilità sott'acqua. Il colore giallo è uno dei più visibili e riconoscibili sotto la superficie dell'acqua, specialmente a grandi profondità dove la luce naturale è limitata.
L'acqua assorbe le lunghezze d'onda della luce in modo diverso, facendo sì che alcuni colori diventino meno visibili con l'aumentare della profondità. Il blu e il verde sono meno assorbiti, quindi permangono più a lungo, mentre i rossi scompaiono quasi subito. Il giallo, essendo un colore brillante, ha una migliore visibilità rispetto ad altri colori a profondità moderate, il che rende i sottomarini più facili da individuare durante le immersioni e le operazioni di salvataggio.
Inoltre, questa scelta cromatica aiuta nella differenziazione visiva dei sottomarini destinati alla ricerca da quelli militari, che tendono ad avere colorazioni più scure o mimetiche per ragioni di stealth e sicurezza
E che dire del Batiscafo Yellow Submarine esposto nel Museo Oceanografico di Monaco? Una coincidenza? Forse. O forse un omaggio sottile ai Beatles e alla loro canzone iconica. In fondo, il mare è stato sempre una fonte di ispirazione per l'umanità, un luogo di mistero e meraviglia che abbiamo cercato di esplorare e comprendere.
Infine, c'è qualcosa di poeticamente adatto nel fatto che i Beatles abbiano le loro radici nella città portuale di Liverpool, nota per la sua lunga storia marinara. In un modo o nell'altro, sembra che il richiamo del mare abbia permeato l'anima della band, trovando espressione nelle loro canzoni più celebri.
In un'epoca in cui milioni di canzoni vengono scritte ogni anno, è sorprendente vedere come poche di esse riescano a resistere alla prova del tempo e a diventare veri e propri classici. Ma "Yellow Submarine" è una di quelle canzoni. Con il suo mix irresistibile di melodia orecchiabile, testo incisivo e connessioni marinaresche intriganti, continua a navigare sulle onde del successo, portando con sé un carico di gioia e speranza per le generazioni future.
Allora, salite a bordo e lasciatevi trasportare dalla magia del sottomarino giallo. È un viaggio che non dimenticherete mai.
Navigando sulle Onde del Successo dei Beatles: La Leggenda di Yellow Submarine e i Nuovi Orizzonti di Mare Nostrum
In un momento di transizione e di nuovi orizzonti per l'Associazione Marinara Mare Nostrum, è opportuno riflettere sulla forza e l'incanto di una delle canzoni più iconiche dei Beatles: "Yellow Submarine". Mentre Mare Nostrum si prepara ad accogliere un nuovo Presidente, possiamo guardare a questa canzone non solo come un classico della musica leggera, ma anche come un auspicio di fortuna e successo per la nuova leadership che prenderà il timone.
"Yellow Submarine" è più di una semplice canzone. È un invito a unirsi in un'avventura senza tempo, a esplorare mari sconosciuti e a mantenere viva la fiamma dell'immaginazione. Con il suo messaggio di unità e comunità, la canzone offre una guida preziosa per coloro che si preparano a guidare Mare Nostrum verso nuovi traguardi.

Ed è in questa cornice che l'elezione del nuovo Presidente di Mare Nostrum assume un significato ancora più profondo. Come il Capitano di un'epica nave, il nuovo leader guiderà l'associazione attraverso le acque agitate della sfida e dell'opportunità, portando con sé la speranza di nuove scoperte e di un futuro luminoso.
In un mondo in cui molte canzoni vengono dimenticate nel vortice del tempo, "Yellow Submarine" brilla come un faro di speranza e ispirazione. Che possa portare la stessa fortuna e il medesimo spirito di avventura alla nuova navigazione di Mare Nostrum e alla sua guida.
Quindi, mentre alziamo le vele e ci prepariamo ad affrontare le onde del cambiamento, continuiamo a cantare insieme l'inno del sottomarino giallo. È un viaggio che non dimenticheremo mai.
TRADUZIONE YELLOW SUBMARINE – THE BEATLES
Testo tradotto di Yellow submarine (Lennon, McCartney) dei The Beatles [Parlophone]
In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
Nella città dove sono nato
Viveva un uomo che andava per mare
E ci ha detto della sua vita
Nella terra dei sottomarini
So we sailed up to the sun
‘Til we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine
Quindi abbiamo navigato fino al sole
Finché non abbiamo trovato un mare verde
E abbiamo vissuto sotto le onde
Nel nostro sottomarino giallo
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
And our friends are all aboard
Many more of them live next door
And the band begins to play
E i nostri amici sono tutti a bordo
Molti di più vivono nella porta accanto
E la banda comincia a suonare
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
Full speed ahead, Mr. Boatswain, full speed ahead !
Full speed it is, Sergeant !
Cut the cable, drop the cable !
Aye-aye, sir, aye-aye !
Captain, Captain !
Avanti a tutta velocità, Signor Nostromo, a tutta velocità !
A tutta velocità, Sergente !
Taglia il cavo, lascia cadere il cavo !
Sì-sì, signore, sì-sì !
Capitano, capitano !
As we live a life of ease (a life of ease)
Everyone of us (everyone of us) has all we need
(has all we need)
Sky of blue (sky of blue) and sea of green (sea of green)
In our yellow (in our yellow) submarine (submarine, ah-ha)
E mentre vivevamo una vita di comodità (una vita di comodità)
Ognuno di noi (ognuno di noi) ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno
(ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno)
Il cielo blu (il cielo blue) e il mare verde (il mare verde)
Nel nostro sottomarino (nel nostro sottomarino) giallo (giallo, ah-ha)
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo
Sottomarino giallo, sottomarino giallo
Carlo GATTI
Rapallo, 20 Febbraio 2024
PRIROSCAFO GENOVA - UN RELITTO CHE FA ANCORA DISCUTERE
P.FO GENOVA
UN RELITTO CHE FA ANCORA DISCUTERE

Relitto Bellico N.12 - P.FO GENOVA
Area Marina Protetta
Portofino
La storia attraverso i relitti
L'ubicazione dei relitti intorno all'Area Marina Protetta di Portofino

P.fo GENOVA N.12
La freccia rossa indica la posizione del relitto
Breve estratto dalla A.M.P.P
“Il Promontorio di Portofino, è stato testimone di numerosi avvenimenti storici. Esistono ben poche informazioni su quanto accaduto in epoche remote, molte di più su naufragi ed avvenimenti di epoche più recenti.
Nella cartina sottostante, che può essere compresa anche grazie alla legenda, si è provato a ricostruire la mappa dei relitti e dei residui bellici presenti, di presenza presunta e, in qualche caso rimossi, intorno al promontorio. Oltre a raccontarci quanto avvenne nelle acque dell'Area Marina Protetta di Portofino in epoche remote i relitti, soprattutto quelli più recenti, hanno dato origine ad importanti zone di aggregazione di animali marini. Le lamiere in ferro vengono corrose dall'acqua marina e colonizzate da numerose alghe e invertebrati (spugne, gorgonie e briozoi). Poco dopo divengono rifugio ottimale di pesci anche piuttosto grossi costituendo vere e proprie aree di ripopolamento del mare sfruttate spesso dai pescatori dilettanti”.
1 -- Caracca Santo Spirito 1579
2 – probabile affondamento nave da carico romana (II sec. A. C.)
3 – Schooner (brigantino-goletta) prima metà del 900
4 – Croesus (piroscafo britannico) 1855
5 – Washington (piroscafo britannico da carico) 1917
6 – Ischia (piroscafo italiano da carico) 1943
7 – sottomarino (probabilmente un U Boote tedesco) II° guerra mondiale
8 – Mohawk Deer (nave cisterna canadese) 1967
9 – probabile affondamento nave greca
10 – Motozattera (piccolo naviglio da sbarco) II° guerra mondiale
11 – aereo Handley page Halifax (bombardiere britannico) 1942
12 – Genova (piroscafo italiano da carico) 1917
13 – piccolo naviglio da sbarco tedesco (chiamato anche bettolina) – II° guerra mondiale
14 – probabile affondamento nave militare romana (I° secolo d. C.)
15 – sottomarino tedesco affondato 1945
16 - battaglia navale
17 – ruderi delle batterie antiaeree
18 - pallini gialli - mine rimosse
Questo articolo è dedicato al relitto del piroscafo GENOVA
ed al ricordo del caro AMICO Emilio CARTA

Comparando le strutture emergenti: (poppa, timone, bighi, gruette lancia, ciminiera) del P.fo Genova (sopra) con la foto del P.fo Palmaiola (sotto), vien fatto di pensare che i due piroscafi fossero gemelli. Entrambi erano di proprietà dell’ILVA - nello stesso periodo.
IL PIROSCAFO GENOVA POTEVA AVERE ANCHE QUESTO VOLTO …

Piroscafo PALMAIOLA (coll. Spazzapan)
Piroscafo da carico di 1879,94 tsl, 1079,47 tsn e 3000 tpl, lungo 78,30 metri, largo 13,31 e pescante 5,55, con velocità di dieci nodi. Di proprietà della Società Anonima "Ilva" Alti Forni e Acciaierie d’Italia, con sede a Genova, ed iscritto con matricola 1584 al Compartimento Marittimo di Genova; nominativo di chiamata IBJJ.
Aveva due stive, della capacità complessiva di 4200 metri cubi.
UN PO’ DI STORIA…
Prima guerra mondiale
27 Luglio 1917 - il piroscafo Genova, che trasportava materiale bellico, era partito da Spezia con destinazione Genova e, nonostante il “costoso – nonché - pericoloso carico”, navigava senza scorta militare.
L'imbarcazione, lunga oltre 100 metri, larga 15, 3.600 tonnellate di stazza, fu colpita a proravia nella murata di dritta da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco appostato nel Golfo Tigullio. Il Comandante del Genova fece rotta verso Paraggi nella speranza di andarsi ad arenare su di una morbida spiaggia della baia più bella del mondo; solo in questo modo avrebbe potuto salvare il piroscafo, il prezioso carico e lo stesso equipaggio.
Purtroppo, il tentativo del Comandante di salvare il salvabile riuscì solo in parte. Raggiunta infatti la Baia di Paraggi, il piroscafo italiano fu circondato dalle piccole imbarcazioni dei villeggianti presenti che riuscirono coraggiosamente a mettere in salvo l’equipaggio. Mancò all’appello soltanto Massa Tomaso (Albo Caduti: Marinaio C.R.E.M., nato a Mele, c.p. di Genova).
Il piroscafo GENOVA, sempre più appruato ed ingovernabile, rimase a galla per parecchie ore in balia della corrente che lo spingeva lentamente verso il largo mentre lo scafo continuava ad imbarcare acqua per la falla aperta dal siluro tedesco. La sua tragica corsa finì su un fondale piatto, profondo 60 metri proprio davanti al castello di Paraggi.
Dopo 107 anni di riposo nel cimitero naturale più “ospitale” del mondo, il relitto del Genova giace ancora oggi in perfetto assetto “subacqueo” di navigazione attirando la curiosità di molti esperti subacquei.
Le cronache dell’epoca riportano che nelle lunghe ore in cui il piroscafo era ancora galleggiante e alla deriva: “vi fu una accesa discussione tra le autorità cittadine e il Comandante del GENOVA. Infatti la nave poteva essere recuperata soltanto se rimorchiata in porto. Tale operazione fu ostacolata per paura della natura del carico che avrebbe potuto, esplodendo, provocare danni ben maggiori. L’affondamento risolse la diatriba”.
Come si è appena detto, il piroscafo imbarcava mare da una falla importante nell' "opera viva" dello scafo. Tuttavia, il Comandante, conoscendo la sua nave meglio di tanti esperti presenti, contava sulla capacità di resistenza del suo piroscafo e “percepiva da marinaio esperto” d’avere il tempo sufficiente per dirigerlo a rimorchio verso il porto più vicino.
Purtroppo, visto lo sbandamento lento e progressivo del piroscafo, l'idea del Comandante non era condivisa dalle Autorità accorse nel frattempo le quali, da un momento all’altro, s’aspettavano d’assistere al più tragico spettacolo che possa offrire il mondo misterioso del mare: il naufragio!
Così ce lo racconta il compianto Emilio Carta nel primo libro della sua preziosa trilogia:
NAVI E RELITTI DI LIGURIA
RELITTI DA MONTECARLO A SPEZIA
“Prima di colare a picco la nave restò a galla per oltre otto ore e l’Autorità Marittima di allora aprì un’inchiesta per chiarire i motivi per cui non vennero chiamati per tempo i rimorchiatori per trainarla nel vicino porto di Santa Margherita Ligure e salvare così la nave ed il suo prezioso carico. Lo scafo si posò sul fondo in perfetto assetto di navigazione e negli anni successivi una ditta specializzata recuperò quasi interamente il carico del “vapore” come i pescatori locali chiamano affettuosamente ancora oggi la nave che si presenta pressoché intatta nella sua struttura metallica”.
IL KILLER del P.fo Genova
Il sottomarino tedesco U-BOOT U-35
Come abbiamo appena visto, il piroscafo Genova venne silurato il 17 luglio 1917. La nave che trasportava cannoni e munizioni, fu colpita da un siluro lanciato da un sommergibile tedesco mentre era in navigazione da Spezia a Genova.

Gli U-Boot U-52 e U-35 – Foto scattata nel 1916
The German submarines SM U 52 (right) and SM U 35 (left) meeting in the Mediterranean

ALBUM FOTOGRAFICO
Le splendide foto sono state “rubate” dalla meravigliosa collezione della:
PORTOFINO DIVERS ed ogni commento ci sembra superfluo!

L’enorme falla è ancora nettamente visibile nella ”opera viva” dello scafo


Cime impigliate sul ponte

Il fumaiolo

Reti da pesca

Uno scorfano sulla poppa
CIRCOSTANZE DIVERSE - STESSA PAURA!
40 anni dopo …
CITY OF FUNCHAL, L'IDROVOLANTE CHE SPIAGGIÒ A SANTA MARGHERITA LIG.
LINK
https://www.marenostrumrapallo.it/city-of-funchal-lidrovolante-che-spiaggio-a-santa-margherita-ligure/

Nel 1956, in seguito allo spiaggiamento dell’idrovolante CITY OF FUNCHAL a Santa Margherita Ligure, i giornali dell’epoca riportarono che la gente, temendo l’esplosione dei serbatoi carichi di carburante, fuggì dalle case lasciando le finestre aperte e corse a ripararsi lontano dalla zona, come ai tempi della guerra.
Carlo GATTI
Rapallo, 15 Gennaio 2024
ROSTRO E CORVO ROMANO - DUE ARMI VINCENTI
ROSTRO E CORVO ROMANO
DUE ARMI VINCENTI

IL ROSTRO. Consisteva in un poderoso sperone in bronzo collocato nel punto di congiunzione tra la parte finale prodiera della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua (elemento strutturale di congiunzione che chiude lo scafo alle sue estremità, sia anteriore che posteriore. Il rostro veniva agganciato alla parte lignea dello scafo, mediante numerosi chiodi. Era composto da una struttura laminare che foderava, proteggendole, le parti lignee dello scafo sulle quali veniva agganciato, ma la sua parte più anteriore terminava con un possente fendente verticale (sperone), a volte rafforzato da ben tre fendenti laminari orizzontali (vedi nella foto sottostante il particolare del bellissimo rostro recuperato a settembre 2008 al largo di Messina).


IL ROSTRO DI ACQUALADRONI, DOTAZIONE MICIDIALE DELLE NAVI ROMANI
L’8 settembre del 2008 fu rinvenuto, giacente a bassissima profondità nelle acque di Acqualadroni, vicino Messina, un antico rostro bronzeo romano.
La scoperta del ROSTRO, di cui se ne intravedeva solo la parte superiore, fu del tutto eccezionale, sia per la rarità dei rostri ritrovati in situ (altri simili erano stati rinvenuti nelle acque delle Isole Egadi e in Israele), sia perché se esso conserva ancora integri frammenti della parte lignea.
Il rostro, inserito nella chiglia all’altezza dritto di prua ed assicurato mediante chiodi, era costituito da tre fendenti laminari orizzontali rinforzati da un possente fendente verticale. Con questo micidiale multiplo fendente, scagliato con forza sulle fiancate delle navi nemiche, la nave da guerra che ne era dotata determinava l’ingovernabilità e l’affondamento di quella nemica grazie alle falle che generava.
Il reperto, integro e di eccellente fattura, è decorato lateralmente sui due lati. Si distinguono alcuni particolari quali teste di aquile, criniere, creste e collari (caratteristiche decorative di tradizione ellenistica presenti fino alla fine del I sec. a.C.)
Dalle analisi effettuate sul rostro si è appurato che il manufatto risalirebbe al periodo compreso tra il 360 ed il 190 a.C.. Quanto all’evento in cui la nave sarebbe affondata, vi sono diverse ipotesi: si è pensato che il rostro potesse appartenere a una delle navi delle flotte della prima (264-241 a.C.) o della seconda (218-201 a.C.) guerra punica, o a una delle numerosissime battaglie intermedie, o alla battaglia del Nauloco (36 a.C.) combattuta tra Marco Vipsanio Agrippa (ammiraglio di Ottaviano) e Sesto Pompeo.
Il reperto si trova oggi al Museo regionale di Messina.





Dal sito: ARCHEOLOGIADELPASSATO
Agosto 27, 2023
Levanzo (Tp). Nuovi ritrovamenti archeologici nei fondali, sito della Battaglia delle Egadi: recuperati altri due rostri in bronzo. Sono l’Egadi 26 e l’Egadi 27. E poi 15 elmi, 20 paragnatidi, una spada e, per la prima volta, 7 monete d’argento.

Egadi 27: è il 27° rostro in bronzo nei fondali di Levanzo (Tp) sito della battaglia delle Egadi del 241 a.C. (foto regione siciliana)
E sono 27! Parliamo dei rostri recuperati nei fondali di Levanzo (Trapani), sito della Battaglia delle Egadi. Sono passati quasi 20 anni, da quel lontano 2004, quando la “scoperta” del primo rostro delle Egadi nello studio di un dentista trapanese ad opera del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri confermò al compianto Sebastiano Tusa che il luogo di rinvenimento, a poche miglia a Nord-Ovest del Capo Grosso di Levanzo, doveva essere proprio il teatro dello storico scontro navale delle Egadi tra la flotta cartaginese e quella romana che nel 241 a.C. segnò la fine alla prima guerra punica.
(vedi: Recuperato nel mare di Levanzo il dodicesimo rostro che conferma l’ubicazione della battaglia delle Egadi del 241 a.C. tra romani e cartaginesi, che pose fine alla prima guerra punica a favore dei romani | archeologiavocidalpassato).

Area della battaglia delle isole Egadi tra romani e cartaginesi nel 241 a.C.

L’archeologo Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo nel marzo 2018
“I fondali delle Egadi”, dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, “si confermano ancora una volta uno scrigno prezioso di informazioni per comprendere lo scontro navale tra romani e cartaginesi. La scoperta di Sebastiano Tusa continua ancora oggi a ricevere conferme sempre più importanti, avvalorando l’intuizione dell’archeologo prematuramente scomparso nel 2019 che aveva consentito l’individuazione del teatro della battaglia che sancì il dominio dei Romani sul Mediterraneo”.

Egadi 26: è il 26° rostro in bronzo nei fondali di Levanzo (Tp) sito della battaglia delle Egadi del 241 a.C. (foto regione siciliana)
La campagna di ricerche che si sta svolgendo in questi giorni – come comunica la soprintendenza del Mare – ha consentito il recupero di due rostri in bronzo denominati “Egadi 26” e “Egadi 27”. Sono stati individuati su un fondale di circa 80 metri e recuperati con l’ausilio della nave da ricerca “Hercules” della fondazione statunitense RPM Nautical Foundation che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l’individuazione e il recupero di numerosi reperti riguardanti l’importante battaglia svoltasi il 10 marzo del 241 a.C.
In genere il ROSTRO era costituito da un unico pezzo fuso in bronzo inserito nel punto di congiunzione tra la parte finale prodiera della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua, sopra il tagliamare. La parte anteriore del rostro era costituita da un potente fendente verticale rafforzato da fendenti laminari orizzontali.
Con questo micidiale strumento le navi venivano lanciate alla maggiore velocità possibile contro le fiancate delle unità nemiche per creare delle falle allo scopo di provocare un rapido affondamento.
In tempi antichi le navi, tipicamente TRIREMI, avevano sulla prua una struttura rinforzata detta ROSTRO, col quale potevano sfondare la fiancata della nave nemica, e quindi (essendo sconosciuto l'uso dei compartimenti stagni) causarne l'affondamento.
IL CORVO ROMANO

I Romani (valorosi e abili soldati, ma meno che mediocri marinai di fronte ai Cartaginesi) decisero le sorti e la vittoria definitiva della loro Patria mediante l'abbordaggio; con questa tattica, trasformavano le piattaforme delle navi, saldamente unite mediante i CORVI in un ristretto e stabile campo di battaglia. In tal modo non era necessario manovrare in maniera accurata per scontrare la nave nemica nel bordo, ma era sufficiente riuscire ad affiancarla.

In primo piano a destra si vede il CORVO con il suo potente uncino di ferro che sta per essere abbattuto sulla nave nemica onde stabilire una testa di ponte su cui sbarcare i soldati romani.
Il CORVO era un’arma tattica militare romana utilizzata durante la Prima Guerra Punica. Era essenzialmente un ponte mobile con un'ala affilata che poteva essere abbassata sui ponti delle navi nemiche durante gli scontri navali. Questo permetteva ai soldati romani di abbordare le navi nemiche e combattere come se fossero sulla terraferma. Questa invenzione conferì un vantaggio significativo a Roma nelle battaglie navali.
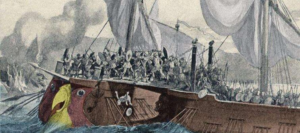
In questa immagine si nota che nella battaglia in corso, il CORVO è stato appena abbattuto. A questo punto il combattimento tra le parti assume un carattere più terrestre che navale in cui i Romani sono storicamente più forti.
Le navi da guerra romane erano: la Bireme, la Triremi, la Quadriremi, la Quinquiremi, la Esareme, la Deceris, l'Actuaria, la Liburna, la Caudicaria.
Per fare un esempio: Si chiamava TRIREMI perchè disponeva di tre serie di rematori, dotata di un ROSTRO per speronare e di CORVI mobili per agganciare le unità avversarie.
UN PO' DI STORIA
Nave da guerra romana
Come erano fatte le navi da guerra della flotta romana? Per rispondere a questa domanda bisogna in realtà tornare indietro e andare a vedere come erano costruite le navi greche che avevano dominato il mare fino ad allora ed erano cresciute in dimensioni e numero di rematori nell’epoca ellenistica.
Le antenate delle navi da guerra romane: le navi greche
Caratteristiche delle navi antiche
Forma elegante e allungata per fendere meglio l’acqua, con alta poppa e prua affusolata per l’alloggiamento del rostro.
Doppio timone, costituito da due “remi” con pale di grandi dimensioni che venivano mossi dal timoniere per cambiare la direzione di navigazione; il timone unico in uso ancora oggi è un’invenzione medievale.
Vela quadra issata sull’albero maestro e sostenuta da sartie e stralli. Nelle navi di maggiori dimensioni poteva essere presente un secondo albero, verso prua, con una vela rettangolare più piccola.
ROSTRO (sperone), agganciato alla chiglia a prua e in metallo. Lo scopo principale di questo elemento era speronare le navi avversarie e spesso era modellato a forma di animali, come il cinghiale.
Castello di prua e/o di poppa, una sovrastruttura leggera posta al di sopra degli scalmi a prua e/o a poppa.
Tipi di navi da guerra greche
La prima antenata delle navi da guerra romane è la greca pentacontera (in uso fino al VI secolo a.C.). Si tratta di un’imbarcazione da 50 rematori (25 per lato) con forma tondeggiante e propulsione sia a remi che a vela, utilizzata come nave da guerra, ma spesso anche per il trasporto di merci.
Evoluzione della pentecontere (iniziata nel VI secolo a.C.) furono le biremi, ma soprattutto le triremi.
Le biremi erano navi utilizzate dall’età classica, con una doppia fila di rematori seduti sullo stesso ponte. La lunghezza variava dai 24-25 m del periodo più antico ai 20 m dei tempi più recenti, quando diventarono più snelle e più facilmente manovrabili.
Le triremi presentavano una terza fila di rematori sistemati in modo sfalsato e seduti nella parte superiore della nave in ponti laterali aggettanti. Potevano arrivare ai 35-40 m di lunghezza e furono utilizzata nelle battaglie navali di epoca classica ed ellenistica. In questa tipologia di nave antica il numero di individui presenti a bordo aumentava notevolmente: oltre ai rematori, più numerosi rispetto a quelli di una bireme, e all’equipaggio addetto al comando e alla navigazione, ospitava anche soldati e arcieri preparati al combattimento nel caso di abbordaggio.
Su questa antica nave da guerra era presente anche un “ponte”, una sorta di passerella centrale che univa le piattaforme a prua e a poppa al fine di permettere un agile movimento a bordo.
L’epoca ellenistica è il periodo dei “colossi del mare”, poiché le fonti ci tramandano della presenza di navi dalle quattro, alle sedici file di rematori. In generale le navi di questo periodo aumentarono in dimensioni, tonnellaggio e ospitarono un numero maggiore di rematori e membri dell’equipaggio. Il problema principale delle navi militari ellenistiche fu proprio la maggiore dimensione degli scafi, che resero le manovre in battaglia sempre più complesse. Non bisogna dimenticare che fino a questo periodo le battaglie navali si combattevano speronandosi a vicenda.
Le navi da guerra romane
Roma costruì la sua flotta in piena epoca ellenistica prendendo spunto dalle grandi flotta dell’epoca. Il primo nucleo della flotta era composto da: liburne (navi leggere con due ordini di rematori e un rematore per remo, adatte ai movimenti veloci), triremi, quadriremi e quinqueremi (navi pontate con trenta remi in linea per fiancata e cinque uomini su ciascun remo), che avevano il grande difetto di essere pesanti e complicate da manovrare.
Nonostante ciò, la preferenza romana per imbarcazioni pesanti ha una spiegazione nel cambiamento di tecnica di combattimento: i romani, forti nel combattimento a terra, preferirono puntare sull’abbordaggio delle navi nemiche inventando una sorta di passerella, detta CORVUS, che permetteva di attaccarsi alle navi nemiche e farci salire i legionari.
L’utilizzo di navi a più file di rematori finirà al tramontare dell’epoca ellenistica. Nel 31 a.C. durante la battaglia di Azio Ottaviano, futuro Augusto, schiererà navi più leggere e facilmente manovrabili (triremi, quadriremi e quinqueremi), mentre Marco Antonio utilizzerà i vecchi e pesanti “colossi del mare” che facevano parte della flotta egiziana.
Fonte: AMICI DELLA SCIENZA- Storia tra le pagine
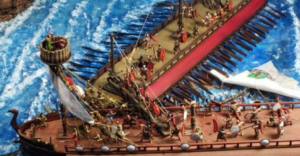
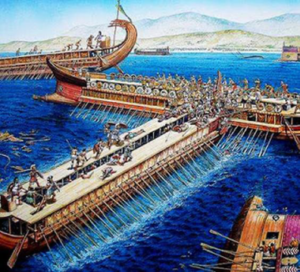
Il CORVO, come appare dalle immagini (sopra riportate), era un grosso pennone cilindrico montato sulla parte prodiera della nave. Da questo pennone, attraverso un sistema di cime, si poteva calare una passerella di legno solida e stabile dotata di ringhiere. Sulla estremità della passerella, un uncino di ferro ricurvo aveva il compito di precipitare al momento giusto sul piano della coperta e ancorarsi alla nave avversaria formando con essa uno scafo unico un po’ asimmetrico. Quando si voleva far entrare in azione il Corvo, bastava eseguire un rapido scatto attraverso le corde e la passerella cadeva violentemente sulla nave avversaria, che veniva letteralmente infilzata, trafitta e trattenuta.
In questo modo, i soldati di fanteria presenti sulla nave romana potevano utilizzare la passerella per abbordare la nave del nemico e trasformare il combattimento da marittimo a terrestre, dove i legionari eccellevano particolarmente.
Secondo lo storico greco Polibio, il corvo era costituito da: un palo cilindrico posto a prua della nave, avente una lunghezza di quattro orgyie * e un diametro di tre palmi. Qui veniva inchiodata una scala a tavole trasversali larga quattro piedi e lunga sei orgyie. La scala aveva ai lati un parapetto alto fino al ginocchio. Sulla punta era installato una sorta di pestello di ferro appuntito con un anello in cima, sicché l'insieme sembrava del tutto simile ai macchinari per la preparazione del pane. Una corda attaccata all'anello permetteva di sollevare il corvo che, se lasciato cadere, si piantava sul tavolato della nave avversaria rendendo impossibile la separazione delle navi.
*L'orgyia (in greco antico: ὀργυιά) era un'unità di misura di lunghezza in uso nell'antica Grecia e nell'antico Egitto equivalente a circa 177,6 centimetri,
Nell'antica Roma un palmo era pari a 1 / 4 di piede, e quindi misurava 7,41 centimetri.
Il Pes romano (piede) equivaleva a circa 30 cm ed è la base delle misure di lunghezza.
In altre parole il corvo era una passerella che fissata alla nave avversaria, permetteva a soldati abituati a combattere sulla terraferma di passare da una nave all'altra senza evoluzioni sulle funi e quindi di combattere come erano addestrati a fare. Se le navi restavano accostate ai fianchi l'abbordaggio era generale, se invece si attaccava la prua, il corvo permetteva l'attacco dei fanti su due file. I primi assaltatori riparavano loro stessi e i compagni tenendo gli scudi davanti a loro, quelli che seguivano, sempre con gli scudi, proteggevano i fianchi.
LA SVOLTA
LA BATTAGLIA DI MILAZZO 260 a.C.
La battaglia navale tra la flotta dei romani guidata da Gaio Duilio e le forze cartaginesi guidate Annibale Giscone, entrò nella storia soprattutto per l’utilizzo di un apparato di nuova concezione che abbiamo già descritto, il CORVO, che permise ai Romani di abbordare le navi avversarie e di capovolgere, come vedremo, una situazione storica a loro sfavorevole.
Milazzo è certamente uno dei massimi esempi dell’ingegno romano, sfoderato di fronte a grandi sfide di natura militare, ma soprattutto rappresenta la prima grande vittoria marittima romana contro i cartaginesi nell’ambito della prima guerra punica.
Messina rinunciò all'indipendenza chiedendo di essere protetta contro i nemici dalla superiore Forza Militare Romana. Ora Roma aveva il "diritto" di stare in Sicilia. Finalmente aveva il Iustum Bellum.
Gaio Duilio si recò personalmente al comando della flotta, settore più debole, lasciando ai tribuni la gestione delle truppe e delle operazioni a terra, settore bellico a cui le legioni erano già addestrate e da secoli vittoriose.
Le truppe cartaginesi stavano saccheggiando la zona attorno a Milazzo; Gaio Duilio diresse la flotta romana verso la città e Annibale Giscone, informato di questo spostamento del teatro delle operazioni, salpò da Palermo al comando di una flotta di 130 navi e, convinto dal risultato della battaglia di Lipari, della sua superiore capacità operativa, incrociò la flotta nemica nel golfo di Milazzo.
I Cartaginesi, sbalorditi furono in parte massacrati e in parte si arresero. 30 navi, le prime che erano entrate in battaglia furono catturate e con queste anche la nave di Annibale che però riuscì a sfuggire alla cattura su una scialuppa.
Il resto della flotta punica cercò di manovrare per evitare l'aggancio dei corvi, tentando di trarre vantaggio dalla migliore qualità delle navi ed esperienza degli equipaggi.
«Confidando nella loro velocità speravano di portare gli assalti a colpo sicuro, gli uni dai fianchi, gli altri da poppa.»
I corvi però, essendo imperniati verticalmente, potevano essere diretti quasi in ogni direzione e le navi cartaginesi finivano regolarmente immobilizzate, assaltate e catturate. Alla fine cinquanta navi puniche restarono nelle mani dei Romani e le altre, virarono di bordo e fuggirono. La battaglia di Milazzo aveva segnato l'ingresso di Roma nel Mediterraneo.
I Cartaginesi, vedendo i corvi sulle tolde delle navi nemiche,
«...restarono incerti, stupiti dal modo in cui gli attrezzi erano congegnati; tuttavia, avendo una pessima opinione dei nemici, quelli che navigavano davanti a tutti si gettarono audacemente all'attacco.»
(Polibio, Storie, I, 23, BUR. Milano, 2001. trad.: M. Mari.)
La flotta romana, lasciata la Sicilia, aveva battuto i Cartaginesi a Capo Ermeo, catturando ben 144 delle 200 navi puniche e le aveva integrate nella sua flotta che quindi era arrivata a quasi 500 navi.
Per chi desiderasse approfondire l’argomento segnalo il seguente LINK:
La flotta da guerra romana e le navi di supporto
https://www.capitolivm.it/societa-romana/la-flotta-da-guerra-e-navi-di-supporto/
Le guerre puniche prenderanno da questo momento una rotta completamente differente: di lì a poco, nella battaglia di Capo Ecnomo, la più grande battaglia navale del mondo antico, i romani ottennero un’altra straordinaria vittoria, utilizzando nuovamente il corvo.
IL TRAMONTO DEL CORVO ROMANO
Nonostante il grande servizio reso a Roma, il corvo venne abbandonato dopo alcuni anni. Gli storici antichi spiegano la breve esistenza del CORVO ROMANO ch fu penalizzata dalla la sua stessa ingombrante struttura.
Osserviamo inoltre che:
-
Per bilanciare il suo peso a prora era necessario zavorrare la nave a poppa
-
Ma in questo modo la nave aumentava di peso perdendo velocità e manovrabilità essendo la forza applicata sui remi rimasta invariata.
-
Anche il fattore SORPRESA era ovviamente venuto meno dopo le prime vittorie …
Infine, secondo le cronache del tempo, si verificarono almeno tre tempeste durante le quali le navi romane affondarono rapidamente, senza riuscire a salvarsi, proprio per il peso del CORVO.
Per questo motivo, sembra che già nella battaglia delle Isole Egadi del 241 a.C, (lo scontro decisivo della prima guerra punica), questo strumento non fosse più in dotazione alla flotta romana.
CONCLUSIONE
Anche se non esiste una connessione diretta tra il CORVO romano e i mezzi da sbarco utilizzati durante lo Sbarco in Normandia (Operazione Overlord) durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambi i concetti condividono l'obiettivo di facilitare lo sbarco di truppe e armi ostili sul territorio nemico, anche se le tecnologie e le tattiche erano ovviamente diverse.
Carlo GATTI
Rapallo 22 Settembre 2022
NAVE ROMANA 180 d.C. RECUPERATA A Leidsche Rijn De Meern - UTRECHT (Paesi Bassi)
NAVE ROMANA (180 d.C.) RECUPERATA
Leidsche Rijn De Meern - UTRECHT (Paesi Bassi)
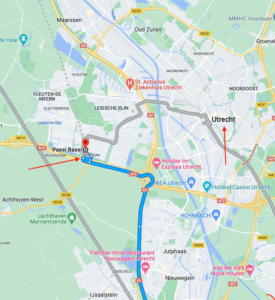

Ipotetica ricostruzione della nave DE MEERN 1
In navigazione sul fiume
COME FU SCOPERTA CASUALMENTE UNA NAVE ROMANA NEI PAESI BASSI

Guardando il reperto da 5 metri d’altezza, i visitatori sono affascinati dal vecchio “legno” sottostante

La prora della nave



È stata semplicemente una scoperta casuale. Mentre scavavano una futura cava per Veldhuizen, una grande nuova area edilizia (parte dello sviluppo di Leidse Rijn), un escavatore ha colpito qualcosa di solido nell'argilla. In realtà, c'era in corso una vera e propria ricerca archeologica nelle vicinanze, alla ricerca della Strada Romana, che si sapeva essere passata sulla sponda meridionale del Basso Reno. Parte di quella strada, (con il ghiaia dell'agger) ancora nella posizione conosciuta, era stata appena scoperta quando si verificò casualmente la scoperta del relitto di una imbarcazione fluviale romana.
LA NAVE
Lo sviluppo di case destinato a circa 30.000 persone a ovest di Utrecht era ovviamente una grande opportunità per gli archeologi, che speravano in diverse scoperte. Il forte romano di De Meern era noto da tempo, ma la scoperta di una grande arteria romana teneva tutti con il fiato sospeso. E molte cose furono scoperte: ulteriori tracce di quella strada, un ponte, un molo e infine una torre di avvistamento, che era una novità.
Poi, nel 1997, è avvenuta la scoperta casuale, che ha portato alla scoperta della nave. Circolano due storie su quella scoperta. La prima racconta di un escavatore che colpisce un legno particolare durante la ricerca della strada romana. Nella seconda si dice che l'archeologo Hans Joosten sente per caso un compagno di viaggio sul treno che racconta di un misterioso legno trovato in una fossa creata per le fondamenta. In entrambi i casi, gli archeologi furono allertati e si precipitarono sul posto.
Pensando alla presenza di altri moli, rimasero molto sorpresi quando scoprirono di trovarsi dinanzi ad un relitto in condizioni perfette. Quando le 6 navi di Zwammerdam furono trovate nel XX secolo, si scoprì che erano state deliberatamente affondate per rafforzare la riva. Questa, invece, era ancora intatta, tanto è vero che è stato persino ritrovato un baule degli attrezzi con il suo contenuto! Doveva essere affondata per un incidente di navigazione piuttosto che per un progetto di rifacimento di un argine simile quello appena descritto. Tuttavia, fu presa la decisione di coprirla nuovamente. Perché? Semplicemente per raccogliere fondi in modo che l’escavazione subacquea potesse essere effettuata correttamente. Tuttavia, nel 2000 si scoprì che il letto antico del fiume portava ancora acqua con troppo ossigeno. Di conseguenza, la nave avrebbe iniziato a marcire…, il che significava che l'escavazione avrebbe dovuto iniziare molto prima. A marzo di quest'anno, lo scavo è iniziato e una grande fossa è stata scavata per rivelare la nave. Entro il 12 giugno verrà sollevata e trasportata a Lelystad, dove un bagno di etilenglicole la conserverà per le generazioni future.
Questa è circa la 15ª nave romana trovata nei Paesi Bassi e si tratta finora della “migliore”.
LA DATAZIONE
La nave DE MEERN 1 è stata datata approssimativamente intorno al 180 d.C.
Questa datazione si è rivelata corretta, poiché è stata confermata poco prima che la nave venisse sollevata dal fango, mentre era in corso l'ultima fase di conservazione. Si sapeva già che la nave era affondata proprio accanto alla strada romana, che era nota per essere stata costruita nel 125 d.C. e che fu terminata nel 225 d.C., quando questa regione del Reno inferiore non era più navigabile. Una moneta di bronzo si è rivelata troppo logora per riconoscere l'Imperatore, e una fibula di bronzo e la forma della nave non hanno fornito possibili date. Altre indicazioni provenivano dal legno con cui la nave era stata costruita. Si è scoperto che per costruire la nave erano stati utilizzati 3 alberi di quercia locali di almeno 40 metri ciascuno e che furono abbattuti tra il 142 e il 154 d.C. Gli indizi provenivano dalla cucina.
Una tegola usata come piastra calda, con l'iscrizione VEXEXGERINF (Vexillatio Exercitus Germanici Inferioris), riferendosi a un'unità militare locale che poteva essere datata solo al 140-180 d.C., mentre una delle tre tazze trovate poteva essere stata fabbricata solo dopo il 175 d.C. Quindi, la nave deve essere affondata intorno al 180 d.C.! Quando i resti sono stati esaminati più attentamente, il momento della sua fine è stato esteso a un periodo tra il 180 e il 200 d.C., in base alle scarpe e ai sandali che l'equipaggio indossava al momento del naufragio.
NEI DINTORNI ……
DE MEERN un villaggio urbanizzato nella provincia olandese di Utrecht. Fa parte del comune di Utrecht e si trova a 6 km a ovest del centro della città. Prima del 2001 i villaggi De Meern, Vleuten e Haarzuilens formavano un comune chiamato Vleuten-De Meern. Il 1° gennaio 2001 è stata incorporata nel comune di Utrecht.
CASTELLUM
Ricostruzione dell’antica Torre Romana d’avvistamento

LA TORRE DI AVVISTAMENTO ROMANA
Poco tempo dopo la scoperta della nave, sono state trovate le fondamenta di una torre di avvistamento nelle vicinanze di Vleuterweide. Anche questa è stata una sorta di sorpresa, perché non ci si aspettava la presenza di torri di avvistamento sul Basso Reno. Oggi sembra agli studiosi che la linea del fiume fosse molto più pesantemente sorvegliata di quanto si fosse finora supposto, con torri di avvistamento a intervalli regolari a vista l'una dell'altra (circa 1,5 km). Segnali di fuoco o fumo potevano avvisare i guardiani della torre successiva, in modo che un allarme potesse essere trasmesso lungo la linea alla fortezza più vicina in un tempo relativamente breve.
Le torri sorvegliavano non solo il fronte fluviale, che potrebbe non essere stato il vero confine (i confini romani non erano mai linee statiche), ma anche la strada, che era importante quanto il fiume come mezzo di trasporto e comunicazione. Questa torre è stata la prima trovata nell'ovest dei Paesi Bass

De Meern si trova nella regione di un ramo scomparso del fiume Reno. Questo ramo del fiume fungeva da confine settentrionale dell'Impero Romano. Sulla sponda del fiume l'esercito romano costruì un accampamento murato, un cosiddetto CASTELLUM. Ciò accadde nel primo secolo dopo Cristo. Anche in altri luoghi nei Paesi Bassi sono state costruite la castella. Il Castellum di De Meern è unico per via del Museo Hoge Woerd con numerosi reperti archeologici rinvenuti nel suolo di De Meern. Questo museo è ospitato in una versione ricostruita del castellum nello stesso luogo dell'ex vero castellum.
All'interno del museo è possibile ammirare La nave romana completa. Questa nave è stata scavata nel 1997 quando è stata preparata una nuova area residenziale a De Meern. È stato trovato sottoterra, sul fondo dell'ex fiume Reno. Dopo un lungo processo di conservazione per prevenire l'ossidazione, la nave è stata spostata nel nuovo Museum Hoge Woerd.
Adress and visitor information
Roman Castellum Hoge Woerd
Address: Hoge Woerdplein 1
Postal code and City: 3454 PB De Meern
Province/Region: Utrecht
Email: info@castellumhogewoerd.nl
Web: castellumhogewoerd.nl
Visit: An average visits takes approx. 1 hours.
Navigation: Groenedijk 1a De Meern.
At the time of writing, the castellum can be visited free of charge from Tuesday to Sunday. Consult the website for more information.
ALBUM FOTOGRAFICO

Vista dall’alto
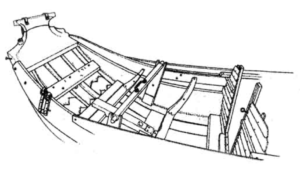
La poppa
Utensili vari in mostra nel Museo

Due anelli (golfari) per ormeggio sul lato sinistro
Nell’attrezzatura navale, qualunque anello metallico fisso, solidamente fermato ai macchinarî, ai ponti, ecc. per agganciarvi i paranchi, le pastecche di rinvio dei cavi sotto sforzo, o per fissarvi le bozze dei cavi di ormeggio e delle catene delle ancore.
Tra I vari reperti ritrovati riportiamo alcune immagini: punta di diamante, una chiave, forbici, mulino a mano, scarpa militare, una moneta, un’ascia, uno stilo, spilla di sicurezza (fibbia), un remo, due bastoni di uso sconosciuto, uno scalpello…
La nave stessa era fatta di grandi tavole di quercia, che erano tenute insieme da unghie di ferro. La chiglia era piatta per ormeggiare sulle rive del fiume.


Tavole di quercia

Punta di diamante (primo piano) e una chiave in secondo piano a ds.

Forbici

Mulino a Mano

In uso ancora oggi, ll Mezzo Marinaio è una lunga asta di legno, di alluminio o di una lega leggera che alla sua estremità ha un uncino. Il suo scopo principale è quello di recuperare o passare le cime di ormeggio e per avvicinare o allontanare l'unità navale all'ormeggio/approdo.
UN PO’ DI GEOGRAFIA
UTRECHT

I Romani sono qui …


Il centro urbano di Utrecht si estende intorno al nucleo centrale e più antico della città. Nel cuore del centro svetta la Torre del Duomo di Utrecht: con i suoi 112,32 m di altezza è la torre campanaria più alta dell'intero paese. Da esso, nelle giornate di bel tempo, è possibile vedere Amsterdam (che si trova a 35 km a nord). La maggior parte degli edifici del centro risale all'epoca d'oro dei Paesi Bassi, ovvero al XVI e XVII secolo, quando questi erano una grande potenza coloniale. Di conseguenza, il centro della città appare a tutt'oggi elegante con abitazioni ed edifici raffinati e riccamente decorati. La città è attraversata da diversi canali: tra i più pittoreschi si distinguono l’Oudegracht (Canale Vecchio) ed il Nieuwegracht (Canale Nuovo). Nelle giornate di sole, i bar, i ristoranti ed i negozi che si affacciano sull'Oudegracht sono affollati.
CATTEDRALE DI SAN MARTINO DI TOURS

Cattedrale di San Martino
cattedrale cattolica dell'arcidiocesi di Utrticaecht fino al 1580, poi passata al culto protestante. Rappresenta uno dei migliori esempi dell'archittetura gotica dei Paesi Bassi, costruita in uno stile di diretta derivazione francese. La sua torre, con i suoi 112,32 metri d'altezza, è il campanile più alto del paese e il simbolo stesso della città.
Origini
Il Clero Franco eresse una prima cappella sul luogo, già dedicata a san Martino di Tours, intorno al 630, con il patrocinio dei re merovingi. Questo edificio tuttavia venne distrutto poco tempo dopo da un attacco dei Frisoni. San Villibrordo, detto l'Apostolo della Frisia, eresse una nuova cappella sul luogo, che venne a sua volta distrutta da una delle numerose incursioni normanne nel IX secolo. Il secolo successivo il vescovo Balderico ricostruì nuovamente l'edificio, che divenne la chiesa principale del luogo, retto da un capitolo di canonici a cui fu concesso nel 999 dall'imperatore Ottone III del Sacro Romano Impero il diritto di commerciare birra gruit.
Il duomo di Adalboldo
Successivamente la chiesa venne più volte distrutta da incendi e in seguito sempre ricostruita. Un bizzarro edificio in stile romanico venne eretto dal vescovo Adalboldo II e consacrato nel 1023. Si presentava come un agglomerato di cinque chiese disposte a forma di croce, chiamato comunemente Kerkenkruis o duomo di Adalboldo. Nel 1039 vi vennero seppellite le viscere di Corrado II il Salico, morto in città.
Anche questa chiesa subì i danni di un grande incendio, scoppiato nel 1253, che devastò gran parte di Utrecht.
Il duomo gotico XIV e XV secolo
Fu allora, nel 1254, che il vescovo Hendrik van Vianden, già decano della cattedrale di Colonia, decise la costruzione di una nuova e maggiore chiesa, l'attuale duomo gotico. Pose la prima pietra nello stesso anno, ma il cantiere non si avviò subito, a causa della ricerca dei fondi necessari. Nel 1265 papa Clemente IV concesse un'indulgenza ai fini della costruzione, ma i lavori iniziarono solo nel 1288 dopo i piani finanziari operati dal vescovo Jan van Nassau, e si protrassero fino al XVI secolo.
Il progetto prevedeva una planimetria a croce latina, con transetto e coro a deambulatorio con cappelle radiali poco profonde. L'ispirazione sembra trovare influssi dalle cattedrali di Tournai e di Soissons, ma mostra delle affinità anche con il duomo di Colonia, tanto da far pensare un operato dell'architetto Gerhard di Colonia.
Il cantiere iniziò con l'elevazione dei pilastri a fascio del coro, terminati intorno al 1295, e si proseguì con quelli dalla navata sud del deambulatorio che tuttavia presenta già una variazione del piano originale, atto ad ampliare gli spazi, e provato dall'utilizzo di pilastri differenti, senza capitelli. Uno dei più antichi esempi di applicazione di pilastri di questo tipo. Questa porzione della cattedrale fu completata intorno al 1320 e si continuò con l'elevazione del deambulatio nord e la relativa sacrestia, eseguiti in uno stile più sobrio entro il 1350. Contemporaneamente, dal 1321, si intraprese l'erezione della torre-portico sulla facciata, a base quadrata e composta da tre piani rastremati.
Dal punto di vista economico Utrecht si distingue da molte altre città olandesi per la forte tendenza al commercio: i suoi negozi sono molto rinomati in tutti i Paesi Bassi. La stazione ferroviaria è il centro della rete ferroviaria olandese e la sede degli uffici centrali del Nederlandse (Ferrovie olandesi) ed è strutturalmente unita al centro commerciale più grande del paese, Hoog Catharijne.
L’Universita’ di Utrecht (Utrecht Universiteit), con i suoi 30.000 studenti, è il più grande ateneo e centro di ricerca di tutti i Paesi Bassi e, con i suoi 7.000 impiegati, è anche la realtà economica più grande, in termini di numero di dipendenti, della città. La presenza dell'Università connota fortemente la vita di Utrecht, dove vivono decine di migliaia di persone con meno di 25 anni di età e diverse migliaia di studenti e ricercatori stranieri. Inoltre, nel centro cittadino ci sono cinema, teatri, centinaia di bar e decine di locali notturni. Utrecht è anche molto famosa per i suoi caffè e ristoranti, realizzati con gli stili e i gusti più variegati.
Dal punto di vista delle attività culturali, la città si presenta come un centro dinamico e molto attivo, specialmente per la presenza di vari musei, teatri, scuole d'arte.
Conclusione:
Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti terrà per sempre nella sua aura di meraviglia.
Jacques-Yves Cousteau
Carlo Gatti
Rapallo, 13 Settembre 2023
MUSEO NAVALE ROMANO - ALBENGA , LA CITTA’ DELLE 100 TORRI
MUSEO NAVALE ROMANO
ALBENGA
LA CITTA’ DELLE 100 TORRI



MUSEO DELLA NAVE ROMANA DI ALBENGA
“ ... nessuno ricorda che l’Italia ha bisogno di risorse esterne e che la vita del popolo romano è esposta ogni giorno alle incertezze del mare e delle tempeste!”
(Tacito-Ann-III,2.52)
Con queste parole risentite Tiberio fustigava in senato i lussi e gli sperperi di Roma, ricordando che invano si sarebbero cercate in patria le risorse necessarie alla sopravvivenza dei cittadini se gli alimenti di base non fossero arrivati d’oltremare. Difficilmente si potrebbe esporre meglio la dipendenza alimentare di Roma dai suoi rifornimenti via mare già nell’alto impero.
PREMESSA
Non essendo il sottoscritto un archeologo e neppure un esperto della materia, ma soltanto un appassionato di archeologia marina, in questo articolo divulgativo ho ritenuto più saggio lasciare quasi tutto lo spazio disponibile agli specialisti della materia perché ritengo che soltanto loro possano attirare nuovi proseliti verso questa affascinante disciplina. Questo almeno è quanto mi è successo molti anni fa...
Navigare il Mediterraneo però non era una passeggiata. Nonostante il Mediterraneo appaia come un bacino chiuso, il Sahara a sud e l’Oceano Atlantico a ovest provocano nei periodi di cambio stagionale variazioni meteomarine abbastanza veloci e non prevedibili senza moderni equipaggiamenti; i navigatori antichi si potevano affidare soltanto all’esperienza per prevedere il cambiamento delle condizioni atmosferiche. Tutta la navigazione si basava su un sapere tramandato di generazione in generazione; per esempio, tra le nozioni apprese dagli antichi naviganti vi era la conoscenza di venti e brezze stagionali che, insieme alle correnti, permettevano di utilizzare diverse rotte a seconda del periodo dell’anno. Il periodo meno favorevole alla navigazione era l’inverno, detto in antico “periodo del mare clausum”, quando le condizioni metereologiche erano più complicate. La grande esperienza dell’equipaggio era necessaria per navigare in buone condizioni di vento e senza copertura nuvolosa notturna che impediva di vedere le stelle utilizzate per orientarsi di notte.
Il museo, oltre al carico di anfore vinarie, provviste e attrezzature provenienti dai resti anfora di una nave romana affondata nel secolo I a.C. davanti alla costa, espone reperti archeologici di area ingauna e una collezione di vasi da farmacia dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia.

Isola Gallinara
L'isola Gallinara o isola Gallinaria (A Gainâa in ligure, Insula Gallinaria o Gailiata in latino ) è un'isola situata nei pressi della costa ligure, nella Riviera di Ponente, di fronte al comune di Albenga al quale appartiene. L'isola dista 1,5 km dalla costa, dalla quale è separata da un canale profondo in media 12 m; essa costituisce la Riserva naturale regionale dell’Isola Riserva naturale regionale dell’isola di Gallinara.
La raccolta completa del museo conserva, oltre ai ritrovamenti della nave romana, anche materiali sottomarini rinvenuti dalle diverse esplorazioni subacquee, dal 1957 in poi, nei fondali circostanti l'isola Gallinara. Nella sala detta "degli affreschi", caratterizzata dalla presenza di portali in ardesia del XVI secolo e un camino, è stata allestita la raccolta dei vasi da farmacia provenienti dall'ospedale di Albenga; la collezione comprende all'incirca un centinaio di pezzi in ceramica bianca e blu, databili tra il XVI e XIX secolo, di fabbricazione savonese e albissolese.
NINO LAMBOGLIA

Nino Lamboglia è considerato il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea, nel 1958 fondò il Centro sperimentale di archeologia marina, invitò studiosi da tutto il mondo, organizzò congressi e seminari e lavorò alla carta archeologica dei fondali, seguendo poi, tutti i ritrovamenti subacquei, dell'intera costa italiana.
La scoperta del relitto della nave romana di Albenga
Il primo scavo subacqueo in Italia
E' stata oggetto di tredici campagne di scavo subacqueo che hanno consentito di documentare gradualmente gli elementi del carico e le caratteristiche costruttive dello scafo. E' stato pure accertato che si tratta della più grande nave oneraria (nave da carico) romana conosciuta a tutt'oggi nel Mediterraneo, con un carico superiore alle 10.000 anfore, e quindi con una portata netta di 450/500 tonnellate. Le anfore contenevano vino proveniente dalla Campania destinato ai mercati della Francia meridionale e della Spagna. Insieme al vino veniva esportata la ceramica a vernice nera e altri tipi di vasellame.
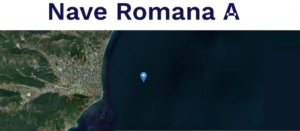
Il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa
NAVE ROMANA DI ALBENGA
La nave da carico era di grandi dimensioni, 40 metri di lunghezza.
Era il 1925 quando un pescatore del luogo, Antonio Bignone, trovò tra le sue reti alcune anfore. La scoperta destò interesse da subito, ma fu necessario attendere sino al febbraio 1950 per un primo tentativo di recupero, in quanto il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa.
Lo scavo permise altresì di individuare l’albero maestro che aveva un diametro di circa 50 cm. seguito dei risultati dello scavo fu accertato che la nave Romana d’Albenga era lunga circa 40 m., larga almeno 10 m. e le anfore trasportate dovevano essere almeno 10.000. Teniamo conto che le anfore pesano (vuote) kg 21.5, che il loro contenuto era di 26 litri, ogni anfora pesava all’incirca 45 kg., quindi la nave aveva una portata di 450 tonnellate.

Anfora del tipo Lamboglia 2
Per il tipo di anfore rinvenute sul relitto (Dressel 1b e poche anfore di forma Lamboglia 2), ed il tipo e la forma delle ceramiche rinvenute si è potuto collocare il relitto nel primo decennio del secolo I a.C.
Tra i materiali del carico sono stati recuperati 8 elmi bronzei, che potrebbero indicare la presenza di una scorta armata a bordo.
E’ ormai diventata famosa la “ruota di manovra” in piombo (del quale non ho trovato la foto) scoperta dai palombari dell’Artiglio, ancora oggi di dubbia interpretazione, ed il corno in piombo che secondo Lamboglia avrebbe fatto parte della testa di un animale che doveva decorare la prua di questa magnifica nave.

https://www.albengacorsara.it/corsara/
“La dotazione di bordo comprendeva, oltre alle stoviglie, tutto l’occorrente per provvedere alle improvvise necessità che potevano verificarsi durante la traversata. Ad esempio vi era un crogiolo in quarzo, adatto a fondere il piombo in modo da poter provvedere alle urgenti saldature e riparazioni.
Per fabbricare funi a bordo era stato installato un meccanismo che prevedeva una ruota di piombo infissa, per mezzo di un foro centrale a sezione quadrata, su una struttura lignea che ne permetteva la rotazione. Disposti a croce rispetto al foro appena citato, ve ne erano altri quattro, all’interno dei quali passavano i singoli cavi che, grazie al movimento della ruota, si attorcigliavano vicendevolmente in modo da formare cime consistenti (le ipotesi di uso riguardanti la “ruota di manovra” sono molteplici, quella illustrata è la più accreditata da parte di chi scrive).
La pirateria era molto diffusa lungo i mari italiani e il Mar Ligure gode di un’efferata fama corsara all’interno delle fonti antiche. Al fine di una difesa in caso di attacchi, vennero caricati a bordo alcuni elmi, facenti parte dell’attrezzatura per una difesa estemporanea e improvvisata, certamente non attribuibili ad una vera scorta armata militare. Per scongiurare tali infausti eventi, era parte dell’arredamento un corno in piombo, con chiaro intento apotropaico, che doveva allontanare malocchi e malefici.
Purtroppo il corno non fu sufficiente, perché la nave, salpata dalla Campania, incontrò una violenta tempesta nei pressi di un centro abitato denominato Albingaunum. Nonostante il vicino riparo del porto e un agevole approdo sull’isola Gallinara, la nave, sospinta dal vento e dal mare, si inclinò a tribordo e si inabissò. Il carico scivolò verso il lato destro e il grande peso delle anfore, circa 45kg l’una da piene, sommato all’urto contro il fondale provocò la rottura dello scafo all’altezza del ginocchio (punto di raccordo fra il fondo della nave e la murata)”.
Le anfore
Sulle navi lo stivaggio delle anfore avveniva impilandole le une sulle altre con un sistema “a scacchiera”, in modo che quelle dello strato superiore si inserissero fra tre colli delle anfore sottostanti. I contenitori si adeguavano alla forma della carena e venivano fissati e protetti dagli urti con ramaglie di ginepro, di erica, giunchi, paglia ed altro.
Le anfore venivano fabbricate nelle regioni di produzione delle merci, con forme diverse a seconda della provenienza, della cronologia e del contenuto. In età romana circolavano in tutto il Mediterraneo, spingendosi fino alla Britannia e al Bosforo, testimoniando l’unificazione commerciale, oltre che politica, dell’impero.
Il primo a comprendere l’importanza di questi oggetti per la ricostruzione dei traffici commerciali fu Heinrich Dressel, che alla fine dell’Ottocento studiò la relazione tra le diverse forme di anfore e le iscrizioni conservate su di esse. Così Dressel gettava un ponte tra archeologia, epigrafia e storia economica. Di qui si è sviluppata una solida tradizione di studi.
Oggi si è in grado di attribuire le anfore a grandi blocchi di produzioni (italiche, galliche, iberiche, africane e orientali) e, all’interno di questi, a sempre più specifici ambiti di provenienza, riuscendo a “tracciare” i rapporti commerciali dei popoli del Mediterraneo.
SCOPRI ALBENGA.IT

Esposizione di importanti reperti recuperati dal relitto della nave oneraria romana rinvenuta nei fondali dell’Isola Gallinara: vasellame, attrezzature navali, pedine da gioco, piccoli arnesi in piombo per la pesca oltre ad un centinaio di anfore vinarie, disposte come lo erano originariamente sulla loro nave, in un’apposita rastrelliera in legno che ne riproduce il “ventre”.
A differenza delle navi da guerra, i mercantili o navi onerarie avevano uno scafo tondeggiante e robusto, adatto sia per la navigazione di cabotaggio, sia per la navigazione in mare aperto, necessaria al fine di attraversare più velocemente determinate zone nel Mediterraneo. La propulsione era unicamente a vela (sempre di tipo quadra che, opportunamente ridotta ad una forma triangolare, permetteva di risalire il vento) e nelle onerarie di maggiori dimensioni poteva essere presente un secondo albero a prua, di dimensioni minori.
Le dimensioni degli scafi potevano variare a seconda delle tipologie di trasporto in cui erano impiegate. Si distinguono: navi di piccolo tonnellaggio (inferiori ai 15 m di lunghezza) adatte alle navigazioni di breve durata, navi di medio tonnellaggio (tra 15 e 30 m) impiegate sia per le rotte lungo costa che per tratti in mare aperto e navi di grande tonnellaggio (sopra i 30 m di lunghezza) che facevano parte della flotta dell’Annona e rifornivano principalmente la capitale.
Nota da ROMANO IMPERO:
ANNONA: Prese il nome di Annona il raccolto di grano di un'annata (annus), poi, gradualmente, ogni altra derrata prodotta da un territorio in un anno.
In seguito si intese con questo nome l'insieme dei prodotti agricoli raccolti in un anno per l'approvvigionamento di una città o di uno Stato.
Vi si aggiunse poi anche il magazzino adibito al deposito dei prodotti e l'ufficio che vi sovrintendeva.
I mercantili possedevano un ponte su cui si muoveva l’equipaggio e potevano trasportare passeggeri (non esistevano navi da trasporto passeggeri per lunghi tratti, ma si viaggiava insieme alle merci). Al di sotto del ponte era presente una stiva in cui venivano sistemati i carichi che potevano essere eterogenei o omogenei (nel caso di navi usate solo per il trasporto di grano o olio). Il principale contenitore da trasporto erano le anfore, ma si potevano utilizzare anche i dolia di grandi dimensioni per il vino, sacchi per il grano, cassette lignee e altro.

DOLIA
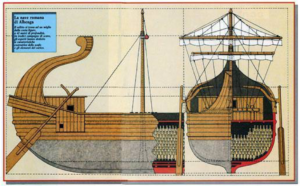
NAVE ROMANA DI ALBENGA

Anfora tipo Dressel 1B
La stiva veniva colmata con anfore vinarie di produzione italica-campana, le Dressel 1B, alte poco più di un metro e caratterizzate per un orlo ripiegato esternamente per formare un colletto leggermente sfasato verso il basso, impostato sul collo, di lunghezza variabile, che termina in una spalla un po’ spigolosa. La pancia poteva essere pronunciata o longilinea. All’estremità inferiore delle anfore si trova un alto puntale, necessario per permettere l’impilamento. All’interno della nave ne furono caricate fino a dieci mila, disposte su cinque strati sovrapposti, con il puntale dell’anfora superiore trattenuto tra i colli delle inferiori. Sfruttando tali incastri il mercante era certo che, anche in presenza di turbolenze, i contenitori non si sarebbero rovesciati e infranti, spargendo il loro prezioso contenuto. Ulteriore accorgimento per evitare la dispersione del vino era costituito dalla chiusura ermetica dell’imboccatura dell’anfora. Il collo veniva sigillato incastrandovi un tappo di sughero, spesso ben 7 cm, bloccato da uno strato di malta e calce. L’estrema sigillatura del collo era data dall’inserimento di una pigna verde che, con il passare del tempo, si sarebbe seccata e aperta a ventaglio. Quest’ultimo espediente poteva avere una duplice funzione, la prima era quella di aromatizzare il contenuto dell’anfora, e la seconda, più pratica, di facilitare la rimozione del tappo. La pigna infatti, grazie alle sue asperità, avrebbe creato dei luoghi di appiglio per incastrarvi due leve che permettessero di applicare la forza necessaria a rimuovere l’intero tappo. Invece, per preservare le proprietà organolettiche del contenuto da commistioni esterne, l’intera superficie porosa dell’anfora fu ricoperta di uno spesso strato di resina o pece.


Legato al nome dell’illustre archeologo e studioso di storia romana e medievale Nino Lamboglia, il prestigioso Museo Navale Romano, sito all’interno di Palazzo Peloso Cepolla espone gli importanti reperti recuperati dal relitto della nave oneraria romana rinvenuta nei fondali dell’Isola Gallinara: vasellame, attrezzature navali, pedine da gioco, piccoli arnesi in piombo per la pesca oltre ad un centinaio di anfore vinarie, disposte come lo erano originariamente sulla loro nave, in un’apposita rastrelliera in legno che ne riproduce il “ventre”.

Diversamente dagli alimenti solidi, come il grano, il trasporto delle derrate liquide o semiliquide come il vino, l’olio e le salse di pesce (garum), è affidato a contenitori in terracotta, in particolare alle anfore (dal termine greco amphìphèro, porto da entrambe le parti, riferito alle due anse dei contenitori). Questo genere di recipienti rappresenta il mezzo più efficace per garantire la conservazione e la spedizione di grandi quantitativi di merci per via marittima o fluviale.
Nelle navi lo stivaggio delle anfore avveniva impilandole le une sulle altre con un sistema “a scacchiera”, in modo che quelle dello strato superiore si inserissero fra tre colli delle anfore sottostanti. I contenitori si adeguavano alla forma della carena e venivano fissati e protetti dagli urti con ramaglie di ginepro, di erica, giunchi, paglia ed altro.
Le anfore venivano fabbricate nelle regioni di produzione delle merci, con forme diverse a seconda della provenienza, della cronologia e del contenuto. In età romana circolavano in tutto il Mediterraneo, spingendosi fino alla Britannia e al Bosforo, testimoniando l’unificazione commerciale, oltre che politica, dell’impero.
Il primo a comprendere l’importanza di questi oggetti per la ricostruzione dei traffici commerciali fu Heinrich Dressel, che alla fine dell’Ottocento studiò la relazione tra le diverse forme di anfore e le iscrizioni conservate su di esse. Così Dressel gettava un ponte tra archeologia, epigrafia e storia economica. Di qui si è sviluppata una solida tradizione di studi.
Oggi siamo in grado di attribuire le anfore a grandi blocchi di produzioni (italiche, galliche, iberiche, africane e orientali) e, all’interno di questi, a sempre più specifici ambiti di provenienza, riuscendo a “tracciare” i rapporti commerciali dei popoli del Mediterraneo.


Sono stati pure recuperati oggetti di uso personale dell'equipaggio e della scorta armata di bordo (elmi), quest'ultima necessaria per difendersi dai pirati che infestavano soprattutto le coste liguri. Tutti gli elementi raccolti permettono di datare il naufragio della Nave Romana di Albenga tra il 100 e il 90 a.C., momento che coincide con la concessione del diritto latino alle popolazioni liguri, con la romanizzazione della regione e con il conseguente sviluppo delle città.
RECUPERO DEL RELITTO
STORIA BREVE
Albenga. Ancora oggi costituisce uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane oggi conosciute nel mediterraneo. E’ la nave romana adagiata sui fondali di Albenga. Venne scoperta casualmente da un pescatore nel 1925. Nelle sue reti finirono tre anfore risalenti all’età romana. La nave “riposa” a circa un miglio dalla costa ad una quarantina di metri di profondità. Solo 25 anni dopo, la SORIMA, (società specializzata che recuperò l’oro sul relitto Egypt,) effettuò un primo intervento di scavo e recupero del relitto. In particolare furono recuperate circa 1.000 anfore, in gran parte danneggiate nella parte superiore per le reti a strascico, ma anche per la pesante benna di recupero dell’Artiglio.
Soltanto nel 1957, con la creazione del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina Albenga, si iniziarono i primi rilevamenti del relitto.
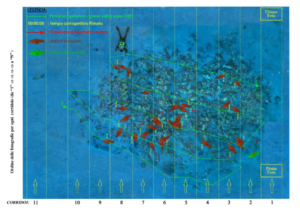
Nel 1961 si affrontò il rilevamento ufficiale della nave adottando il sistema di quadri di rilievo in tubi rigidi formanti una rete di copertura sul relitto, a maglie di cm 150×150, che attraverso un sistema di ingrandimento fotografico in scala di tutti i quadrati (192 per l’esattezza) e il loro fotomontaggio diede le misure reali del cumulo di anfore emergente dal fondo: 26 Mt. di lunghezza e 7.5 di larghezza. Lo scavo iniziò subito dopo al rilevamento e lo stesso permise di accertare che vi era stato subito dopo il naufragio della nave un rapido insabbiamento del fondale e un riempimento di fango proveniente dal fiume Centa che fino agli inizi del Trecento sboccava di rimpetto al relitto.
I risultati più importanti furono raggiunti durante le campagne degli anni 1970 – 1971. Durante queste campagne si poterono costatare che gli strati di anfore erano come minimo quattro, la scoperta di tre ordinate (larghe 14 – 15 cm e alte 12 cm) distanti 10 cm tra di loro nonché la scoperta della lamina di piombo con le chiodatura in rame che fasciava il fasciame esterno, la scoperta della ceramica a vernice nera facente parte del carico impilata negli spazi vuoti tra le anfore la ceramica probabilmente era imballata con materiali leggeri (paglia o altro) e attorno ad essa frammenti di pietra pomice anch’essa come le anfore e le ceramiche di provenienza campana. Lo scavo permise altresì di individuare l’albero maestro che aveva un diametro di circa 50 cm.
A seguito dei risultati dello scavo si accertò che la nave Romana d’Albenga era lunga circa 50 m. larga almeno 10 m.t. e le anfore trasportate dovevano essere almeno 10.000.
Si tenga conto che le anfore pesano vuote kg 21.5, che il loro contenuto era di 26 litri ogni anfora pesava all’incirca 45 kg. – quindi la nave aveva una portata di 450 tonnellate.
Trattandosi di un record, ripetiamo ancora una volta che questa nave costituisce, ad oggi, uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane oggi conosciute nel mediterraneo.
Per il tipo di anfore rinvenute sul relitto (Dressel 1b e poche anfore di forma Lamboglia 2), il tipo e la forma delle ceramiche rinvenute si è potuto collocare il relitto nel primo decennio del secolo 1 a.C.
Tra i materiali del carico sono stati recuperati 8 elmi bronzei, che potrebbero indicare la presenza di una scorta armata a bordo.
E’ ormai diventata famosa la “ruota di manovra” in piombo trovata dai palombari dell’Artiglio, ancora oggi di dubbia interpretazione e il corno in piombo che secondo il Lamboglia come facente parte della testa di un animale che doveva decorare la prua di questa magnifica nave.






Il professor Nino Lamboglia, a bordo della nave "Artiglio" (foto sopra) riuscì a recuperare in poco meno di un mese oltre 700 anfore, dando il via ad una campagna di scavi sommersi condotta in modo sistematico, la moderna "archeologia subacquea". Purtroppo all'inizio furono utilizzati strumenti inadeguati, tra cui una benna meccanica, che arrecarono dei danni irreparabili al carico della nave. Le ricerche che si sono susseguite negli anni hanno permesso di ampliare le conoscenze sulla nave ed il recupero di molto materiale tra cui elmi in bronzo ed oggetti di uso personale dell'equipaggio. Il carico, infatti, è ricchissimo ed in perfetto stato di conservazione nonostante la datazione delle anfore risale intorno al 100 a.C. Le anfore erano stivate con il tipico sistema delle navi onerarie romane e l'aspetto sorprendente è che le anfore pesino vuote circa 21 kg e che il loro contenuto era di 26 litri, per un peso complessivo di circa 45 kg. La nave aveva una portata di oltre 450 tonnellate ed è, ancora oggi, uno dei più grandi relitti di navi onerarie romane conosciute nel mar Mediterraneo.

Il sistema di sollevamento dei resti per mezzo della benna







Per il recupero dei relitti venivano impiegati scafandri rigidi e articolati, forniti di gambe e braccia terminanti con artigli metallici in grado di afferrare utensili. Il palombaro attraverso degli oblò poteva osservare l’esterno e comunicava con la superficie attraverso un cavo telefonico. Quaglia credette così tanto in questo progetto che nel 1927 acquistò in esclusiva gli scafandri rigidi tedeschi Neufeldt und Kuhnke.
LA NAVE
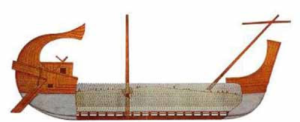
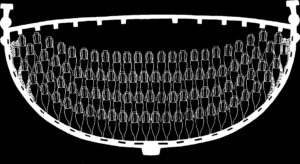
Ce lo spiega molto bene una descrizione tratta da www.antika.it/008704_nave-romana-di-albenga.html e qui riassunta: la nave oneraria di epoca romana rinvenuta ad Albenga (Savona – Liguria), era un’imbarcazione impiegata per il trasporto di merci, lunga 40 m e larga 12 m; essa poteva trasportare intorno alle 11.000/13.000 anfore vinarie e vari tipi di ceramica, tra i quali ve ne erano alcuni che erano stati realizzati in Campania per essere poi esportati in Francia meridionale e in Spagna.
Nel 1950 il professore Giovanni Lamboglia tentò il primo recupero dei reperti con l’aiuto della nave Artiglio, mentre nel 1961 furono realizzati i primi rilievi del relitto.
IL CARICO DELLA NAVE
La nave trasportava per la maggior parte anfore, alcune delle quali furono ritrovate integre, altre soltanto in frammenti costituiti da fondi e colli; il numero delle anfore e la capacità del relitto hanno portato a sostenere che la nave contenesse 13.000 pezzi.
Esse contenevano per la maggioranza vino, ma sono stati rinvenuti anche anfore con residui di noccioline. Le anfore erano chiuse con tappi di sughero, sigillati con la malta, alcune di esse presentavano sotto il tappo una pigna incastrata nel collo, con lo scopo di mantenere l’aroma del vino. Le anfore facenti parte del carico sono le Dressel 1; tre olearie Lamboglia 2 e alcuni frammenti di Dressel 27. Per quanto riguarda la ceramica, essa è presente nella campana A e C e d’imitazione; vasi a vernice rossa interna; urnette; olle; olpi e grandi boccali.
Tra i vari resti sono stati trovati anche due elmi in frammenti; un corno di ariete; una ruota di manovra; tubi; un mortaio; lamine; un tubetto in piombo e piccoli strumenti difficili da identificare. Per il tipo di anfore rinvenute (Dressel 1 B e Lamboglia 2) e il tipo e le forme della ceramica (Campana A, forme 5 e 31) e per gli altri vasi (Campana C, imitazione campana, vasi a vernice rossa interna, vasi a patina cenerognola e vasi comuni) la nave di Albenga è stata datata primo decennio del I a.C.
A cura di A. Eusebio
Nel 1925 il pescatore Antonio Biglione recuperò dal mare tre anfore di epoca romana, la cui posizione era di circa 1 miglio dalla costa e a 40 m di profondità. Nel 1948 l’avvocato Giovanni Quaglia, con lo scopo di verificare la presenza della nave, propose una prima campagna di indagini ed il Ministero della Pubblica Istruzione approvò tale richiesta. Fu stipulato un accordo secondo il quale i reperti recuperati sarebbero stati custoditi nel Museo Civico di Albenga.
LA PRIMA CAMPAGNA DI SCAVO
La campagna iniziò il mattino dell’8 febbraio del 1950 e fu il professor Giovanni Lamboglia a descriverla, vivendola in prima persona:
“Guidammo l’Artiglio, alle 8 del mattino dell’8 febbraio 1950, sulla località delle anfore, con la barca dello stesso pescatore Antonio Bignone e col geom. Fortunato Canepa, del comune di Albenga, pure appassionato pescatore. Fissati gli ormeggi, il palombaro Petrucci si calò per primo sul fondale, entro la torretta di osservazione che costituisce uno degli strumenti più preziosi dell’Artiglio; e, alla profondità di m. 40, telefonò subito che si vedevano anfore a centinaia, sparse in ogni direzione, su una linea di circa 30 metri di lunghezza e circa 10 metri di larghezza, formante una massa affusolata alta circa due metri sul fondale melmoso circostante”.
In seguito a questi rinvenimenti i ricercatori stabilirono di iniziare il recupero delle anfore e di constatare le condizioni della nave:
“Il giorno dopo, 9 febbraio furono issate a bordo le prime anfore, e l’interesse della stampa e del pubblico diventò immediatamente spasmodico, creando seri intralci al lavoro. Fu, ciò nondimeno, un’impressione indimenticabile veder salire a bordo le anfore intatte, a grappoli di cinque o sei, legate a doppio nodo con una fune dai palombari che lavoravano sul fondo, coperte dai colori vivissimi della fauna marina, che al sole si estinguono dopo pochi minuti, di alghe, incrostazioni calcaree e molluschi secolari”.
Dello scafo della nave non emersero resti, perciò si ipotizzò o che la nave fosse stata ricoperta dalla sabbia, oppure che lo scheletro del relitto, a causa del forte peso del carico e all’opera delle correnti marine, si fosse squarciato aprendosi sui due lati, lasciando intatte solo le anfore e probabilmente la chiglia.
Nei giorni successivi venne perfezionato il metodo utilizzato per sollevare le anfore, infatti fu impiegata una rete invece del sistema della legatura ad una fune, che riduceva le anfore in frammenti. Non era stato ancora risolto il dubbio della reale esistenza della nave, della sua posizione e delle sue condizioni di conservazione; perciò le ricerche furono rivolte verso l’estremità del relitto orientata verso il mare aperto.
Il 13 febbraio le ricerche ripresero per mezzo della benna, che aveva la capacità di sollevare una quantità maggiore di anfore e di raggiungere più velocemente la chiglia ed il 17 furono estratti i primi resti della nave. Il 18 lo scavo fu approfondito fino a 2 m, dalla buca furono estratte anfore prive di incrostazioni, ciò fu chiaro indice della vicinanza della chiglia. La campagna fu sospesa il 21 su decisione di Lamboglia e del prof. Pietro Romanelli (ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione).

Nel 1960 la “Daino”, protagonista di questa storia, trasformata in nave ricerche archeologiche sottomarine, assumendo la sigla NATO “A 5308”.
Nel 1962 una seconda esplorazione del relitto fu effettuata dalla nave DAINO così come altre spedizioni sottomarine negli anni seguenti su incarico e a cura del Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina che proprio ad Albenga ha la sua sede nazionale.
Nave Romana A
Sito Centro Subacqueo Idea Blu
https://www.youtube.com/watch?v=9p2hJ0gZBQA&t=18s
https://www.centrosubideablu.com/13-immersioni/54-nave-romana-a
IMMAGINI DELL’IMMERSIONE DEL 2 AGOSTO 2014




IMMERSIONE SULLA NAVE ROMANA
DEEP DIVING ACADEMY
L’immersione sulla “Nave Romana di Albenga”, pur non presentando particolarità o difficoltà che la rendono eccezionale, ha tuttavia un fascino al quale è difficile rimanere indifferenti.
Una montagna di anfore poggia su un fondale sabbioso a poco più di 40 metri di profondità, intorno il nulla o quasi. Il 2 agosto 2014 alcuni pesci luna accompagnavano i sub.
Una oasi di storia e di vita accoglie il subacqueo che visita in sito, ogni anfora è diventata la casa o il rifugio di animali marini e così da luogo di memoria è diventato un ambiente di trasformazione, una culla dove nuova vita sorge tra i reperti di quella passata.

Villa san Giovanni in Tuscia - STORIA
Micaela Merlino

CHI ERA NINO LAMBOGLIA?
Nino Lamboglia è stato il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea
Tra le figure di grandi studiosi di archeologia e di storia, l’Italia vanta Nino Lamboglia il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea, che purtroppo, però, è poco conosciuto dal grande pubblico.
Nato a Porto Maurizio in provincia di Imperia il 7 Agosto 1912, già dagli anni dell’Università si interessò alla storia dell’Ingaunia, antica zona della Liguria di ponente.
Nel 1933, nello stesso anno in cui si laureò all’Università di Genova, fondò ad Albenga la “Società Storico Archeologica Ingauna”, quindi dal 1934 al 1937 fu Direttore della “Biblioteca Civica” di Albenga, facendola risorgere dopo un periodo di crisi. Fu poi nominato Commissario straordinario del “Museo Biknell” di Bodighera, fondato nel 1888 dall’inglese Clarence Biknell (1842-1918) che, tra l’altro, aveva scoperto e studiato le incisioni rupestri del Monte Bego. Il Museo raccoglieva le sue collezioni di botanica, ornitologia, archeologia e mineralogia.
In quegli stessi anni il Lamboglia conobbe il famoso archeologo genovese Luigi Bernabò Brea (1910-1999), dal 1939 al 1941 Soprintendente alle Antichità della Liguria, con il quale iniziò a collaborare in ricerche archeologiche nella Riviera di Ponente. Il Bernabò Brea fu il precursore in Italia dello scavo archeologico stratigrafico, che applicò nello scavo della grotta delle Arene Candide presso Finale Ligure, un sito di età Neolitica, e successivamente nello scavo dell’acropoli di Lipari in Sicilia quando fu Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale.
Sempre animato da grande passione per le antichità e da grande energia, nel 1942 Nino Lamboglia fondò a Bordighera l’“Istituto Internazionale di Studi Liguri”, rivestendo la carica di Direttore per trentacinque anni, istituendo successivamente anche altre sezioni in diverse città della Liguria. Né va dimenticato che collaborò attivamente con la Soprintendenza alle Antichità della Liguria come Ispettore aggiunto, in molte ed importanti ricerche di archeologia locale.
La sua benemerita attività si segnalò anche in occasione della Seconda Guerra Mondiale, quando fu Direttore della “Biblioteca Civica Aprosiana” a Ventimiglia, la prima biblioteca pubblica aperta in Liguria e una delle più antiche d’Italia, fondata nel 1648 da Angelico Aprosio (1607-1681) monaco agostiniano e letterato, riconosciuta ufficialmente nel 1653 da Papa Innocenzo X, poi dagli inizi del XIX secolo amministrata dal Comune di Ventimiglia.
La biblioteca possedeva preziosi volumi, incunaboli e manoscritti, e già nel periodo della dominazione napoleonica in Italia aveva subìto furti e dispersione, ma dai primi decenni del XX secolo conobbe una rinascita e ciò grazie all’opera intelligente e zelante di alcuni bibliotecari, tra cui lo stesso Lamboglia, che paventando possibili danni al patrimonio librario e archivistico a causa degli eventi bellici, si attivò per garantirne la conservazione.
I rapporti tra Nino Lamboglia e Luigi Bernabò Brea continuarono ad essere proficui anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo il Bernabò Brea fondò in Sicilia il “Museo Archeologico di Lipari” insieme all’archeologa Madeleine Cavalier, sua infaticabile collaboratrice. Una seria e preparata studiosa che anche il Lamboglia stimò ed apprezzò affidandole nel 1948 le cariche di Segretaria e Vice Presidente della “Section Languadocienne” dell’ “Istituto Internazionale di Studi Liguri”, che mantenne fino al 1952.
Nel 1950 Nino Lamboglia su incarico della Soprintendenza alle Antichità di Siracusa assunse la direzione degli scavi di Tindari, in provincia di Messina, e si dedicò anche allo scavo archeologico sottomarino della nave di Albenga, poi nel 1958 fondò il “Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina”, una struttura tecnico-scientifica deputata alle ricerche di archeologia subacquea.
In quello stesso anno ad Albenga si svolse il “II Congresso Internazionale di Archeologia Sottomarina”, e grazie al contributo del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Difesa Marina al Centro Sperimentale fondato dal Lamboglia fu affidata la nave “Daino” appositamente adattata per le ricerche archeologiche in mare. Dal 1959 al 1963 furono condotte campagne di scavo sottomarino a Baia, a Spargi (relitto di nave romana), a Punta Scaletta presso l’Isola di Giannutri nel 1963 (relitto di nave di età repubblicana), e nuove campagne di scavo ad Albenga (relitto di nave romana).
Poi il “Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina” si dotò di una propria nave denominata “Cycnus”, impegnandosi in importanti ricerche lungo le coste tirreniche. Archeologo sempre attento alla salvaguardia dei Beni Culturali, il Lambolgia si battè con decisione per salvare Villa Hanbury presso il promontorio di Capo Mortola a pochi chilometri dal confine con la Francia.
La villa possedeva un meraviglioso giardino botanico allestito dal 1867 dall’inglese sir Thomas Hanbury, coltivando specie vegetali di tutto il mondo, e diventando ben presto conosciuto ed apprezzato a livello internazionale.
Sir Hanbury morì nel 1907, ma il figlio Cecil e sua moglie Dorothy continuarono a prendersi cura della villa e del giardino, che però furono abbandonati nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Fu allora che il giardino rischiò di essere lottizzato, ma appunto il Lamboglia con grande tenacia nel 1960 riuscì a farlo acquistare dallo Stato Italiano, e nel 1962 il complesso fu dato in gestione all’ “Istituto Internazionale di Studi Liguri”.
Tra gli altri meriti del Lamboglia c’è quello di essere stato il primo archeologo italiano ad aver ricoperto nel 1974 la cattedra di “Archeologia medievale” nell’Università di Genova, nello stesso anno in cui fu fondata la rivista “Archeologia Medievale” diretta dall’ archeologo Riccardo Francovich (1946-2007). Sembra incredibile che il padre dell’archeologia subacquea italiana abbia trovato la morte proprio in mare, non durante una ricerca archeologica sottomarina ma a causa di un incidente.
La sera del 10 Gennaio 1977 mentre era alla guida del suo autoveicolo in compagnia del collaboratore Giacomo Martini, fatalmente tratto in inganno dalla folta nebbia e dall’oscurità che impedivano una corretta visibilità, durante le manovre per salire sulla rampa di accesso di un traghetto sbagliò direzione, precipitando nelle gelide acque del mare. La morte tragica e prematura del grande archeologo, e del suo collaboratore, lasciò sconcertati e addolorati i suoi colleghi studiosi, i suoi studenti e quanti avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo.
Per ricordarlo, sull’Isola della Maddalena in Sardegna gli è stato dedicato un Museo, perché nei pressi dell’isola di Spargi Lamboglia aveva recuperato alcuni reperti. In occasione del quarantennale della tragica morte, la “Sezione di Imperia” dell’ “Istituto Internazione di Studi Liguri” il 10 Gennaio scorso ha reso omaggio all’illustre studioso con una cerimonia svoltasi presso la sua tomba, nel cimitero di Porto Maurizio.
L’eredità che Nino Lamboglia ha lasciato, non solo agli studiosi di archeologia, è di grande importanza: la ricerca ha sempre bisogno di coraggiosi “iniziatori” di nuovi metodi di indagine, proprio come lui è stato; per ricostruire in modo esauriente la storia di una civiltà e del territorio nel quale si è formata, e trasformata, occorre avere attenzione non solo per le “fasi classiche” ma anche per i periodi preistorici, e similmente per quelli tardo-antichi e medievali, e il Lamboglia non ha mai prediletto una fase storica rispetto ad un’altra ma tutte ha trattato e studiato con uguale interesse e rigore scientifico.
Una seria ricerca archeologica non si accontenta delle indagini nel terreno, ma scruta con lo stesso impegno gli abissi marini, poiché terra e mare allo stesso modo conservano tracce cospicue dell’uomo, della sua storia, della sua cultura, e il contributo da lui dato all’archeologia subacquea italiana è stato di importanza fondamentale.
L’archeologo non può limitarsi allo studio dei contesti che intende indagare, perché non è né uno “scavatore” nè un intellettuale avulso dalla sua società e dalle urgenze contingenti del momento storico e culturale in cui vive, ma ha il dovere di vigilare con amore, e di far sentire la sua voce con fermezza tutte le volte che qualcuno, o qualcosa, minacciano l’integrità, la sopravvivenza e la trasmissione alle generazioni future dei Beni Culturali, sottraendosi alla logica della speculazione, del guadagno di pochi, dell’indifferenza o della rassegnazione, proprio come ha fatto lui.
L’archeologia per Nino Lamboglia non fu una disciplina a cui dedicare tempo ed energie, ma una scienza che ha performato ed “invaso” tutta la sua vita, identificandosi con essa e andando anche oltre, grazie alla preziosa eredità che ha lasciato.
Micaela Merlino

ANFORE
Aspetti generali
Struttura dell'anfora
Le classificazioni delle anfore
La tebella Dressel
La tabella Lamboglia - Benoit
Esempi: le anfore cananee
Esempi: le anfore greco - arcaiche
Esempi: le anfore greco - italiche
Esempi: le anfore fenicie e puniche
Esempi: le anfore Etrusche
Esempi: le anfore imperiali
La più antica e famosa classificazione di questi vasi biansati senz'altro quella data dall'archeologo tedesco Henry Dressel, che visse molti anni a Roma e nel 1899 studi i marchi delle anfore del Monte Testaccio.
Questo monte, vicino a Porta Portese (Roma), d un'idea del grande uso che veniva fatto di questi recipienti in epoca romana; non altro infatti che una discarica di cocci d'anfora alta 30 metri.
La tabella Dressel (da Corpus Inscriptionum Latinarum) una classificazione tipologica delle anfore romane e, nonostante l'opinione contraria di molti archeologi, anche una tabella cronologica, seppure con molte lacune. Viene universalmente adottata, perchè il punto di partenza delle classificazioni posteriori; si legge a righe successive: la prima si riferisce alle forme repubblicane (II e I secolo a.C.), le altre a forme imperiali (I-III secolo a.C.).
Il compianto professor Nino Lamboglia, assieme al collega francese Fernand Benoit, ha rivisto e rielaborato la primitiva tabella Dressel con una nuova tabella, riordinando le varie forme, con una maggiore attendibilità cronologica.
La più completa e documentata classificazione a cui mi riferisco riguardo alle anfore quella pubblicata dall'archeologo francese Jean Pierre Joncheray nel 1976, con il titolo "Nouvelle classification des anphores dcouvertes lors de fouilles sousmarines".
Si tratta della descrizione tipologica e cronologica delle anfore recuperate lungo i litorali francesi; l'autore un appassionato archeologo oltre che un ottimo sommozzatore. I francesi hanno fatto maggiori progressi e sono a un livello superiore al nostro nella ricerca e nello studio dell'archeologia subacquea.
Lorenzo Mari tratto da 'Speciale Archeosub' supp.to n. 79 di Sub - 6/91
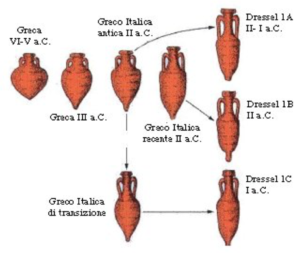
FONTI: Museo della Nave Romana di Albenga
BIBLIOGRAFIA
-
Lamboglia, Diario di scavo a bordo dell’ “Artiglio”, in “Rivista Ingauna e Intemelia”, V, 1, gennaio-marzo 1950, pp. 1-8.
N. Lamboglia, La nave romana di Albenga, in “Rivista di Studi Liguri”, XVIII, 3-4, luglio-dicembre 1952, pp. 131-203.
N. Lamboglia, Il primo saggio di scavo sulla nave romana di Albenga, in “Rivista Ingauna e Intemelia”, XVII, 1-4, gennaio-dicembre 1962, pp. 73-75.
F. Pallarés, Nino Lamboglia e l’archeologia subacquea, in “Rivista di Studi Liguri”, LXIII-LXIV, gennaio-dicembre 1997-1998, pp. 21-56.
A cura di Carlo GATTI
Rapallo, 16 Febbraio 2023
IL TESORO DELLA GARONNA
IL TESORO DELLA GARONNA
AQUITANIA – FRANCIA

Ogni relitto ritrovato è la tessera di un mosaico che racconta il cammino della storia navale nella sua evoluzione in tutti i settori:
-
costruzione navale
-
trasporto delle merci
-
mappa delle rotte frequentate
-
portualità dell’Impero Romano interno al Mare Nostrum ed anche esterno.
Ciò di cui ci occupiamo oggi è qualcosa di diverso dal solito, il relitto ritrovato è sicuramente una nave oneraria romana simile a quelle che trasportavano anfore colme di vino, olio, frutta secca e soprattutto il GARUM di cui ci siamo già occupati in varie occasioni.
Ma cosa ha di speciale questo relitto che è considerato uno tra i più importanti ritrovamenti archeologici degli ultimi decenni?

Innanzitutto si parla di una nave oneraria romana che, uscita da Gibilterra, navigò nel non facile golfo di Guascogna aperto sull’oceano fino a raggiungere Bordeaux dove, risalendo il fiume Garonne, incontrò forti correnti di marea che, da sempre, possono raggiungere gli 8 metri di altezza.
Di quella nave non si sa nulla perché fu devastata da un incendio e naufragò dove meno era probabile che accadesse in aperta campagna a 15 km da Burdigala (Bordeaux) nel suo viaggio di ritorno. Ma del suo carico, dopo 2 millenni, se ne parlerà ancora a lungo ….
Portare l’imprinting di Roma nel cuore dell’Occitania ed anche più a Nord presentava insidie di ogni tipo ed ebbe costi enormi per molti secoli.
Riportiamo alcune immagini significative del tesoro ritrovato
Il “Tesoro della Garonna”: 4001 monete romane, ora esposte al Museo d’Aquitania
4 Gennaio 2023
IL TESORO DELLA GARONNA
ROMANO IMPERO

FRANCIA - Il Tesoro della GARONNA: un insieme di 4001 monete romane che vennero perse con un naufragio nel II secolo d.C., è stato esposto al Museo dell’Aquitania' a Bordeaux. Questa è la prima volta che tutte le 4001 monete vengono esposte al pubblico. Le monete sono SESTERZI in oricalco, una lega di zinco e rame simile all'ottone, la cui data va dal regno dell'imperatore CLAUDIO (41-54 d.C.) a quello di ANTONINO PIO (138-161 d.C). È il più grande e significativo tesoro di monete ROMANE ritrovate in Francia.
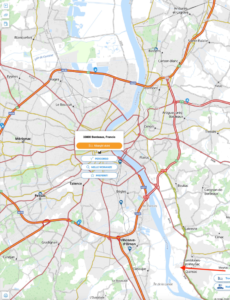
Il naufragio avvenne a SSE della città di Bordeaux, nella zona indicata dalla freccia rossa, nelle località Camblanes-Meynac-Quinsac e Cadaujac oltre l’altra sponda.
Le monete furono ritrovate tra il 1965 e il 1970 sui fondali della Garonna, presso alcuni piccoli paesi indicati con una freccia rossa sulla carta con i relativi nomi riportati nella didascalia.
I rinvenimenti avvennero durante lavori di dragaggio effettuati per ricavare materiali da costruzione, e le monete sono quindi state ritrovate durante un lungo e certosino lavoro di setacciamento, portato avanti da un professore universitario, Robert Etienne.
Il docente, con una determinazione e competenza fuori dal comune, riuscì a mappare i fondali, calcolare gli spostamenti delle dune sabbiose nei secoli per poi setacciare scrupolosamente tonnellate e tonnellate di materiale argilloso calcolando le forti correnti di marea nei due sensi: montante e calante; infine riuscì a recuperare monete anche nei cantieri di costruzione degli edifici.

Passarono sei anni e l'ex professore dell'Università di Bordeaux Robert Étienne continuò le sue ricerche di monete organizzando una serie di scavi sistematici in diversi siti sul fiume.
Le monete ancora intrappolate nella sabbia della Garonna, continuarono a spuntare nei decenni successivi, donate anche da privati ed altre Associazioni di ricercatori volontari.
Pezzi di legno carbonizzati trovati nella scoperta iniziale indicano che le monete si trovavano su una nave mercantile che risaliva il fiume da BURDIGALA (l’odierna BORDEAUX) tra il 170 e il 176 d.C. La nave prese fuoco e affondò con il suo carico, tra cui migliaia di sesterzi, molti dei quali sono stati visibilmente alterati dal contatto con il fuoco.
Le stime basate sulle dimensioni del carico della nave suggeriscono che almeno 800 monete sono ancora disperse, rubate dai cacciatori di tesori, o incastonate nel sedimento sul letto del fiume. La registrazione e lo studio dell'enorme numero di monete ha richiesto molti decenni di lavoro, motivo per cui il tesoro completo è stato esposto soltanto di recente.
Gli interrogativi …
La nave discendeva verso la città per ordini commerciali? Per vendere dei prodotti? Oppure stava iniziando il viaggio di ritorno nel Mare Nostrum con il “frutto” delle sue vendite?
Le ipotesi avanzate sono molte… ma nessun reperto ritrovato pare sia in grado di riportare alla luce la vera storia di quel naufragio.
Personalmente non escluderei un attacco piratesco di bande nemiche di Roma o comunque attirate dalla ricchezza ostentata dalle navi onerarie di Roma.
La trappola potrebbe essere scattata in aperta campagna lontana dai controlli delle pattuglie armate del fiume.
Aspettiamo i vostri commenti … Prendetevi tutto il tempo che volete!

All’epoca la somma della “CAGNOTTE” era pari a 125 anfore di vino o 10 tonnellate di grano, ma il tempo e la storia la rendono oggi un tesoro inestimabile”.
Per quanto riguarda il conio, la zecca più vicina ai luoghi di ritrovamento era Lione. Tutti i reperti sono stati lungamente restaurati, catalogati e studiati prima di essere messi in mostra, a molti anni dal loro ritrovamento.
UN PO’ DI STORIA ...
NAVE ONERARIA ROMANA
Parallelamente ai ritrovamenti di rostri che testimoniano la presenza di navi da guerra romane, nel Mediterraneo sono sempre più frequenti le segnalazioni e i susseguenti recuperi di imbarcazioni destinate ai traffici commerciali.

Le navi onerarie erano legni adibiti a tal scopo. Le dimensioni delle stesse variavano anche in funzione del carico, da una decina a oltre 60 metri, per particolari imbarcazioni destinate al trasporto di blocchi di marmo.
Mentre queste ultime pare presentassero particolari soluzioni costruttive per l’uso straordinario cui erano destinate (doppio fondo), le onerarie minori (di circa 20 metri), presentavano una struttura più semplice, a unico fondo, così come rappresentato nella figura riportata a sinistra.
La tecnica costruttiva preponderante era del tipo “a guscio portante”: il fasciame esterno, montato a paro, era assemblato da linguette lignee (tenoni) incavigliate all’interno di mortase, mentre l’ossatura presentava madieri e costole in alternanza, fissati al fasciame esterno con chiodi metallici o con caviglie in legno annegate.
Due elementi longitudinali paralleli (paramezzalini), collegati da traverse, assicuravano l’intera struttura sulla chiglia. All’interno dello scafo, serie di “serrette” (tavole di fasciame mobile per l’ispezione e la pulizia delle sentine) e “correnti” – per dar ulteriore rinforzo alla struttura esterna – costituivano la struttura del pagliolato; lamine in piombo, infine, erano utilizzate per apportare riparazioni allo scafo e per rivestire punti nevralgici.
La tecnica costruttiva sopra descritta ha avuto conferma in diversi ritrovamenti in tutto il “Mare Nostrum”, ultimo dei quali quello del relitto della nave di Marausa (TP) (III – IV sec. d.C.).
Quest’ultima è un reperto di eccezionale valore per la completezza dello scafo (ad eccezione delle estremità consunte dal tempo e dalle teredini) e la varietà del carico che portava, composto principalmente da varie tipologie di anfore africane chiuse da tappi di sughero, utilizzate per il trasporto di frutta secca (pinoli, nocciole, mandorle, pesche, fichi), olive e con ogni probabilità olio, vino e salsa di pesce o “garum” (come testimonierebbe all’interno dei contenitori la presenza di un tipo di resina); sono stati inoltre rinvenuti recipienti ceramici (coppe, coppette, coppe con base carenata, ampolline, piatti) e vetro.
Nelle costruzioni navali e nelle opere marittime ad esse collegate, cioè porti, moli, magazzini ecc. i Romani svilupparono una branca importante della loro maestria di architetti ed edificatori, con tecniche sofisticate ed innovative, sia nell'ingegneria navale, che nell'ingegneria marittima e costiera.
In tutte le coste del Mediterraneo e dell’Oceano costruirono nuovi porti marittimi e fluviali, ristrutturando e ampliando i vecchi con la costruzione di moli, dighe e scali, non solo seguendo i canoni descritti da Vitruvio nel suo trattato sull’architettura, ma creandone di nuovi.
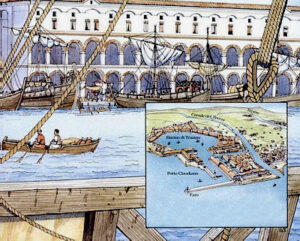
Ve ne sono ampie testimonianze su tutte le coste che appartennero all’impero romano, che tuttora custodiscono molti resti di porti e fari dell’antica Roma, in parte studiati e recuperati, in parte visibili solo sott'acqua, coperti dal mare per il lento fenomeno del bradisismo sul Tirreno che nasconde e mette a repentaglio opere d'arte incommensurabili.
La costa tirrenica è piena di moli, torri e resti di ville romane sulle spiagge, barbaramente distrutte dai vari palazzinari col beneplacito dello stato, o lasciate a a marcire sott'acqua per non salvare opere eccezionali come le ville imperiali di Posillipo.
Ma la maggior parte, ed è un bene, giace sepolta sotto terra o sotto le spiagge, perchè lo stato non reputa vantaggioso investire nell'archeologia, nonostante abbiamo un patrimonio apprezzato da tutto il mondo. Diciamo che è un bene perchè dall'Italia prendono il volo misteriosamente statue alte 4m e mezzo, che pesano svariate tonnellate e che svaniscono dai musei senza che nessuno sappia nulla, come se un visitatore se le fosse messe sotto braccio trafugandole in tal modo.
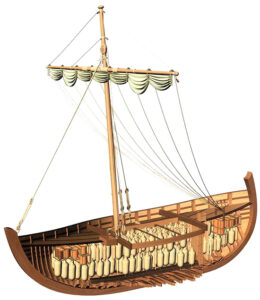
Fonte: ROMANO IMPERO
Carlo GATTI
Rapallo, 15 Gennaio 2023
LA STORIA DELLA NAVE DA CARICO VALFIORITA
LA STORIA DELLA NAVE DA CARICO
VALFIORITA
UNA VITA BREVE…
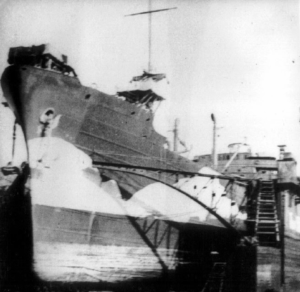

La Valfiorita Impostata nel 1939 nei cantieri Franco Tosi di Taranto in costruzione Varata il 5 luglio 1942 e completata il 25 agosto 1942 dalle Industrie Navali Società Anonima.
CARATTERISTICHE:
Motonave da 6200 tsl - lunga 144,47 metri - larga 18,65 - velocità 14-15 nodi.
UN PO’ DI STORIA…
Il 17 settembre 1942, la Valfiorita viene requisita dalla Regia Marina, per essere adibita al trasporto di rifornimenti per le truppe in Africa Settentrionale. La nave viene armata con un cannone da 120/45 e tre mitragliere contraeree Oerlikon da 20 mm. Per ostacolare la localizzazione della Valfiorita da parte di unità nemiche, viene installato anche un impianto nebbiogeno a cloridrina.
Eravamo in piena guerra per cui l’approvvigionamento di materiali ed attrezzature non era cosa facile. I metalli erano strategici e le priorità verso gli armamenti bellici erano maggiori.
Il 20 settembre 1942 la nave inizia a Taranto il carico di rifornimenti destinati alle forze italo-tedesche a Bengasi, prendono parte al viaggio in AS anche un centinaio di militari del Reggimento Cavalleggeri di Lodi.
Vennero imbarcate in tutto 4171 tonnellate di carico, comprendente 77 veicoli e 206 motociclette italiane, 95 veicoli tedeschi (moto comprese), 16 cannoni e 14 autovetture.
Il 3 ottobre, con i suoi 97 uomini di equipaggio (48 civili, tra cui 3 operai della Franco Tosi di Legnano, azienda produttrice dei motori, e 49 militari della Regia Marina), imbarcò anche 110 militari italiani del Reggimento Cavalleggeri di Lodi e 100 militari tedeschi. Sulla nave erano presenti due comandanti, il capitano di lungo corso Giovanni Salata (comandante civile) ed il capitano di corvetta Giuseppe Folli, comandante militare.
LA PARTENZA

Antonio Pigafetta (classe Navigatori)

Camicia Nera

Saetta
Con la scorta dei cacciatorpediniere Antonio Pigafetta, Camicia Nera e Saetta, la VALFIORITA prende il largo alle 15.10, ma solo a mezzanotte che fu dato l’allarme aereo.

Poco dopo in cielo esplosero i bengala che illuminarono il convoglio italiano che era stato segnalato da un Supermarine Spitfire, (foto sopra) aereo da ricognizione a lunga autonomia, sulla base delle intercettazioni delle informazioni fornite da “ULTRA”.


L’attacco inglese era composto da quattro Vickers Wellington (foto sopra) del 69th Squadron della Royal Air Force, armati sia di bombe che di siluri.
Il Vickers Wellington era un bombardiere medio bimotore inglese, realizzato sul finire degli Anni trenta; largamente impiegato nel corso della Seconda guerra mondiale, fu costruito in oltre 11.000 esemplari, caratterizzato dall'inusuale struttura geodetica, sviluppata dal celebre ingegnere ed inventore britannico Barnes Wallis, che garantiva al velivolo un'eccezionale robustezza, già sperimentata con il precedente Vickers Wellesley.
Caratterizzato dalla sigla interna Type 271, il velivolo fu inizialmente chiamato Crecy (dal luogo in cui si svolse una battaglia della guerra dei cent’anni. Il nome definitivo fu in onore del primo duca di Wellington che sconfisse Napoleone Bonaparte nella Battaglia di Waterlloo.
Riporto la cronaca dell’attacco tratta da Ocean for Future
L’attacco fu fulmineo, e nonostante l’uso di un pallone frenato e di una fitta cortina fumogena, raggiunse il suo scopo. I bombardieri Wellingtonattaccarono a motore spento da 1370 metri di quota, ed una bomba da 1000 libbre cadde a meno di 140 metri a poppavia della Valfiorita. Uno degli aerosiluranti, volando a bassissima quota, sganciò il suo siluro da 640 metri. Il siluro colpì la Valfiorita nella stiva numero 5, a poppa, facendo levare una fiammata rossastra ed aprendo una grossa falla attraverso cui l’acqua allagò le stive 5 e 6. La reazione della contraerea riuscì a danneggiarlo e costringerlo in seguito ad un atterraggio d’emergenza a Luqa. Sulla Valfiorita si scatenò il panico. A seguito del siluramento anche l’apparato fumogeno della nave rimase danneggiato ed il cloro venne disperso su ponte ferendo molti marinai. Nonostante gli effetti provocati dalla falla, causassero un rapido allagamento, esteso anche alla galleria dell’asse dell’elica, la motonave Valfiorita, proseguì il suo moto raggiungendo il mattino del 4 ottobre Corfù. Al fine di effettuare le dovute riparazioni fu quindi fatta incagliare ad una ventina di metri dalla costa. Nel frattempo i militari del Reggimento Cavalleggeri di Lodi vennero sbarcati e si accamparono presso il vicino villaggio di Potamòs, dove la popolazione soffriva di una gravissima carenza di cibo. Furono i militari italiani a condividere le loro razioni per permettergli di sopravvivere.
Sbarcati uomini e mezzi, solamente il 25 novembre 1942, dopo avere effettuato alcuni lavori, viene messa in condizioni di riprendere il mare, e raggiunge Taranto per i lavori di riparazione.
Terminati i lavori in bacino, a fine giugno 1943 la Valfiorita, ultimò anche le prove in mare e tornò in servizio.
Il 27 giugno 1943 il Comandante civile della motonave, il Capitano di lungo corso Giovanni Salata, chiede l’invio del materiale che mancava, specie delle 55 bombole di anidride carbonica dell’impianto antincendio, che erano state sbarcate per essere ricaricate dopo il siluramento dell’ottobre 1942 e non erano più state restituite. Furono inviate dieci bombole, ma il 7 luglio 1943 il Tenente di Vascello Giuseppe Strafforello, nuovo Comandante militare della Valfiorita dovette lamentare allo Stato Maggiore che le dieci bombole mandate erano inadatte all’impianto della Valfiorita, e che, come già aveva comunicato il comandante Salata il 2 luglio 1943, non c’erano altri mezzi antincendio a bordo della nave.
Sempre in data 7 luglio 1943, la nave in tarda serata, parte da Taranto in direzione Messina, sprovvista di ogni mezzo per spegnere qualsiasi focolare d’incendio, carica di mezzi, tra cui camion Fiat 626, moto, autoblindo e altri veicoli. L’equipaggio civile era composto da 45 uomini, mentre quello militare era composto da italiani e tedeschi. Arrivata a Messina, intorno alle 20,50 dell’8 luglio 1943, lascia il porto messinese in direzione Palermo, alle 22,30 giunta nello specchio di mare tra Capo Rasocolmo e Mortelle, viene fatta oggetto di attacco nemico da parte del sommergibile della Royal Navy HMS Ultor (P53) (foto sotto) agli ordini del Lt. George Edward Hunt DSC, RN.



L’unità britannica lancia quattro siluri, due dei quali colpiscono mortalmente la motonave. Distrutto il carteggio di bordo, i due comandanti civile e militare, danno l’ordine di abbandono della nave.
In soccorso dei naufraghi, oltre alla torpediniera di scorta “Ardimentoso”, accorsero da Messina le regie corvette Camoscio e Gabbiano (della stessa classe).
Su 45 civili e 22 militari (18 italiani e 4 tedeschi) che componevano l’equipaggio della Valfiorita, 13 civili persero la vita (dodici – soprattutto del personale di macchina – risultarono dispersi ed il direttore di macchina Pegazzano morì in ospedale) e 11 militari (7 italiani e 4 tedeschi) rimasero feriti.

Torpediniera di scorta ARDIMENTOSO in bacino di carenaggio a Genova

La classe Gabbiano (corvette) fu progettata e costruita durante la Seconda guerra mondiale dall’Italia Fascista per rimediare alla cronica deficienza, nella Regia Marina, di un'unità adatta ai compiti di scorta dei numerosi convogli verso la Libia. Dopo aver fatto fronte a questa necessità utilizzando le navi più disparate, dai cacciatorpediniere di squadra alle vecchie torpediniere della Prima guerra mondiale nel 1941 venne decisa la costruzione di sessanta unità delle corvette classe Gabbiano, adatte alla scorta dei convogli e alla caccia dei sommergibili nemici.
L’8 luglio 1943 la Valfiorita fu colpita alla prua da un siluro lanciato dal sommergibile HMS Ultor della marina britannica nel tratto di mare tra Messina e Palermo, affondò rapidamente quando si staccò il troncone di prua. La Valfiorita, nonostante la tragicità dell’avvenimento e per le vittime che ha trascinate sul fondo, rimane per i posteri uno dei più affascinanti relitti storici che si trovano al largo delle coste italiane e di tutto il Mediterraneo.
Infatti, non solo conserva ancora intatto tutto il suo carico (motocicli, auto e camion degli anni Trenta-Quaranta), ma si trova adagiata sul fondale in perfetto assetto di navigazione. A causa della notevole profondità, delle reti sul relitto e della forte corrente le immersioni subacquee possono essere effettuate solo da sub molto esperti.
La nave in navigazione da Messina per Palermo venne attaccata e silurata dal sommergibile Britannico Ultor l’8 Luglio del 1943, affonda spezzandosi in due tronconi. Il relitto giace su un fondo che va da 60 a 70 metri, per tre quarti in perfetta linea di navigazione, mentre la prua è riversa su un lato, con la coperta rivolta a NW. Per visitarla tutta sono necessarie almeno tre immersioni aperte solo a subacquei tecnici date l’elevata profondità e la durata. E’ possibile penetrare all’interno delle stive dove si trovano Jeep, motociclette, autocarri e munizioni. La nave è abitata da grandi cernie (Epinephelus marginatus), dentici (Dentex dentex), pauri (Sparus pagrus) e occasionalmente da astici (Homarus gammarus).
CONTRIBUTI
http://www.ocean4future.org/savetheocean/archives/22198
Immergersi sulla Valfiorita
La Valfiorita è uno dei più affascinanti relitti storici al largo delle coste italiane e di tutto il Mediterraneo. L’immersione nel blu, adatta a subacquei esperti, è ricca di emozioni. Inizialmente si intravede il castello, situato verso poppa, a circa 45 metri di profondità, poi lentamente si intravedono i resti della importante struttura distribuiti tra i 60 e i 72 circa.
Tra di essi, un’esperta subacquea tecnica, Isabelle Mainetti che ha raccontato in un suo articolo, corredato dalle foto di GianMichele Iaria la sua immersione sulla motonave Valfiorita. Non solo lamiere immerse nel buio e nel fango ma ricordi, forti emozioni che fanno rivivere quella terribile notte che abbiamo brevemente raccontato. Viene voglia di ritornarci … chissà.
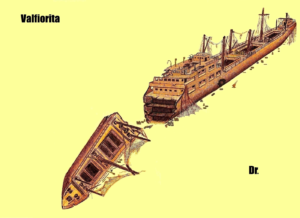
Il troncone centrale-poppiero giace in assetto di navigazione, mentre quello prodiero giace piegato sul lato sinistro, entrambi ancora carichi di esplosivi, munizioni e vari mezzi, a circa 70 mt di profondità.

Scendendo nella stiva ormai a cielo aperto appare tra il fango una mitica Balilla. Di seguito numerosi automezzi ancora perfettamente stivati, uno a fianco dell’altro, come in un garage.

L’altro pezzo della motonave si trova più avanti, a prua, spezzato di netto a circa un quarto della lunghezza della nave, mollemente adagiato sul fianco sinistro. In questo troncone si ritrovano due stive ancora contenenti casse di proiettili e materiali militari.
foto di GianMichele Iaria
Risalendo le strutture contorte o collassate, la plancia, le torrette che ospitavano le armi ormai strappate dalle loro strutture ed affondate negli abissi.
Questo il racconto di chi ha avuto la fortuna di visitare questo relitto, che giace ad una profondità non accessibile a tutti i sub. Non avendo avuto questa fortuna mi soffermo sulle loro parole, di quei subacquei che hanno sfidato le profondità alla ricerca di qualcosa che va oltre il relitto.


Una parte del relitto della VALFIORITA
Carlo GATTI
Rapallo, 26 Ottobre 2022
IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI
AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il REGENT, un sommergibile inglese costruito nel 1930, affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat (E' una provincia italiana della Puglia settentrionale che conta 391.556 abitanti. Il capoluogo è congiunto fra le città di Barletta, Andria e Trani), meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.
Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di una Unità militare italiana.
I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta.
PROPONIAMO DUE TESTIMONIANZE VIDEO (Splendide immagini) DEI SUB E DI STUDIOSI CHE HANNO RISOLTO IL DILEMMA

https://www.youtube.com/watch?v=8JV2FAfcNOE
https://www.youtube.com/watch?v=YwMn0MyOb2A
Nota: A volte viene usata la parola “sommergibile” altre volte “sottomarino”.
Rispetto al sottomarino, il sommergibile dispone di limitate capacità in immersione e non è in grado di operare per periodi prolungati al di sotto della superficie dell'acqua. Per molti aspetti si ritiene quindi che il sommergibile rappresenti il predecessore dei più moderni sottomarini.
Nel periodo fra le due guerre poche sono le innovazioni tecniche sostanziali apportate al sommergibile, ormai evoluto. Oltre all'irrobustimento dello scafo, reso idoneo a scendere sotto i cento metri, al miglioramento delle sistemazioni di salvataggio e dall'adozione di telecomandi oleodinamici.
Rilevante é lo studio di un'importante apparecchiatura che, utilizzata realmente solo a partire dalla metà della Seconda G.M. rimarrà poi strumento fondamentale per il moderno sottomarino a propulsione convenzionale: lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.
UN PO’ DI STORIA … L’autore si è concesso la riduzione personale dell’ampia versione del Quadro Storico in cui operarono i nostri sottomarini nella Seconda guerra mondiale.
MINISTERO DELLA DIFESA


Lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.
L'invenzione dello snorkel viene generalmente attribuita ai tedeschi, che per primi lo impiegarono in guerra, sul finire del 1943; i più informati ne fanno risalire l'origine agli olandesi, che lo istallarono sui loro battelli della classe "O" negli anni fra il '37 ed il '40.

In realtà, lo snorkel è un’invenzione italiana. Fu, infatti, il Maggiore del Genio Navale Pericle Ferretti (nella foto) a condurre i primi studi, intorno al 1920, presso l'Arsenale di Taranto. Egli stesso, poi, realizzò un prototipo che nel 1925 fu felicemente sperimentato sul Smg. "H3" (uno dei battelli acquistati in Canada durante la 1^ G.M.).
Sotto la spinta degli eventi politici mondiali, la produzione di Smg viene intensificata a tal punto che, nel 1940, la Marina italiana entra in guerra con 115 sommergibili: una delle maggiori flotte subacquee del mondo.
Le prestazioni dei sommergibili italiani vengono vieppiù migliorate. Aumenta l'autonomia, che nei battelli oceanici raggiunge le 20.000 miglia, così come l'armamento (fino a 14 tubi di lancio e 40 siluri). Il siluro si perfeziona e diventa più affidabile. La quota massima scende oltre i 130 metri. La velocità in superficie raggiunge i 20 nodi. Per il combattimento in superficie, al cannone si aggiungono mitragliere antiaeree.
Fino al 1942 il successo dell'offesa sottomarina è elevatissimo. I battelli italiani, che prima della costituzione della base a Bordeaux ("Betasom") dovevano forzare lo stretto di Gibilterra, vengono di norma impiegati isolatamente nell'Atlantico centrale e meridionale, dove il traffico è meno intenso e fortemente scortato. Ciò nonostante, i risultati non mancano: quasi 600 mila tonnellate di naviglio affondato con un "exchange rate" (ossia, il rapporto fra tonnellate di naviglio affondato e battelli perduti) praticamente uguale per entrambe le Marine.
Dopo il 1942, la crescente efficacia della lotta "antisom" sovverte le sorti della guerra subacquea. Sono soprattutto il radar e l'uso intensivo dell'aereo a contrastare il sommergibile, che risulta sempre più vulnerabile, specialmente in superficie. Si adottano, così, nuove misure, come la riduzione del volume delle sovrastrutture e la revisione dei criteri d'impiego e delle tattiche operative. Alcuni battelli oceanici vengono ritirati dalla linea ed adattati al trasporto. I tedeschi ricorrono allo snorkel ed approntano una sorta di intercettatore di onde radar.
Ormai, però, il sommergibile non riesce più ad ottenere i risultati di prima, mentre le perdite si fanno più ingenti, fino a superare il numero di navi affondate. Alla data dell'8 settembre 1943, la forza subacquea italiana, che nel corso del conflitto aveva acquisito fino a 184 battelli, è ridotta a 54 unità, delle quali soltanto 34 sono in grado di muovere; queste, in base alle clausole d'armistizio, passano ad operare con gli Alleati con funzioni prevalentemente addestrative e, alla fine della guerra, vengono demolite o consegnate ai vincitori in conto riparazioni di guerra.
Dati riepilogativi relativi ai sommergibili italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale
Missioni svolte |
1750 |
Miglia compiute |
2.500.000 |
Giorni in mare |
24.000 |
Attacchi svolti |
173 |
Siluri lanciati |
427 |
Naviglio Mercantile affondato |
132 (665.317 tons) |
Naviglio Militare affondato |
18 (28.950 tons) |
|
|
|
Sommergibili italiani affondati
Mare Mediterraneo |
Altri settori |
88 |
40 |
Giovanni BAUSAN (ITA)
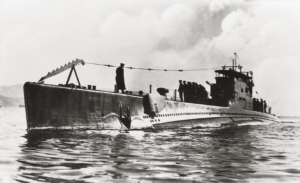
Sottomarino d’attacco costiero (di media crociera) della classe Pisani (dislocamento di 880 tonnellate in superficie e 1058 in immersione). Durante il suo brevissimo periodo di servizio attivo nella seconda guerra mondiale (poco più di un mese) svolse 3 missioni offensive/esplorative e 5 di trasferimento, percorrendo complessivamente 2593 miglia in superficie e 198 in immersione. Dal gennaio all’ottobre 1941 effettuò poi 90 uscite addestrative in Alto Adriatico per la Scuola Sommergibili di Pola.
Dislocamento: 800 t in emersione – 1057 t in immersione
Lunghezza: 68,2,mt – Larghezza: 6,09 mt – Pescaggio: 4,93 mt
Velocità in immersione: 8,2 nodi Velocità in emersione: 15 nodi
Profondità op. 90 mt
Equipaggio: 48
LA CARRIERA DEL BAUSAN
Il sommergibile, intitolato a Giovanni Bausan, valoroso combattente della marineria napoletana nato a Gaeta il 14 aprile 1757, dopo l'entrata in servizio fu assegnato alla V Squadriglia Sommergibili di Media Crociera, con sede a Napoli, ricevendo a Gaeta la Bandiera di Combattimento, offerta dalla comunità locale, il 14 novembre 1929.
Tra i suoi primi comandanti vi fu il Capitano di Corvetta Giovanni Marabotto.
Nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 1932, durante un viaggio addestrativo, il Bausan andò ad incagliarsi alle Isole Mormorato (vicino a Punta Falcone, nelle Bocche di Bonifacio. L'unità fu tuttavia in grado di disincagliarsi senza bisogno dell'assistenza di altre unità.
Dal 7 dicembre 1935, al comando del tenente di vascello Ferruccio Ferrini, fu assegnato alla II Squadriglia del VI Grupsom di Lero.
Nel gennaio-febbraio 1937 svolse un'infruttuosa missione (non furono avvistate navi sospette) nel corso della Guerra di Spagna. Dal 10 al 13 giugno 1940 effettuò (agli ordini del capitano di corvetta Francesco Murzi) una prima missione di guerra al largo di Malta; il 13 giugno, in fase di rientro ad Augusta, fu avvistato al largo di Capo Santa Croce dal sommergibile britannico Grampus, che gli lanciò un siluro; il Bausan lo schivò con una manovra evasiva.
Dal 20 al 24 giugno svolse una seconda missione al largo di Capo Kio, ma dovette fare ritorno per via di un guasto ai timoni di profondità di prua.
La terza missione – dal 14 al 21 luglio, tra Pantelleria e Capo Bon, dovette essere anch'essa interrotta per un guasto ai motori.
In tutto aveva compiuto, sino a quel momento, 3 missioni offensive e 5 di trasferimento, per un totale di 2791 miglia di navigazione (2593 in superficie e 198 in immersione); fu quindi assegnato alla Scuola Sommergibili di Pola.
Svolse attività addestrativa dal 1º gennaio all'8 ottobre 1941 per un totale di 90 missioni, dopo di che, il 18 maggio 1942, fu messo in disarmo e convertito in bettolina carburanti con il contrassegno GR. 251.
RADIATO il 18 ottobre 1946 fu quindi avviato alla demolizione.
HMS REGENT (UK)
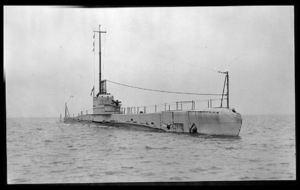
Dislocamento: in emersione 1.475 t – in immersione 2,030 t
Lunghezza:…. 87,5 mt – Larghezza: 9,12 – Pescaggio: 4,9 – Profondità operativa: 95 mt
Propulsione: 2 motori diesel da 4.640 hp, due motori elettrici da 1670 shp
Velocità in immersione: 9 nodi - Velocità in emersione: 17,5 nodi
Equipaggio: 53 uomini
Artiglieria: 1 cannone-102/40 mm–2 mitragliatrici-12,7 mm–8 tubi lanciasiluri da 533 mm
La classe di sottomarini della Royal Navy Britannica: Rainbow o classe R era composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1930 e il 1932.
Battelli a lunga autonomia progettati per operare nei mari dell’Estremo Oriente, rappresentavano l'ultimo sviluppo del progetto iniziato con i classe Odin e proseguito con i classe Parthian. Negli anni della Seconda guerra mondiale i Rainbow operarono principalmente nel teatro del Mar Mediterraneo, dove tre di essi furono perduti per cause belliche; l'unico superstite della classe, attivo anche nel teatro bellico dell’Oceano Indiano. Durante la seconda parte del conflitto, fu radiato e avviato alla demolizione nel 1946.
HMS Regent |
19 giugno 1929 |
Vickers-Barrows Armstrong in Furness |
11 giugno 1930 |
11 novembre 1930 |
perduto in mare in una data imprecisata compresa tra il 12 aprile e il 1º maggio 1943, probabilmente caduto vittima di una mina nell’Adriatico meridionale |
LA CARRIERA DEL HMS REGENT
Era il 18 aprile del ’43, gli abitanti di Bisceglie (Barletta) sentono un enorme esplosione proveniente dal largo: con molta probabilità essa segnò la fine del sottomarino inglese REGENT entrato in collisione con una mina galleggiante ed affondato senza superstiti. Era partito il 12 aprile da Malta (La Valletta) per il canale di Otranto. La sua carriera era iniziata con un’impresa da film d’azione. Nei primi giorni di guerra era penetrato nel porto di Cattaro, attraccando senza problemi e sbarcando un ufficiale per chiedere la liberazione dell’ex Ambasciatore inglese a Belgrado. Costretto alla fuga, se n’era andato… portandosi via un militare italiano. Il 5 ottobre del ’40 c’è il primo affondamento, anche se la preda non è eclatante: un vascello a vela (probabilmente un peschereccio), il Maria Grazia di 188 tonn. Quattro giorni dopo danneggia il mercantile Antonietta Costa, il 15 gennaio ’41 affonda il Città di Messina (2472 tonn), il 21 febbraio danneggia il mercantile tedesco Menes 5600 tonn., il 1° agosto affonda il dragamine italiano Igea, il 1° dicembre danneggia un altro mercantile italiano: l’Enrico.
Quattro mesi dopo, la fine. Ora il suo scafo squarciato giace su un fondale sabbioso a – 28 mt. In https://uboat.net/allies/warships/3406.html così viene descritta la sua fine: HMS REGENT (Lt.Walter Neville Ronald Knox,DSC,RN) sailed from Malta on 12 April 1943 to patrol in the southern Adriatic. She was mined north of Barletta, Puglia, Italy on 18 April 1943. That evening a large explosion was heard in that area, wich is believed to have been HMS Regent striking a mine. HMS Regent was reported overdue at Beirut on 1st May 1943. The wreck of Regent has been found and lies in 28 meters of water”.
Quanto è stato scritto sopra sono le versioni rilevate da fonti ufficiali che risalgono alla fine del conflitto. Oggi, a quanto sembra, il MARE STA RESTITUENDO ALCUNE VERITA’ CHE SONO SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEGLI STUDIOSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.
CORRIERE DELLA SERA – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO –
Il 18 luglio 2022 Luca Pernice scrive:
Barletta, il relitto non è il sottomarino inglese Regent ma l’italiano Bausan: la scoperta di un team di Foggia
I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.


Sin dal 1943 si è creduto che il relitto del sommergibile che giace a 37 metri di profondità nell’Adriatico, al largo di Barletta, fosse quello del Regent, affondato appunto nel 1943. Fino a quando un team foggiano, composto da sub e storici, ha scoperto che in realtà si tratta di un sommergibile italiano, il Giovanni Bausan.
Una storia iniziata nell’aprile 1943
La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il Regent, un sommergibile inglese costruito nel 1930 affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat, meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di un mezzo italiano.
Il team e lo studio
Un team composto da tre sommozzatori – Michele Favaron, Stefania Bellesso e Fabio Giuseppe Bisciotti – da personale addetto all’assistenza di superficie – Alessandro Auliclino e Pietro Amoruso – da due piloti – Pasquale Bailon e Ruggero Nanula – e da Giuseppe Iacomino che ha curato l’assistenza storica del progetto.
«Dai dati in nostro possesso – spiega Fabio Giuseppe Bisciotti – sono subito emersi dubbi su quanto potesse essere veritiera la teoria del sommergibile inglese. Nelle foto esistenti del relitto si evince la assoluta incompatibilità di ciò che le foto mostrano con il design di un sommergibile britannico classe R quale il Regent. In particolare, oltre alle dimensioni totalmente differenti, vi è la presenza di una bombatura sul piano di calpestio del sommergibile del tutto assente in qualsiasi piano costruttivo e fotografia riguardanti il mezzo navale in questione. Dopo una lunga ricerca poi siamo giunti al ritrovamento del tassello più importante al riguardo». Bisciotti e il suo team, infatti, è in possesso di una documentazione che comproverebbe la presenza, nel porto di Barletta, di un sommergibile Italiano, classe Pisani, di nome “Giovanni Bausan”. Al momento della radiazione, fu ribattezzato GRS 251 ed usato come cisterna carburante sino all’arrivo degli alleati in Puglia. Dopo il 1943 il sommergibile venne usato come target notturno per gli aerei inglesi e americani per addestramento. Nel 1944, al termine del periodo di training, fu affondato. “Siamo certi – conclude Bisciotti - che il Bausan attualmente si trovi a circa 33 metri sul fondo del mare al largo di Barletta. E’ il relitto che per molti anni tutti hanno pensato, erroneamente, fosse quello del Regent”.
Carlo GATTI
Rapallo, 10 ottobre 2022
LA BARCA DI ERCOLANO
LA BARCA DI ERCOLANO
Noi siamo la nostra memoria,
noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti,
questo mucchio di specchi rotti.
(Jorge Luis Borges)
Ricostruzione Virtuale
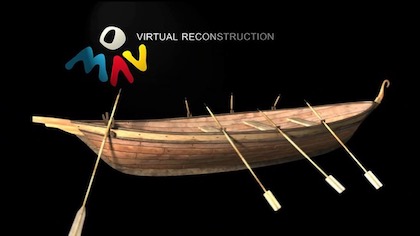
La scoperta del relitto, noto come LA BARCA DI ERCOLANO, avvenne il 3 agosto del 1982. L’idea di cercare reperti archeologici nella sabbia vulcanica dell’antica spiaggia fu del direttore degli scavi Giuseppe Maggi. Proprio in quel sito, presso i magazzini a ridosso della spiaggia, furono ritrovati oltre 300 scheletri di fuggiaschi ercolanesi i quali, all’interno di quelle robuste arcate abituate a respingere i marosi, si erano rifugiati con l’intento di fuggire alle ire del Vulcano e con la speranza che arrivassero soccorritori a bordo di gozzi di pescatori locali come quello rinvenuto proprio in quel sito. Forse, proprio su questo pensiero si basò l’intuizione del MAGGI.
Purtroppo, riportiamo: “I fuggiaschi furono sorpresi nel cuore della notte dall’arrivo della prima nube di gas roventi, il surge, che, con una temperatura di oltre 400° e una velocità di 80 chilometri orari, raggiunse la città e provocò la morte istantanea per shock termico di tutti gli abitanti. L’arrivo delle ondate di fango vulcanico dal Vesuvio ricoprì poi i resti dei loro corpi, sigillandoli nella posizione in cui si trovavano al momento della morte. Fra gli altri, fu trovato il corpo di una giovane incinta e prossima al parto, dalla quale furono recuperati i resti di un feto di circa otto mesi. I fuggiaschi avevano portato con sé lucerne per illuminare l’oscurità, chiavi di casa, amuleti, strumenti di lavoro, gruzzoli di monete.
Una donna i cui resti erano riccamente adorni di orecchini, anelli e bracciali è stata soprannominata la “Signora dei gioielli”.
(vedi foto sotto)




Nel giorno del ritrovamento della “BARCA DI ERCOLANO”, fu la chiglia ad emergere per prima. L’imbarcazione era stata completamente capovolta dalla strapotenza dei flussi piroclastici che l’avevano sepolta e nello stesso tempo protetta da una “coperta” di vari materiali vulcanici che, induriti velocemente, assorbirono l’ossigeno residuo e ne conservarono l’ossatura fino ai giorni nostri.
“La barca era stata danneggiata da grandi travi cadute dai tetti e dai solai delle case di Ercolano, che sfondarono la chiglia e piegarono il fasciame restando incastrate. La barca era lunga oltre nove metri con una larghezza di 2,20 e un’altezza massima di circa 1 metro dalla chiglia al bordo”.
Ci racconta la guida:
“Dopo le prime fasi di scavo della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei, la barca è stata rivestita da uno strato di gomma sul quale poi è stata applicata della vetroresina. Si è creato così un guscio che ha permesso di contenere i resti carbonizzati ed evitare il pericolo del collasso della struttura dell’imbarcazione. All’interno conteneva ancora il riempimento di fango e pesava circa 40 quintali.
La conclusione della prima fase del restauro della barca (realizzato con i fondi del Programma Operativo Regionale Campania 2000-2006) permise così di aprire al pubblico uno dei reperti simbolo dell’antica città e di esporre, per la prima volta, una serie di oggetti collegati al mare e alle attività marinare.
Una serie di prelievi di campioni di legno da varie zone della barca, compiuti durante i lavori di recupero, hanno permesso di individuare i legni utilizzati per la sua costruzione: legni di pino, ontano, faggio e quercia.
Ancora oggi vengono usati gli stessi legni per costruire i gozzi di tutta la penisola italiana.
L’intervento di restauro del 2008 ha previsto il taglio del guscio esterno in vetroresina e la rimozione dello strato di gomma siliconica messo a protezione dello scafo.
È stato poi realizzato lo scavo del deposito vulcanico che ancora riempiva parte dello scafo. Si è quindi proceduto al delicato lavoro di pulizia del legno e al riposizionamento e micro incollaggio dei frammenti e alla stuccatura delle lesioni. Nel contempo è stata realizzata una pulitura meccanica dei chiodi in bronzo. Per ricollocare le parti distaccate sono stati fabbricati supporti in vetroresina colorati.
Questo intervento ha permesso di giungere a una prima esposizione dell’eccezionale reperto, in attesa che con il completamento dei lavori di restauro si ricollochino nella corretta posizione le parti di fasciame ripiegate e asportate dalla violenza dell’impatto durante l’eruzione”.
ESTERNO

Per proteggere la barca gli operai costruirono in fretta un capannone in muratura e lamiera mentre si cercava di estrarre quanto più fango possibile per portare alla luce dati e reperti. Si recuperarono cime spezzate, aghi, cipolline, pettini in bronzo, un cestino di vimini ed altro ancora trasportato chissà da dove dal fango vulcanico.
INTERNI



Grazie al National Geographic, Ercolano faceva notizia nel mondo e intanto, ad esaminare la barca, giungeva nella cittadina vesuviana uno dei maggiori esperti di archeologia navale: J.Richard Steffy dell’Institute of Nautical Archaeology del Texas. Il reperto veniva confermato come un’imbarcazione di nove metri in buono stato di conservazione tranne per un notevole schiacciamento al centro che se non restaurato in tempi brevi avrebbe sicuramente portato dei rischi enormi per la conservazione.

Il restauro è stato effettuato progettando e realizzando un telaio ruotante in ferro per riportare la barca nella giusta posizione. Dopo essere stata ribaltata e parzialmente svuotata all’interno, è stata trasferita nell’area destinata alla futura musealizzazione. Una serie di prelievi di campioni di legno da varie zone della barca, compiuti durante i lavori di recupero, hanno permesso di individuare i legni utilizzati per la sua costruzione: legni di pino, ontano, faggio e quercia.
L’intervento di restauro del 2008 ha previsto il taglio del guscio esterno in vetroresina e la rimozione dello strato di gomma siliconica messo a protezione dello scafo.
LA STRUTTURA DELLA BARCA DI
ERCOLANO
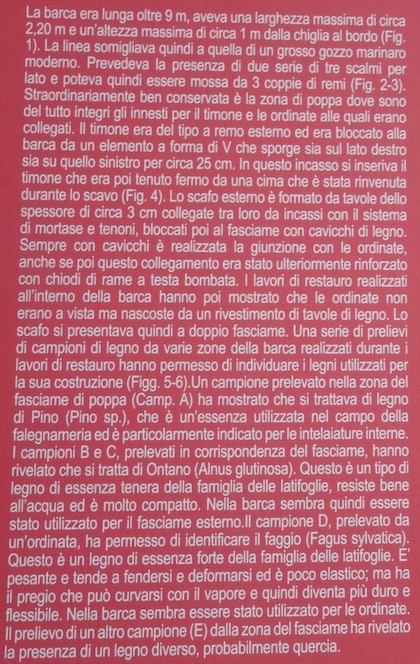
ALBUM FOTOGRAFICO
PARTICOLARI TECNICI
DELLA MARINERIA DI 2.000 ANNI FA


LA BARCA DI ERCOLANO ERA DESTINATA - CON TUTTA PROBABILITA’ - ALLA PESCA
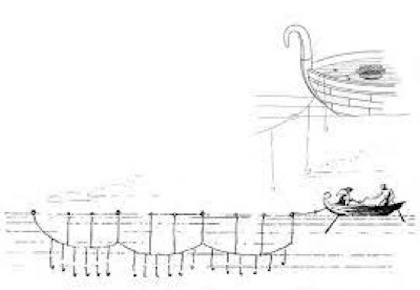
Secondo gli studiosi la struttura prevedeva la presenza di tre scalmi per lato e poteva essere manovrata da tre coppie di remi. Diversi furono i reperti trovati assieme alla barca e sepolti nel fango. Fra questi la punta di una prua che si è conservata in maniera eccezionale con le tracce di colore con cui era stata dipinta, il rosso cinabro, e perfino un minuscolo salvadanaio in legno con coperchio scorrevole con dentro una monetina d’argento e una di bronzo con il volto di Vespasiano.

LA COSTRUZIONE NAVALE DELL’EPOCA
Completamente diverso dal procedimento attualmente in uso nel Mediterraneo che prevede la messa in opera, sulla chiglia, dell’ossatura interna e il suo rivestimento con tavole di fasciame, in età Greco-Romana, dopo aver sistemato la chiglia, veniva costruito il guscio esterno costituito dal fasciame mentre l’ossatura era inserita successivamente con una funzione di rinforzo interno, detta: costruzione su guscio. Il collegamento tra le tavole del fasciame avveniva coi tenoni, linguette in legno duro inserite in appositi incassi (le mortase) nello spessore delle tavole. I tenoni, infine, erano bloccati da spinotti. In questo modo, le tavole del fasciame potevano mantenere la forma desiderata e il guscio acquistava eccezionale solidità grazie ai numerosi collegamenti interni.
Le navi Romane erano più larghe dell'usuale, spesso oltre un quarto dell’intera lunghezza, per consentire anche in caso di sbarco in terra nemica di accostarsi molto alla riva, oppure di scaricare più rapidamente le merci.

Interno dello scafo
Come abbiamo già visto, la scoperta della barca di Ercolano avvenne il 3 agosto del 1982 quando nella zona davanti alle Terme Suburbane iniziò a emergere dall’interro vulcanico la chiglia di una barca rovesciata dalla furia dell’eruzione. Questa era stata sepolta dai flussi piroclastici rimanendo sigillata nella coltre di materiali vulcanici che si indurì rapidamente garantendo, con la mancanza di ossigeno, la conservazione dei legni.
La barca era lunga oltre 9 m, aveva una larghezza massima di circa 2,20 m e un’altezza massima di circa 1 m dalla chiglia al bordo. La linea somigliava quindi a quella di un grosso gozzo marinaro moderno. Prevedeva la presenza di tre scalmi per lato e poteva quindi essere mossa da tre coppie di remi.
Lo scafo esterno è formato da tavole dello spessore di circa 3 cm collegate fra loro da incassi con il sistema di mortase e tenoni, uniti poi al fasciame con cavicchi di legno. Sempre con cavicchi è realizzata la giunzione con le ordinate, anche se poi questo collegamento era stato ulteriormente rinforzato con chiodi di rame a testa bombata.
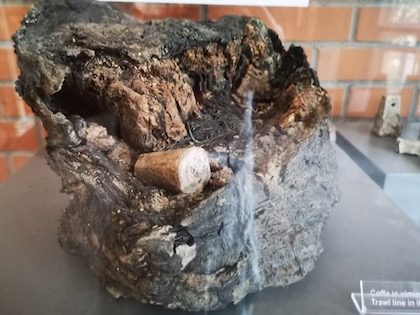
Cestino che contiene un amo e un verricello

I remi della barca di Ercolano
La barca, inoltre, era dotata di un timone esterno a remo che era bloccato da una cima ritrovata (foto sotto) durante le operazioni di estrazione dal fango, impresa non semplice perché, proprio come racconta Maggi nel suo libro “Ercolano. Fine di una città”, da un saggio piccolo che si era aperto all’inizio dello scavo si era passati ad una specie di voragine che pullulava di corpi da salvaguardare. Il tempo a disposizione era poco e i fondi erano finiti.


Cima adugliata

SONO PASSATI SOLTANTO 2.000 ANNI…
MA NON SEMBRA …
Ho recuperato alcune foto di gozzi moderni che, con qualche modifica “regionale”, appaiono simili a quello recuperato a Ercolano. Giudicate voi…


GOZZI MODERNI CON TRE SCALMI E REMI

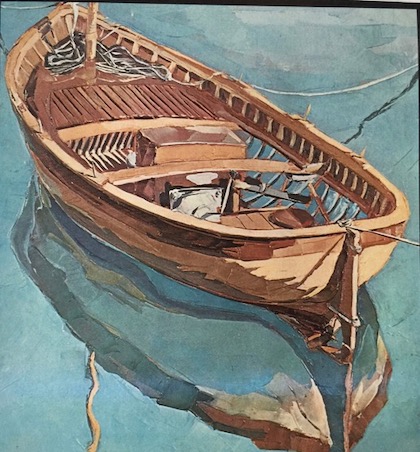
Elementi costruttivi dello scafo in legno
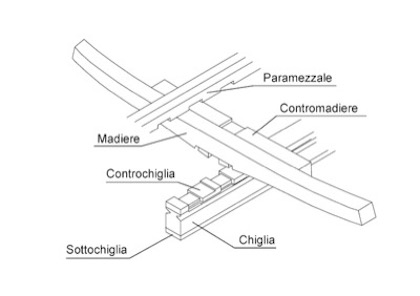
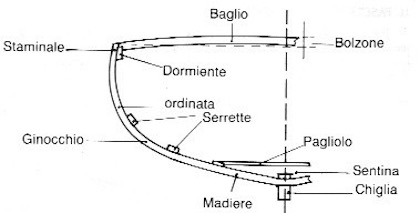
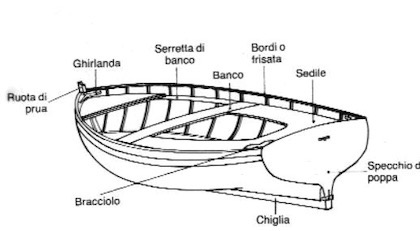

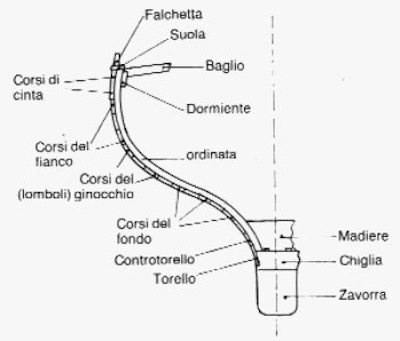
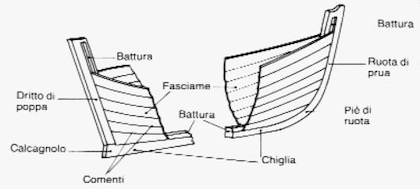
Questi disegni mostrano la sezione trasversale di una nave in legno moderna che è molto simile a quella romana antica. I termini navali delle varie parti sono rimasti sorprendentemente invariati nel tempo.
Ad esempio il vocabolo paramezzale, cioè l’ossatura longitudinale del fondo, deriva dal greco e significa: “quasi in mezzo” per indicare la sua posizione vicino al centro dello scafo. Il vocabolo prora è rimasto uguale a quello usato dai greci e che, come per noi, indicava la parte anteriore della nave. La parola costola, ossatura trasversale del fianco, deriva dal latino costa per indicare la sua somiglianza con l’osso del torace.
CONCLUSIONE
I romani realizzarono una successione di fari posti in vista l’uno dell’altro su tutte le coste del Mediterraneo; questi fari avevano anche lo scopo di inviare dei messaggi a grande distanza attraverso segnali di fumo o di fuoco, impiegando un codice simile all’alfabeto Morse.
Utilizzando questo sistema, i pompeiani richiesero aiuto a Plinio il Vecchio, ammiraglio della flotta imperiale romana di stanza a Capo Miseno, durante l’eruzione del Vesuvio nel 79 d. c.
Da Capo Miseno – Plinio - da naturalista qual’era, aveva già osservato e descritto un’immensa nube incandescente a forma di pino sopra il vulcano e, quando gli giunse la richiesta di aiuto, accorse prontamente con delle navi veloci. Egli attraversò tutto il golfo di Napoli, che era sconvolto dal mare agitato e dalla caduta di una pioggia di pietra pomice, fino a giungere a Pompei.
Durante questa spedizione Plinio perse la vita, ma le sue navi riuscirono a salvare un certo numero di pompeiani.
Dopo l’eruzione comparvero due monti distinti che caratterizzano il golfo di Napoli: il monte Somma e l’attuale Vesuvio.

L’attuale faro di Capo Miseno (nella foto) è ubicato dove sorgeva quello dei tempi di Plinio e dell’imperatore Tiberio, che risiedeva a Capri e che comunicava direttamente con Roma attraverso il sistema di segnali di fuochi prima descritto.
Carlo GATTI
Ringrazio l’amica Prof. Marinella Gagliardi Santi che mi ha inondato di materiale fotografico del Museo della BARCA DI ERCOLANO.
Sappiamo quanto le zone archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata siano state fonti ispiratrici per i suoi pregiatissimi libri!
Rapallo, 30 Agosto 2021