AFFONDAMENTO DEL FRANCESCO CRISPI
AFFONDAMENTO DEL FRANCESCO CRISPI
ACCADDE 75 ANNI FA
943 Le Vittime

FRANCESCO CRISPI - Ts.l. 7.600 – Costruito: Muggiano – 1925
UN PO’ DI STORIA
A norma di quanto disposto dal D.M. Il 13 novembre 1931, la CITRA fu incorporata nella “FLORIO”, che assunse la nuova denominazione di “TIRRENIA” FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA.
Nel 1937 fu trasferita da Flotte Riunite Florio-Citra al Lloyd Triestino. Requisita nel 1941 dalla Regia Marina e successivamente dal Ministero delle Comunicazioni.
Il 19 aprile 1943, a poche miglia dall'Isola d'Elba, tre siluri lanciati dal sommergibile inglese HMS SARACEN colpivano e affondavano il piroscafo del Lloyd Triestino FRANCESCO CRISPI mentre trasportava circa 1000 soldati italiani verso la Corsica. Perirono 943 persone fra i quali la maggior parte apparteneva ai Granatieri di Sardegna. Per molti giorni a seguire il relitto della nave restituì cadaveri che le correnti marine trasportarono fin sulle coste liguri. Una tragedia nella tragedia. La vigilia di Ferragosto dello stesso anno il sommergibile inglese HMS SARACEN fu inseguito dalle corvette della Regia Marina MINERVA ed EUTERPE che con il lancio di numerose bombe di profondità lo costrinsero prima ad emergere e poi lo affondarono a sole dieci miglia dal punto in cui aveva colpito il CRISPI.
L'ingegner Guido Gay, noto per aver ritrovato la Corazzata ROMA, grazie al suo ROV "Pluto Palla", riporta ora la luce sui relitti del piroscafo FRANCESCO CRISPI e del sommergibile HMS SARACEN e sulle loro lamiere contorte è scritta una tragica storia di 75 anni fa.
Finché visse mio nonno materno Filippo Machì, il nome della nave passeggeri FRANCESCO CRISPI rimbalzò spesso a ondate ricorrenti tra le pareti di casa nostra con la stessa tristezza che in genere si avverte per la perdita di un congiunto. Per molti imbarchi era stata la sua nave, la sua casa, i suoi amici, il suo lavoro da macchinista che gli aveva permesso di aprire, ormai da pensionato, una trattoria ubicata nelle vicinanze della cattedrale S. Lorenzo a Genova, riuscendo a dare alla numerosa famiglia un lavoro sicuro ed una clientela di noti Ufficiali e Comandanti del mondo dello shipping di allora.

Mio nonno Filippo a destra nella foto con al fianco il suo primogenito C.l.c. Elia Ufficiale di coperta e tutta la sua famiglia.

Bomba inesplosa nella Cattedrale di San Lorenzo a Genova


Ecco cosa rimase di quel quartiere di Genova…
Il 9 febbraio del 1941 Genova subì il suo primo ed unico pesante bombardamento navale da parte della flotta britannica: un evento bellico che, per le sue varie implicazioni di carattere politico e militare, e soprattutto psicologiche, segnò una svolta nell’andamento del conflitto. Per la prima volta, infatti, una grande città della penisola veniva scelta come obiettivo strategico da un avversario deciso a piegare la volontà di resistenza non soltanto del regime, ma anche della popolazione civile italiana.
“Giunte a circa quindici miglia da Genova, la Malaya e la Renown misero in posizione le torri prodiere e alle 8,12 i loro pezzi pesanti aprirono il fuoco, seguiti poco dopo da quelli di medio calibro dello Sheffield. Il bombardamento colse la città al suo risveglio e durò in tutto poco più di mezz’ora. La Malaya concentrò il suo fuoco sui bacini e sul porto, mentre la Renown e lo Sheffield bersagliarono l’area industriale. Complessivamente, le due corazzate spararono 272 colpi da 15 pollici e 400 da 4,5 - mentre lo Sheffield ne lanciò 782. Alcuni colpi da 381 della Malaya centrarono ed affondarono quattro mercantili e la nave-scuola Garaventa (la corazzata Duilio rimase invece indenne), danneggiando leggermente altre 18 unità. Uno dei giganteschi proiettili da 381 della Malaya perforò il tetto della cattedrale di San Lorenzo, ma fortunatamente non esplose, andandosi a conficcare alcuni metri sotto il pavimento, mentre altri centrarono la zona di Piazza Cavour. Ulteriori bordate colpirono alcuni edifici del centro, tra i quali il palazzo dell’Accademia e il primo stabile di sinistra all’inizio di Via Roma. La popolazione genovese pagò l’indubbia audacia dell’azione britannica con 144 morti, circa 200 feriti e ingentissimi danni”.
Il ristorante di mio nonno fu colpito e distrutto mentre i miei zii lo stavano raggiungendo per la consueta apertura. Al momento dell'esplosione si trovavano soltanto a poche decine di metri dal luogo dell'impatto; rimasero feriti ma si salvarono gettandosi d’istinto in un vicolo adiacente che gli fece da scudo quasi completamente.
Oggi, in quel sito di Via David Chiossone,
é ubicato il rinomato ristorante:
"LA BUCA DI SAN MATTEO"
Si salvarono fortunosamente anche gli altri componenti della famiglia ma perdettero le loro abitazioni e quasi tutti finirono all’ospedale per fratture multiple, ossa schiacciate, escoriazioni e contusioni varie; non ebbero il tempo di piangere su quelle macerie perché dovettero rimboccarsi le maniche per non morire di fame. Mio nonno era già anziano ma possedeva un’antica tempra di lottatore e, grazie ai suoi trascorsi professionali, riuscì ad imbarcare ancora una volta sul FRANCESCO CRISPI insieme al suo secondo genito che era Ufficiale di coperta.
Quell’imbarco fu molto lungo e pericoloso perché nel frattempo la nave era stata militarizzata, come abbiamo già visto, e destinata a trasportare truppe tra le sponde del Mediterraneo.
Ma questa volta il buon Dio ebbe pietà di loro … e fece in modo che padre e figlio sbarcassero 10 giorni prima che la FRANCESCO CRISPI venisse affondata dal sottomarino inglese SARACEN. Sbarcarono in tempo per raggiungere la loro famiglia che nel frattempo si era trasferita in collina (S.Agostino) a Rapallo.
Questa é soltanto una “piccola” storia famigliare tra le tante che sono state vissute dagli italiani più fortunati...
Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo dedicato 60 articoli ai naufragi importanti ed anche a quelli dimenticati per i quali, ancora oggi, siamo giornalmente sommersi di richieste di notizie da parte di famigliari delle vittime. Queste persone meriterebbero l’attenzione del Governo e degli storici. Noi ci siamo assunti soltanto l’onere di tenere vivi quei ricordi per consegnarli alle nuove generazioni affinché non vengano dimenticati quei morti e le cause che li fecero sprofondare negli abissi del nostro mare.
IL SILURAMENTO DELLA FRANCESCO CRISPI
Proprio in questi giorni ricorre il 75° anniversario dell’affondamento del FRANCESCO CRISPI.

Il FRANCESCO CRISPI felicemente ormeggiato in banchina
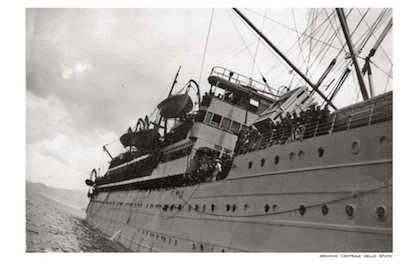
Suggestiva immagine del FRANCESCO CRISPI
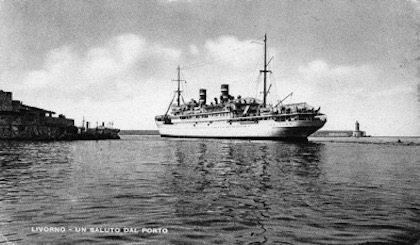
Il FRANCESCO CRISPI saluta il Porto di Livorno
Il FRANCESCO CRISPI ed il suo CARICO UMANO…
Il 19 aprile 1943, verso le 14.30, mentre navigava ancora con le insegne del Lloyd Triestino, venne intercettato e colpito con tre siluri dal sommergibile inglese H.M.S. Saracen che era in agguato a 18 miglia da Punta Nera (Isola d'Elba). Il piroscafo, pesantemente danneggiato, affondò in soli 16 minuti. Il convoglio, formato dalla Crispi con 1300 uomini a bordo, dalla nave trasporto Rossini e da alcune navi ausiliarie, era scortato dal cacciatorpediniere La Masa. Nell’affondamento morirono 943 uomini, in gran parte Granatieri di Sardegna, inviati ai presidi della Corsica occupata.
ll corpo dei Granatieri di Sardegna, al contrario della Brigata Sassari, non è mai stato costituito su basi esclusivamente regionalistiche. Il destino ha voluto che la tragedia del Crispi sia avvenuta il giorno dopo la sua fondazione, il 18 aprile, a Torino.
I Granatieri sono ancora adesso un corpo di fanteria dell'esercito. Discendono dall'antico Reggimento delle guardie, creato nel 1659 dal Duca Carlo Emanuele II. Oggi costituiscono una brigata tra le più impegnate delle forze armate italiane.

Il sottomarino britannico SARACEN (nella foto), varato il 16 febbraio del 1942, era la bestia nera dei convogli italiani in quel tratto di mare. Il Saracen si era distinto sin dalla sua prima missione, quando, al largo delle isole Fær Øer il 3 agosto del 1942, aveva affondato il sommergibile tedesco U-335. Il battello britannico aveva un dislocamento di 990 tonnellate, era lungo 65,9 metri, imbarcava un equipaggio di 48 uomini, era munito di 6-7 lanciasiluri e un cannone da 102/40. Il 9 novembre del 1942 aveva affondato in Sicilia al largo di Capo San Vito il sommergibile italiano Granito. Poi, nell'aprile del 1943 si era messo in agguato nel mar Ligure, intercettando i convogli italiani diretti in Corsica.
L’Ing. Guido GAY, piemontese di origine ma svizzero di adozione, ha ricevuto, l’8 Aprile 2018, il conferimento a Cavaliere di Santo Stefano. L’ing. Gay, esperto di “idrobotica” è l’inventore dei sottomarini robotizzati “PLUTO” che nel Giugno 2012, dopo anni di ricerche e tentativi, soltanto con propri finanziamenti e risorse, è riuscito a localizzare il relitto della corazzata ROMA al largo dell’isola dell’Asinara. Innumerevoli i riconoscimenti per questo straordinario ritrovamento anche da parte della Marina Militare. Ricordiamo che la ROMA, una delle più belle ed efficienti “Regie Navi da Battaglia” Italiane affondò in seguito ad una bomba radio guidata di nuovo tipo lanciata da un aereo tedesco il 9 Settembre 1943. Il Museo Marinaro di Chiavari ha dedicato innumerevoli conferenze alla Corazzata ROMA dato che delle 1393 vittime ben tre membri dell’equipaggio erano Chiavaresi, i Marinai Sebastiano Custo, Andrea Descalzi e il Tenente del CEMM Emilio Ruocco.
Recentemente l’Ing. Guido Gay è stato l’artefice del ritrovamento in fondo al mare del relitto del piroscafo FRANCESCO CRISPI del Lloyd Triestino affondato nel 1943 e del Sommergibile Inglese Saracen che lo aveva affondato.

Nella foto: a sinistra l'Ammiraglio Luigi ROMANI Cavaliere di Gran Croce, conferisce l’Ordine Militare di Accademico di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano all’Ing. Guido Gay. Nella stessa cerimonia hanno ricevuto il Conferimento a Cavalieri di Santo Stefano anche i chiavaresi Comandanti Ernani ANDREATTA e il C.F. Giuseppe Massimo PENNISI.




(Foto sopra) Guido Gay ed i suoi sottomarini robotizzati “PLUTO”
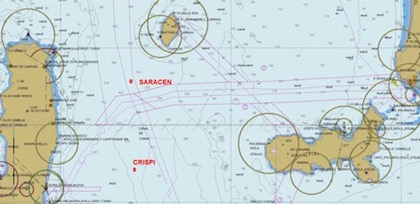
La carta nautica mostra l’esatta posizione dei due relitti. Più a Nord il SARACEN più a Sud il CRISPI, scritti in rosso.
«Cercavo il Saracen da due anni - racconta Guido Gay - da quando ho avuto una richiesta di collaborazione da parte della Andrea Malraux, nave da ricerca del Ministero della Cultura francese». La tv francese sta infatti lavorando a un documentario sulla liberazione della Corsica, e siccome il Saracen aveva contribuito alle operazioni sbarcando agenti e truppe speciali sulle coste dell’isola, la troupe voleva trovare il relitto del sommergibile e filmarlo. «All’inizio non abbiamo avuto fortuna - continua Gay - poi ho proseguito da solo la ricerca, con il mio catamarano Daedalus, finché due settimane fa ho individuato il sommergibile». Il piroscafo Crispi, invece, «l’ho trovato per caso prima, il 31 maggio scorso». Dopo il team del Département des Recherches Archéologiques Subacquatiques et Sous-Marines, anche gli inglesi si sono fatti avanti quando hanno saputo del ritrovamento del loro sommergibile, e una targa commemorativa è già pronta per essere sistemata sul sottomarino.
Marina Mercantile
di Achille Rastelli (Storico Italiano)
Trasporti-di-truppe
L'attività principale nella quale furono impiegate le navi passeggeri fu però quella del trasporto di truppe verso i fronti oltremare, cioè verso la Libia, l'Albania, e poi, dall'inverno 1942-43, la Tunisia.
Lo sviluppo dell'aeronautica consentiva l'impiego di aerei da trasporto per l'invio immediato di piccoli reparti o per il rapido ripiegamento di feriti gravi; a volte furono impiegate in queste missioni anche navi da guerra, sacrificandole in un ruolo per il quale non erano state progettate.
La maggior parte di questo traffico si concentrò però, come era ovvio, sulle navi passeggeri, alle quali va attribuita la maggior parte dei militari trasportati e giunti a destinazione, per un totale di 1.242.729 soldati di tutte le armi.
Non è questo il luogo dove ricordare tutte le missioni svolte da queste navi, perché la loro storia è parte integrante della guerra dei convogli e, quindi, della storia della guerra sul mare della Regia Marina. Basti qui ricordare che, per la tipologia di unità, furono tutte della flotta Finmare e quindi sempre navi dello Stato, che per queste missioni viaggiarono quasi sempre come navi requisite, mai però militarizzate, e sempre con equipaggi della Marina mercantile.
Alcune di queste navi furono protagoniste di alcuni fra i più tragici episodi della guerra dei convogli: Neptunia e Oceania vennero affondate il 18 settembre 1941 dal sommergibile britannico Upholder, e morirono 384 uomini, dei 5818 che erano a bordo. La Conte Rosso, partita da Napoli per Tripoli il 24 maggio 1941 in convoglio con l'Esperia e la Marco Polo, venne silurata, sempre dal sommergibile Upholder, che le colpì con due siluri.
La nave affondò in 14 minuti, e morirono 1291 fra soldati e marinai; 1441 furono salvati dalle siluranti di scorta e dalla nave ospedale Arno giunta da Messina.
Una delle perdite più sentite dalla Marina mercantile italiana fu quella della motonave Victoria, una delle più belle e celebri navi italiane, colpita da aerosiluranti britannici al largo della Sirte. Perirono con la nave 249 uomini, tra cui il Capitano Arduino Moreni, Comandante della Victoria, ed il Comandante militare, capitano di vascello Giovanni Grana.
L'elenco delle navi passeggeri affondate durante missioni di trasporto truppe è tragicamente lungo: Sardegna, Viminale, Francesco Crispi, e Liguria del Lloyd Triestino, Caliteli, Esperia, Galilea (sulla quale morirono 995 alpini), Quirinale e Celio dell'Adriatica, Città di Agrigento, Città di Bastia, Citta di Tripoli, Firene, Catalani, Puccini, Aventino, Città di Catania della Tirrenia, più altre catturate dai tedeschi.
Alla fine della guerra erano poche le navi passeggeri rimaste in servizio, e su quelle poche si doveva contare per il riprendere il traffico civile, essenziale in quei primi mesi del dopoguerra.
CONCLUDIAMO CON LA MAI LOGORA CITAZIONE DI
PRIMO LEVI
“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo”
Carlo GATTI
Rapallo, 2 Maggio 2018
BIBLIOGRAFIA:
- STORIA DEI TRASPORTI ITALIANI:
F.Ogliari, A.Rastelli, G.Spazzapan, Alessandro Zenoni.
Volumi: III-V-VII
- - LA MARINA ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE:
Ufficio Storico della Marina Militare
- - IL BOMBARDAMENTO DI GENOVA - di Alberto Rosselli
- - GENOVA IN FIAMME (Edito dal Secolo XIX)
{j
BATTAGLIA DELLA MELORIA
BATTAGLIA DELLA MELORIA
6 Agosto 1284


PREMESSA:
Anche tra RAPALLO e i Pisani c’é stato un lungo contenzioso…
Scrive Antonio Calegari:
…..Così nel maggio 1087 i pisani vi piombano sopra “viriliter” (come scrisse l’Unghelli) smantellando il castello, incendiando la Chiesa e facendo schiavi uomini e donne.
…..Così nel 1284 Rapallo è duramente provata dalla flotta veneto-pisana, comandata da Alberto Morosini e da Loto Donoratico, figlio quest’ultimo del ben noto conte Ugolino. Pisa è la nemica di Rapallo, la quale arma alcune galere per contrastarne le forze, sempre in unione alla flotta genovese. Fin dal 1229 Rapallo si è volontariamente assoggettata a Genova.


Infatti nell’anno 1284 navi rapallesi partecipano valorosamente alla famosa battaglia della Meloria nella quale i pisani subirono così dura sconfitta.

Galea genovese
La storia della Repubblica di Genova, dai suoi esordi fino al suo epilogo nel 1797, s’intreccia con la storia di queste imbarcazioni particolari. Le galee dominano il Mediterraneo per oltre mille anni: ad esse sono legate le più importanti battaglie navali combattute in questo periodo, dalla Meloria a Lepanto. In questa lunghissima storia, i genovesi svolgono un ruolo importante: apportano innovazioni e modifiche, diventano tra i costruttori più apprezzati di questi scafi.
Ma la storia delle galee non è solo una storia di tecniche costruttive e militari: alle galee è legato un mondo, quello dei vogatori, in origine liberi e volontari, ma a partire dal XVI secolo, per lo più schiavi e forzati.

Lo stemma di Pisa
Lo stemma della città è rappresentato dalla bandiera rossocrociata. La bandiera rossa, inizialmente priva di croce, fu concessa alla Repubblica di Pisa da Federico Barbarossa. La città fu costantemente fedele all'impero e almeno dal 1242 fu portata in mare. La croce bianca, che simboleggia il popolo pisano, fu aggiunta successivamente. Nel 1406, la città perse l'indipendenza e da allora la bandiera simboleggia il Comune. Oggi lo stemma della città è inglobato sugli stemmi e le insegne marittime italiane insieme a quelli delle altre tre repubbliche marinare.
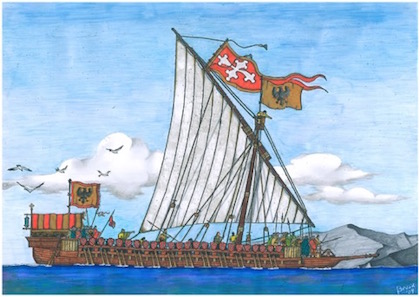
Galea biremi pisana
Scrive Georg Caro:
Ma negli anni precedenti si ha notizia di galere rapallesi; nel 1232, quando Rapallo invia una galera a Genova per essere incorporata nella flotta destinata ad aiutare i cristiani di Ceuta minacciati dai saraceni; ed in seguito negli anni 1258, 1262, 1265, 1270, numerosi legni da guerra si affiancano alle navi di San Giorgio nella lotta contro i comuni nemici. Parallelamente nei secoli XIII e XIV, quei di Rapallo sviluppano una rilevante attività commerciale-marittima, soprattutto col Levante, a quanto è lecito supporre, per esempio, dalla numerosa colonia rapallese dislocata a Cipro. In essa emergono, come naviganti, armatori e commercianti, i nomi della casata dei Ruisecco e dei Pastene. Un Domenico Pastene (fine del ‘300) diventa il più grande commerciante dell’isola, viaggia molti anni in Egitto, Siria, Asia Minore, Mar Nero, sino al golfo Persico, inviando interessanti relazioni diplomatico-commerciali alla Repubblica di Genova, lasciando infine tutte le sue ricchezze al Banco di San Giorgio. E Rapallo manda persino sulle rive del Lemano alcuni suoi figli, un Sacolosi ed un Andreani, quali maestri d’ascia per la costruzione di galee sabaude. Pure alla fine del ‘300 un Antonio Colombo di Rapallo è comandante di galee. (Su questo argomento ci siamo già occupati su questo sito).

Faro della Meloria
(foto di S. Guerrieri - archivio Area Marina Protetta)

Torre della Meloria
(foto di S.Guerrieri - archivio Area Marina Protetta)
Per il racconto della Battaglia della Meloria (1284) abbiamo preso come testo di riferimento:
“BENEDETTO ZACCARIA”
di Roberto S. LOPEZ
Ediz. CAMUNIA Editrice 1996 - Firenze
« Benedetto Zaccaria è una delle splendide figure di un tempo nel quale non mancavano spiccate personalità...Il mare era la sua patria; egli aveva percorso tutte le coste del Mediterraneo alla testa di galere da guerra, ora al servizio di Genova, ora al soldo di principi stranieri »
La battaglia della Meloria ci é stata raccontata in tante versioni tra le quali, per la verità, emergono numerose discordanze, imprecisioni e direi anche suggestioni più o meno di parte…
Per la nostra ricerca ci siamo messi nelle mani di una GUIDA sicura, un Pilota di razza: lo studioso genovese Roberto S. Lopez che nacque a Genova nel 1910 – si laureò in Storia Medievale nel 1932 con la tesi: Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante. Genova marinara nel Duecento, che pubblicò nel 1933.
Nella prefazione di questo libro la celebre storica genovese Gabriella Airaldi ha scritto:
“Quando vide la luce nel 1933 il Benedetto Zaccaria del giovanissimo Lopez rappresentò per molti aspetti una novità. In esso, infatti, le intenzioni dell’autore facevano della vicenda dell’uomo anche uno strumento nuovo per leggere le forme di vita di una delle grandi potenze medievali, Genova, alla luce di un “medioevo degli orizzonti aperti”. D’altra parte, la capacità di leggere e d’interpretare con raffinato metodo un ampio spettro di testimonianze e le brillanti capacità espositive collocarono subito Lopez nel ristretto Olimpo di questi scienziati capaci allo stesso tempo di colloquiare con l’accademia e con un più vasto pubblico”.
Perché Benedetto Zaccaria? Chi era costui?
Per lo storico Lopez, e per altri autori, è stato un personaggio poliedrico: uno dei più abili ammiragli del Medioevo, vero vincitore della Battaglia della Meloria, mercante, scrittore, diplomatico, politico.
MELORIA (A. T., 24-25-26 bis). - Con questo nome si designa, più che uno scoglio, una zona di bassifondi sabbiosi e fangosi, disseminati di rocce a 2-5 m. di profondità, e di scogli affioranti, su uno dei quali a circa 7 km. a ponente di Livorno sorge un'antica torre, edificio a base quadrata ad archi, alto 20 m., eretto dai Pisani a uso di faro; 200 m. più a S. sorge il faro moderno in ferro, le cui coordinate geografiche sono di 43° 32′ 45″ lat. N. e 10° 13′ 10″ long. E. I bassifondi si estendono per circa 6 km. da N. a S.

La battaglia della Meloria. - Fu la più cruenta e decisiva delle battaglie navali combattute tra le due repubbliche di Genova e di Pisa, nella secolare lotta per il dominio del Tirreno.
Nell’anno 1284, la guerra tra le due Repubbliche Marinare era già in atto da oltre due anni.
Già un violentissimo scontro era avvenuto nelle acque di Sardegna, a Tavolara, tra Enrico de' Mari, capitano della scorta d'un ricco convoglio genovese, e un'armata pisana agli ordini di Guido Zaccia, con la perdita di dieci galee pisane.
La parola a Roberto S. Lopez:
Il 22 aprile 1284, presso l’isola di Tavolara, tredici navi da guerra pisane furono prese e una affondata da un convoglio mercantile di cui faceva parte una galea da carico di Benedetto e Manuele Zaccaria. Proseguendo nel loro viaggio, i vincitori catturarono ancora due navi nemiche, e ne vendettero l’equipaggio a Siracusa, per dileggio, in cambio di cipolle. Ecco dunque che si formava, nel Tirreno come nell’Egeo, quella stretta catena nella quale corsari, mercanti e militari si davano la mano.
Poco dopo i Genovesi, agli ordini di Benedetto Zaccaria, bloccarono il porto di Pisa; ma approfittando di una momentanea assenza della squadra di blocco, tutta l'armata pisana, forte di 72 galee (secondo altre fonti 75), uscì al largo agli ordini del podestà, il veneziano Albertino Morosini, col proposito d'impedire la congiunzione della squadra dello Zaccaria con un'altra di 52 galee che si stava frettolosamente armando a Genova agli ordini di Oberto D'Oria. Il Morosini condusse l'armata nelle acque di Genova, schierandosi a sfida dinnanzi al porto (31 luglio); ma il sopraggiungere dello Zaccaria costrinse il podestà di Pisa ad allontanarsi per non essere preso in mezzo tra le due squadre nemiche.
La parola a Roberto S. Lopez:
Quattro giorni dopo la partenza (da Tavolara), Benedetto Zaccaria era già a Porto Pisano, a dare la mala Pasqua ai cittadini di Pisa; incrociò molto tempo in quel mare, fu visto alla Gorgona alla fine di giugno, perlustrò i mari di Corsica e di Sardegna…. Mentre quelle di Pisa non s’arrischiavano a lasciare i sicuri ormeggi del porto…. Ammiraglio e mercante, lo Zaccaria comprese che per colpire a morte la città nemica occorreva anzitutto paralizzare il suo commercio, separarla dalle colonie di Sardegna e del Levante, tagliarle i rifornimenti marittimi. …. In tre mesi nemmeno una nave di Pisa andò a cadere nelle reti del genovese.
L’apparente inerzia dei Pisani… doveva soltanto servire a dar tempo di allestire la grande armata che avrebbe vendicato fin nel porto di Genova l’onta di Tavolara…. Anima della riscossa pisana era il nuovo podestà, entrato in carica dal 1° di marzo, uomo di grande valore anche a detta de’ suoi nemici; il veneziano Alberto Morosini.
Alla metà di luglio l’INVINCIBILE ARMADA era pronta: 65 galee e 11 galeoni.
A bordo erano stati caricati in gran numero quei famosi trabocchetti che avrebbero dovuto infliggere a Genova l’umiliazione di un bombardamento.
Pisa s’era svuotata di difensori per equipaggiare le galee, sulle quali era salito il fiore della nobiltà e molti popolari della città e del contado; v’erano il podestà, tutto il collegio dei giudici, il conte Ugolino col figlio lotto della Gherardesca e col nipote Anselmuccio.
L’animosità e la brama di rivincita avevano fatto commettere a Pisa una grande sciocchezza: giocare il tutto per il tutto in una sola spedizione che, se fosse fallita, non avrebbe potuto essere rinnovata; mentre Genova, più popolosa, anche dopo aver persa una flotta poteva senza troppo aggravio metterne in mare un’altra.
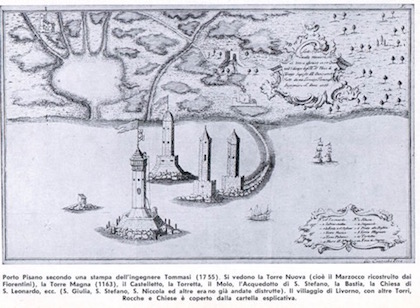

Già attivo e conosciuto nel III e II secolo a.C., il porto pisano nasce in una zona abitata già in ere precedenti alla nascita di Roma. Si hanno cenni di popolazioni stanziali dedite alla pesca nel territorio oggi pisano, nei secoli IX e VIII a.C.. La zona rappresentava un ampio golfo formato dalle foci del fiume Arno e Serchio. Nel corso dei secoli l’area fu interessata da forte insabbiamento che formò ampie zone paludose distinguendo nettamente le foci dei due fiumi. Il Portus Pisanus comincia ad essere citato come tale nel II secolo d.C. alludendo come ad una delle più importanti strutture portuali della vasta area lagunare. Altro centro portuale di questa zona era posto nei pressi di San Piero a Grado, probabilmente con caratteri di scalo fluviale, dove la leggenda narra sia sbarcato San Pietro nel luogo ove sorge la mirabile Basilica di San Piero a Grado. Il Portus Pisanus, probabilmente fu base della flotta romana in azione nel Mar Ligure.
Com’é noto, Pisa non si trova sul mare, essa è costruita sul fiume Arno e per difendere la sua flotta costruì un faro a Porto Pisano nel XII secolo ma ben presto l’erosione marina e l’insabbiamento resero inutilizzabile sia il porto sia il faro. A questa distruzione aveva contribuito anche la terribile battaglia che Pisa combatté nel 1284 contro i genovesi tra le secche della Meloria. I Pisani nel frattempo, intorno al 1200, avevano eretto una nuova torre su una di queste pericolose secche, circa quattro miglia al largo della costa, come una sentinella notturna per prevenire i naufragi fra quelle pericolose rocce.
La parola a Roberto S. Lopez:
I Pisani pensarono di uscire di sorpresa dal porto, annientare con forze preponderanti le navi di Benedetto Zaccaria e piombare sulla città nemica impreparata e ancora sotto il colpo della sconfitta. Cogliere i Genovesi di sorpresa non era difficile: avvezzi ormai alle gradassate dei Pisani, sebbene venisse loro riferito che una grande flotta stava per muovere da Pisa, non ci credettero. Ma una tempesta inchiodò per molti giorni la flotta pisana alla bocca dell’Arno. La sorpresa era fallita: Benedetto Zaccaria, che probabilmente stava da tempo sull’avviso, ricevette dal Comune lettere di richiamo, mentre era nel porto di Tizzano in Corsica e si preparava ad assalire Sassari; senza indugio egli fece vela per Genova.
Il Morosini, uscito da Bocca d’Arno il 22 luglio, pensò che lo Zaccaria sarebbe tornato per la Riviera di Ponente, puntò direttamente su Albenga per tentar di tagliargli la strada: ma l’ammiraglio genovese rimpatriò per La Riviera di Levante.
Il 31 luglio la squadra del Morosini, senza aver incontrato quella dello Zaccaria, comparve dinanzi a Genova. Ma la città aveva avuto il tempo di mobilitare i marinai delle due Riviere, e in poche ore – quante occorsero ai nemici per giungere da Varazze, dove erano stati avvistati la mattina, alle adiacenze del porto – furono pronte 58 galee e 8 panfili, sotto il comando di Oberto d’Oria.
LE ARMI USATE SULLE GALEE
Non mancavano i mezzi per scagliare grosse
pietre a distanza: le galee avevano a bordo gran numero di arnesi di lancio meccanico: catapulte, mangani, trabocchetti, balestre fisse, gatti, briccole, alcuni dei quali gettavano proiettili di trenta libbre e anche più. I Genovesi, anzi, erano famosi come balestrieri e costruttori di balestre; e poiché anche allora le armi navali più pesanti erano dello stesso genere di quelle usate nella tecnica d'assedio terrestre, oltre che pietre, dalle navi si scagliavano liquidi bollenti (olio, pece, calce viva, anche sapone liquido per far scivolare gli uomini sul ponte);
Non mancavano anche altri ordigni bizzarri, come quell'«arganel» rotante, che aveva per braccia una quantità di spade affilate, che fu visto alla battaglia della Meloria sulla prua d'una galea pisana. I Pisani s'erano ripromessi di sorprendere i Genovesi con questo nuovo strumento d'offesa, ma s'ingannarono: galea e arganello andarono a ingrossare i trofei della vittoria nemica."
La parola a Roberto S.Lopez
Forzare l’entrata di un porto così ben munito non pareva possibile; né il d’Oria volle uscire a dar battaglia con forze di tanto inferiori, sebbene i Pisani lo aizzassero con clamori e vituperi. …. Non c’é ragione di dubitare che, ( i pisani) trovandosi così vicini alla città nemica, non abbiano adoperato i famosi trabocchetti per far piovere” a grandigia dentro le mura palle coperte di panno scarlatto” o balestrarvi “quadrella d’argento”.
Comunque fu breve trionfo: la sera medesima Benedetto Zaccaria, sfuggito alla caccia delle navi pisane, da Portofino entrava sano e giulivo nel porto di Genova.
La situazione era rovesciata: e tutto il merito era dello Zaccaria. Se egli avesse perso qualche ora, gli avvenimenti avrebbero preso una piega molto diversa….
Ormai era tardi: se il Morosini avesse aggredito lo Zaccaria prima che entrasse in porto, certamente Oberto d’Oria lo avrebbe preso in mezzo, con forze preponderanti.
La sola salvezza dei Pisani, trionfatori la mattina, stava ormai in una precipitosa ritirata. La parola FUGA ripugnava a una flotta che era partita per compiere una spedizione punitiva: i cronisti pisani asseriscono che i loro connazionali si staccarono dalle acque nemiche per via del vento contrario…quasiché le navi di Benedetto Zaccaria fossero state intessute d’Eolo e di brezze.
La notte medesima Oberto d’Oria, lasciato sgombro il porto, andò a ormeggiarsi davanti alla spiaggia di Sturla. Quando le due flotte genovesi riunite giunsero nelle acque del Porto Pisano, i Pisani vi erano dal giorno prima. Si raccontò più tardi che la loro squadra era rientrata in città, che gli equipaggi erano stati passati in rivista fra i due ponti sull’Arno e benedetti dall’arcivescovo Ruggeri: e che durante la solenne cerimonia il globo con la croce posto sullo stendardo era caduto a terra. Terribile presagio; ma gli orgogliosi Pisani gridando “battaglia, battaglia!” erano usciti incontro al nemico e avevano disprezzato il celeste avvertimento. Favole: i Pisani il tempo di muoversi da porto Pisano prima che arrivassero i Genovesi lo avevano avuto: la croce dello stendardo cadde realmente dall’asta, ma prima ancora che l’armata partisse per il bombardamento di Genova.

Estate 1284: nel braccio di mare di fronte alle Secche della Meloria, le due Repubbliche Marinare si contendono l’egemonia sul Mediterraneo.
La sera del 6 agosto 1284 il mare davanti a Livorno era rosso di sangue e ingombro di cadaveri che galleggiavano tra remi spezzati, vele strappate, gomene tagliate, scialuppe rovesciate. La potenza della Repubblica Marinara di Pisa era tramontata, schiacciata da Genova.
Alla loro volta i Genovesi inseguirono i Pisani che, dopo avere volteggiato verso Capo Corso, erano tornati a Porto Pisano. Per attirare i nemici a battaglia, il d'Oria ricorse a uno stratagemma, ordinò cioè allo Zaccaria di calare le vele e gli alberi e di nascondersi con una parte dell'armata (forse presso Montenero di Livorno): sicché, contate le vele nemiche e vistele molto inferiori di numero alle sue, il Morosini deliberò di accettare il combattimento, e uscì dal Porto Pisano dirigendosi verso il nemico. La battaglia avvenne il 6 agosto presso le secche della Meloria (pare che Iacopo Doria chiamasse Veronica lo scoglio), e dapprima parve volgere in favore ai Pisani, le cui 102 tra galee e navi minori erano molto superiori alle 60 del d'Oria, e appoggiate alle secche presentavano un aspetto formidabile. Ma a un tratto ecco avanzarsi contro la formazione pisana la squadra dello Zaccaria, che dava ai Genovesi, se non la superiorità del numero, il vantaggio della sorpresa. Era ormai per i Pisani troppo tardi per ritirarsi ed evitare l'avvolgimento di una delle ali, comandata da Andreotto Saraceno. Si combatté disperatamente, non più per la vittoria, bensì per la salvezza.

Ma quando lo Zaccaria con due galee accoppiate, fra le quali era tesa una grossa catena, venne a investire la capitana pisana, troncandone di netto al primo urto lo stendardo bianco con l'immagine della Vergine, la linea pisana cominciò a spezzarsi; poi, dopo disperata resistenza, fu rotta. E incominciò l'inseguimento e la strage. Solo l'ala sinistra, grazie all'abilità e alla prudenza di Ugolino della Gherardesca, che la comandava, poté mettersi in salvo, riparando nel porto e conservando così a Pisa una parte delle sue forze navali, circa venti galee. Delle altre, come dice l'iscrizione apposta sulla facciata di S. Matteo, chiesa dei D'Oria, 33 furono prese, 7 affondate. Le perdite dei Pisani furono di circa 5000 morti e, secondo l'iscrizione, di 1272 prigionieri. Tra essi il podestà Morosini e Lotto, figlio di Ugolino. Le perdite genovesi furono anch'esse molto gravi; ma mentre Pisa senza retroterra non poteva più rialzarsi e, circondata com'era da feroci nemici (Lucca, Siena, Firenze), era destinata irrimediabilmente a perdere libertà e dominio, Genova, avendo nelle due riviere inesauribile riserva di uomini, poté ben presto riparare ai vuoti.

Torre della Meloria luogo della Battaglia

«La battaglia della Meloria», un dipinto di Giovanni David (1743-1790) collocato a Genova sopra l’ingresso del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale
La sera del 6 agosto 1284 il mare davanti a Livorno era rosso di sangue e ingombro di cadaveri che galleggiavano tra remi spezzati, vele strappate, gomene tagliate, scialuppe rovesciate. La potenza della Repubblica Marinara di Pisa era tramontata, schiacciata da Genova. Le due città erano in lotta perché i loro interessi commerciali si sovrapponevano sia nel Mare Tirreno (entrambe aspiravano al controllo di Sardegna e Corsica) sia nel resto del Mediterraneo (tutte e due avevano colonie in oriente e si contendevano i flussi di spezie e seta). Il confronto era impari perché Genova, stretta tra mare e montagna, non doveva fronteggiare nemici in terraferma, mentre Pisa, avvantaggiata dal fatto di sorgere alla foce dell’Arno, sbocco sul mare per tutta l’economia toscana settentrionale, era braccata da città ostili (Lucca per prima) sempre pronte ad attaccarla.
LA FATAL BATTAGLIA
Di Roberto S.Lopez
La flotta genovese, comparsa il 5 agosto di sera davanti alla Meloria, vide la mattina dopo i vascelli pisani ancorati sotto la protezione delle torri di Porto Pisano, dietro le catene che ne chiudevano l’accesso.
Perché i nemici credessero di avere davanti a sé la sola squadra di Oberto d’Oria, le galee di Benedetto Zaccaria ammainarono le vele e seguirono il grosso dell’armata a una certa distanza, in modo da poter essere scambiate per quelle barche che di solito accompagnavano le navi da guerra: non però così lontane da non poter intervenire a tempo nella mischia.
Era il giorno di San Sisto, data consacrata per tradizione alle battaglie navali.
I Pisani abboccarono all’amo. L’armata della riscossa, tornata senza gloria e a mani vuote, non poteva rientrare a Pisa, e tollerare per di più lo sfregio della presenza dei Genovesi davanti al porto…
(Ingannato dallo stratagemma) Morosini giudicò avere quella leggera superiorità numerica che gli avrebbe accordato parecchie galee favorevoli sui Genovesi, i quali dovevano essere anche stanchi del viaggio.
La flotta pisana uscì dal porto sicuro e si schierò di fronte a quella nemica. Da quel momento l’esito della lotta fu deciso.
La battaglia della Meloria é stata narrata più e più volte da altri, cosicché non ci attarderemo troppo a descriverla. Come é noto i Pisani, usciti dal porto alla mattina, non potevano muovere all’assalto perché erano coperti d’armi pesantissime, e imbarcati su vascelli carichi dei trabocchetti già destinati all’onta dei Genova, e resi ancor più grevi dalla corazzatura degli scudi. Ne approfittarono i genovesi per lasciar cuocere gli avversari fino a vespro, sotto il solleone d’agosto; poi, distribuito pane e vino ai marinai ormai riposati dal viaggio, attaccarono.
Da ambo le parti si combatté con grande valore; si scagliavano dardi, sapone liquido, calce polverizzata a nuvole che oscuravano l’aria, mentre il mare si tingeva di sangue; ma poco dopo l’inizio della battaglia – mentre, a detta d’un cronista poco sospettoso perché appartenente a una città neutrale, i Pisani vincevano – sopraggiunse Benedetto Zaccaria a far tracollare la bilancia dalla parte dei Genovesi. La loro galea capitana era venuta a battaglia con quella dei Pisani: subito lo Zaccaria accorse in aiuto del supremo comandante, intuendo che là si decideva la lotta. I Pisani avevano due stendardi, uno dei quali issato sulla nave ammiraglia: lo Zaccaria, legata una catena agli alberi di due galee, le fece passare l’una a destra l’altra a sinistra della ammiraglia; nell’urto il pennone fu falciato e cadde il drappo vermiglio recante l’immagine della Madonna, che vi sventolava. Nello stesso tempo la galea di S. Matteo – dove erano saliti, a quanto pare, duecentocinquanta persone della famiglia d’Oria, fra le quali i generi di Benedetto e Manuele Zaccaria, Paolino e Niccolò – assaliva il vascello pisano sul quale sventolava la bandiera del Comune, che fu tosto lacerata: ma solo dopo lunghi sforzi si poté abbattere l’asta ricoperta di ferro.
La caduta dei due stendardi segnò il principio della rotta: i Genovesi, fatta prigioniera la galea ammiraglia nemica, diedero l’assalto generale; e i Pisani, che sino allora avevano combattuto con disparata tenacia, cercarono salvezza nella fuga. Fu detto che per primo fuggisse il conte Ugolino, con tutta una sezione dell’armata: ma il suo non fu tradimento, ché anzi valse a salvare alla Repubblica almeno una piccola parte di quella superba flotta, che ormai era votata alla distruzione.
Sette galee erano state sommerse. Trentatré vascelli; una moltitudine di prigionieri (contando anche quelli catturati nelle precedenti battaglie, più di novemila) fra i quali il podestà Morosini, tutto il collegio di giudici, il conte Lotto che solo grazie alla prigionia poté poi sfuggire alla morte nel carcere della Fame; il sigillo del podestà, lo stendardo, la cancelleria del Comune pisano: questa la preda superba dei Genovesi.
Ma anche i vincitori avevano subite perdite gravissime, cosicché non tentarono un assalto alla città – l’avrebbero trovata indifesa e prostrata sotto il peso delle sciagure, che avevano colpita in essa quasi ogni famiglia – e ritornarono subito a Genova senza celebrare con grandi feste un trionfo per cui tante famiglie dovevano vestir gramaglie.
A CHI VA ATTRIBUITO IL MERITO D’AVER IMMAGINATO LO STRATAGEMMA CHE PROCURO’ LA VITTORIA? AL COMANDANTE SUPREMO DELLA SPEDIZIONE GENOVESE OBERTO D’ORIA OPPURE A BENEDETTO ZACCARIA?
Ce lo spiega Roberto S. LOPEZ
In genere si credette, e si crede, che la gloria spettasse al capitano del popolo, ammiraglio supremo della squadra: Oberto d’Oria, tanto più che la sua famiglia, a ragione considerata fra le più illustri di Genova, si fece il panegirico da sé nella famosa iscrizione della chiesa di San Matteo. Anche l’Annalista di Genova – Jacopo d’Oria, fratello dell’ammiraglio – attribuisce il piano di battaglia a Oberto: ma, considerata la stretta parentela che lo univa a lui, non c’é da stupirsene.
Piuttosto può sembrare strano che negli Annali si trovi solo un vago accenno alla disposizione delle galee dello Zaccaria, cosicché noi la ignoreremmo senza il chiaro racconto di un altro cronista. Si direbbe che Jacopo d’Oria abbia a bella posta lasciato in ombra un accorgimento che non fu dovuto a suo fratello.
Ma confrontiamo il curriculum vitae di Benedetto Zaccaria con quello di Oberto d’Oria. Questi prima del 1284 aveva compiuto un saccheggio dell’indifesa isola di Candia, e due volte, nel 1271 e nel 1283, uscito in forze dal porto, era tornato senza nemmeno aver combattuto.
La medesima irresolutezza si palesa dopoché i Pisani hanno tentato di bombardare Genova: superiore a loro per forze, invece di costringerli a battaglia tende loro un trabocchetto abbastanza grossolano, e perde un tempo prezioso prima d’inseguirli. La Meloria, se non é il battesimo del fuoco per il d’Oria, é per lo meno la sua prima battaglia. E anche l’ultima: nel 1295, ottenuto di nuovo il comando di una flotta – la più grande che Genova avesse armato, centosessantacinque galere – se ne servì soltanto per giungere a Messina, aspettarvi inutilmente diciotto giorni la squadra veneta (con grande stupore dei Siciliani, che non vedevano l’ombra di un veneziano) e tornare indietro senza aver torto un capello o bruciato una chiatta al nemico.
Non é dunque un capitano così dubbioso, esitante, scialbo che poteva aver concepito il piano e la condotta della battaglia fatale ai Pisani. Un altro uomo accanto a lui, con attribuzioni di comando quasi indipendenti, aveva l’esperienza e l’ingegno necessari: Benedetto Zaccaria.
Uno storico eminente ha osservato che la formazione della flotta genovese alla Meloria era uguale ad una di quelle trattate fin dal secolo IX da un tattico greco, Leone il Filosofo: coincidenza fortuita, o non piuttosto vestigio dell’opera di un ammiraglio educato alla scuola di Bisanzio? E, quand’anche le imprese dello Zaccaria contro i pirati dell’Egeo non fossero arra (garanzia) bastante per proclamare il suo genio militare, le vittorie smaglianti che più tardi riportò contro i Saraceni del Marocco sono ben degna di quella che nel 1284 troncò la secolare gloria di Pisa, e mutò così la storia del mare.
La formazione tattica usata per la prima volta nel 1284, da Benedetto Zaccaria, divenne classica e si radicò nell’arte militare di Genova: le più belle vittorie ch’essa riportò in seguito, Curzola e Pola, furono combattute seguendo la medesima strategia.
Cronotassi dei principali avvenimenti
· 1237 - prima battaglia della Meloria (3 maggio) con vittoria pisana che fa prigionieri 4.000 genovesi
· 1254 – fondazione dell’eremo di San Jacopo ad opera degli Agostiniani su autorizzazione del capitano del porto
· 1267 – Carlo d’Angiò distrugge gran parte del Porto Pisano e dei suoi dintorni con le pievi, monasteri, spedali, borghi, dogana, ecc.
· 1270 – Corradino di Svevia s'imbarca sulla flotta pisana per la spedizione punitiva in Sicilia contro Carlo d'Angiò; scomunica papale alla repubblica pisana
· 1282 - è eretta una torre a Salviano per difendere il porto dal lato terra
· 1284 - il 6 agosto si combatte la seconda Battaglia della Meloria, con la disfatta pisana; il porto in gran parte distrutto dalle armi genovesi e circoscritto dal progressivo interramento viene limitato tra la foce dell'Ugione e il borgo di Livorno
· 1284 - viene eretta la nuova torre Rossa a difesa del porto
· 1285 - sono erette le torri di difesa Maltarchiata e Fraschetta; la cala portuale può contenere ancora un centinaio di galee; un nuovo attacco genovese dal mare e lucchese da terra danneggia gran parte del porto
· 1286 - i genovesi distruggono la torre-faro della Meloria
· 1289 - nuovo attacco della flotta genovese che taglia la catena del porto e a pezzi la porta a Genova
· 1290 - nuove distruzioni ad opera dei genovesi, fiorentini e lucchesi che danneggiano le torri e tentano di insabbiare l'ingresso del porto
· 1303 - i provveditori delle fabbriche del porto, Lando Eroli e Jacopo da Peccioli, fanno erigere il nuovo Fanale (attuale faro di Livorno), vengono costruite nuove opere portuali e fortificazioni, posta una nuova catena all'ingresso e risarcito l'acquedotto di Santo Stefano che fornisce l'acqua alle navi
· 1339 - si comincia a citare in modo distinto il porto dallo scalo di Livorno
· 1360 - in previsione della guerra con Firenze si rafforzano le fortificazioni del porto e sono restaurate le torri Rossa e Castelletto
· 1363 - assalto di galee genovesi al soldo di Firenze, molti edifici sono distrutti, la catena è nuovamente tagliata e i suoi pezzi appesi alle colonne di porfido del battistero fiorentino
· 1364 - ultimo grande scorreria nel porto ad opera dei fiorentini Monforte, Manno Donati e Bonifacio Lupi
TRACCE DI PISA A GENOVA DOPO LA MELORIA
Come abbiamo appena letto, il 6 agosto 1284: in una delle più grandi battaglie navali del medioevo, la Battaglia della Meloria, la flotta pisana, comandata dal Podestà, il veneziano Alberto Morosini (ma è partecipazione individuale, Venezia non interviene), è pressoché annientata.
Genova sconfigge la rivale Pisa per merito di Oberto Doria e del suo esperto collaboratore Benedetto Zaccaria. Un'impressione di stupore quasi mistico si produce a Genova dalla grande vittoria e dal grande numero di prigionieri (oltre 9000) da far nascere il notissimo proverbio «chi vuol vedere Pisa vada a Genova».
Tuttavia le trattative di pace languivano finché il 15 aprile 1288 fu firmato a Genova l'atto di pace, che Pisa ratificò il 13 maggio successivo.
Le condizioni dettate dai Genovesi erano gravissime e non pareva proprio che i Pisani volessero eseguirle. Così il 23 agosto 1290 la flotta genovese comandata da Corrado Doria salpò da Genova per raggiungere il Porto Pisano; ne abbatté le torri e mentre i Lucchesi devastavano Livorno e la campagna pisana, i Genovesi distrussero dalle fondamenta Porto Pisano, otturando con pietre e con una nave piena di mattoni le bocche dell'Arno. Fu in quella occasione che i Genovesi si impossessarono delle Catene di Porto Pisano.
Secondo le cronache, fu il genovese Noceto Ciarli (o Chiarli) ad aver avuto l'idea di accendere un fuoco sotto di esse, in modo da poter indebolire il metallo e da rompere facilmente gli anelli che chiudevano il porto. L'astuta mossa dei genovesi permise loro di entrare nel Porto di Pisa e di raderlo al suolo, interrandolo e cospargendolo di sale (esattamente come i Romani avevano fatto con Cartagine), in modo da renderlo totalmente infertile ed inutilizzabile.
La catena che avrebbe dovuto proteggere il porto fu spezzata in varie parti e portata a Genova; queste vennero appese in varie chiese ed edifici della città, a scherno dei pisani e a monito della potenza dell'omonima repubblica.

Franco Bampi, presidente de A COMPAGNA - Genova, ha stilato questo interessante elenco intitolato:
Da dove pendevano
le catene di Porto Pisano
a Genova
1. Chiesa di San Torpete
Fu San Torpete la chiesa della comunità pisana di Genova, sulla cui facciata nel 1290 furono sospesi alcuni anelli della catena del porto pisano, infranta dai fabbri della flotta genovese guidata da Corrado Doria la quale il 10 settembre 1290 aveva forzato il porto rivale.
2. Palazzo del Capitano del Popolo (Palazzo San Giorgio)
Al di là della via Filippo Turati scorgiamo il palazzo fatto costruire dal capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra negli anni intercorrenti dal 1257 al 1262 e divenuto, dopo la deposizione di costui, il palazzo del Comune sulla cui facciata, tra un arco e l'altro, pendevano tredici anelli della già menzionata catena.
3. Chiesa.di.Santa.Maria.di.Castello
Il nostro itinerario ci conduce alla chiesa di santa Maria di castello, anch'essa ornata con quattro anelli della catena di porto pisano, la quale ebbe il primo fonte battesimale di Genova, secondo un'antica tradizione.
4. Chiesa.del.Santissimo.Salvatore
Risaliamo in piazza Sarzano sostando dinanzi alla chiesa del Santissimo Salvatore sul cui prospetto stavano altri tre anelli della catena che chiudeva il porto di Pisa...
5. Porta.Soprana
...e, per l'antica strada di Ravecca, giungiamo in vista della Porta Soprana appartenente alla cinta muraria costruita dal 1157 al 1159; da sotto il suo arco pendevano quattro anelli dell'anzidetta catena il cui ricordo ancora ci lega alla città di Pisa.
6. Bassorilievo.in.Borgo.Lanaiuoli
Ridiscesi nello scomparso vico dritto Ponticello, ci ricordiamo di una casa che formava angolo con il Borgo Lanaiuoli; su di essa era murato un bassorilievo, che risaliva al 1290, raffigurante tre moli chiusi da catena sormontati da tozze torri rotonde e circondati da fortificazioni; da esso pendevano due anelli della stessa catena del porto pisano rappresentato dallo stesso bassorilievo.
7. Porta.degli.Archi
Oltre questa s'apriva la piazza di Ponticello sul cui lato opposto era situato l'ospedale di Santo Stefano che prospettava la strada direttamente alla Porta degli Archi: anche su questo edificio erano stati posti alcuni anelli della menzionata catena.
8. Chiesa.della.Maddalena
Scendendo lungo la via ai quattro canti di San Francesco, la quale anticamente era detta Mansura o contrada dei Mussi, arriviamo alla chiesa della Maddalena dinanzi a cui sostiamo perché sopra il suo ingresso stavano sospesi altri quattro anelli della catena.
9. Salita.di.Sant'Andrea
Da Luccoli, per uno dei vicoli che ascendevano alla Domoculta, saliamo idealmente alla scomparsa salita di Sant'Andrea oer rammentare i quattro anelli della catena del porto pisano che pendevano dalla sua facciata.
10. Chiesa.di.Sant'Ambrogio
Mediante il vico di Borgo sacco si scendeva nella strada dei sellai dove la chiesa di Sant'Ambrogio recava anch'essa sulla sua fronte gli anelli della stessa catena.
11. Chiesa.di.San.Matteo
Per la contrada delle prigioni detta più anticamente strada dei Toscani, corrispondente all'odierna via Tomaso Reggio, e per la salita all'arcivescovato scendiamo alla chiesa di San Matteo la quale, oltre ad esporre i consueti anelli, conservava un cimelio della battaglia della Meloria ricordato da Agostino Giustiniani: «Il stendardo Pisano col sigillo del Podestà fu riposto nella chiesa di S. Matheo».
12. Chiesa.di.Santa.Maria.delle.Vigne
Poco lungi da questa chiesa vi è quella di Santa Maria delle Vigne che si fregiava per essa degli anelli recati da Pisa nel 1290.
13. Chiesa.di.San.Donato
Compiendo il già percorso cammino il nostro itinerario ci conduce alla chiesa di San Donato dove nel 1290 furono sospesi, allo spigolo esterno del suo portale, quattro anelli della catena recata a Genova quale trofeo di guerra.
14. Porta.dei.Vacca
E per le strade di Giustiniani, Canneto il Curto, Banchi, San Luca, Fossatello e del Campo, incontriamo nuovamente le mura del XII secolo le quali avevano nella Porta dei Vacca il varco in direzione della riviera di ponente. Anche su questa porta si trovavano quattro anelli della catena suddetta i quali pendevano dall'apice sottostante all'arco esterno.
15. Chiesa.di.San.Sisto
Per la lunga strada di Pré si perviene alla chiesa di san Sisto, un'altra delle chiese già fregiate con detti anelli.
16. Commenda.di.San.Giovanni.di.Pré
Il nostro percorso si conclude di fronte alla commenda di San Giovanni di Pré, anch'essa onorata degli anelli che già avevano serrato il porto di Pisa. liguria@francobampi.it
ALBUM FOTOGRAFICO

“Alcuni pezzi delle catene di Porto Pisano, restituite dai genovesi nel 1860, oggi custodite nel cimitero monumentale di Pisa”.

Porta Soprana-Genova ritratta alla metà del XIX secolo da Domenico Cambiaso. Al centro dell'arco pendono alcuni anelli delle catene di Porto Pisano.

Maglie di catena del Porto Pisano a Murta, nel territorio del Comune di Genova.
![]()
Maglie delle Catene di Porto Pisano a Moneglia
(...) Come alleata di Genova contro Pisa, Moneglia, nel 1284 intervenne con sue navi alla battaglia della Meloria, ne sono testimoni due maglie della catena che chiudeva Porto Pisano, distrutto dai genovesi dopo la vittoria, ancora ben visibili sulla facciata della chiesa di Santa Croce, portate dal monegliese Trancheo Stanco. Parte di quelle antiche catene erano infisse sui principali monumenti genovesi, ma furono restituite all'antica rivale dopo l'Unità d'Italia.


Traduzione della lapide:
Nel nome del Signore così sia
Anno 1290
Questa catena fu portata via
dal porto di Pisa
la lapide fu posta dal signor
TRANCHEO STANCO DI MONEGLIA
battaglia della Meloria 1284
CAMPO PISANO – Genova
Una storia tanto gloriosa, quanto lugubre.
Una delle piazze più suggestive e meno note del centro storico, sempre avaro di spazi aperti, deve il suo nome e la sua storia a una delle pagine più gloriose e al tempo stesso tragiche della storia di Genova. Parliamo di Campo Pisano, la piazza a risseu sotto Sarzano, con i suoi alti palazzi che la chiudono a emiciclo. Vuole la tradizione, suggestiva ma probabilmente sbagliata, che l’appellativo “pisano” venga dalla battaglia della Meloria e da quello che ne seguì.
Tra migliaia di morti lasciati nel mare di Toscana, i genovesi catturarono circa 10 mila soldati nemici, compreso il comandante veneziano Alberto Morosini (Pisa per tradizione sceglieva un podestà straniero) e quel Rustichello che scriverà “Il Milione” per conto di Marco Polo, durante la prigionia genovese. I pisani condotti in città vennero sistemati in quest’area: ricchi e nobili vennero riscattati e riuscirono a salvarsi, mentre agli altri il destino riservò la morte, per stenti, per fame, per omicidio e il campo dei pisani divenne – anche, e soprattutto – il camposanto dei pisani. Passarono ben 13 anni prima che i pochi sopravvissuti (non più di qualche centinaia) venissero liberati, mentre nasceva il detto, drammatico e beffardo allo stesso tempo, “Se vuoi vedere Pisa vai a Genova”. Quello che era uno spazio libero e aperto venne edificato nel Cinquecento, poco prima di essere compreso tra le mura.

Campo Pisano

l nome deriva dal fatto che lì furono concentrati migliaia di prigionieri pisani, catturati dai genovesi al tempo delle Repubbliche Marinare.
Dal sito di Miss Fletcher:
La storica rivalità con la città di Pisa per il predominio del Mediterraneo sfociò, nel 1284, nella battaglia navale della Meloria, durante la quale i genovesi, sotto la guida di Oberto Doria, Benedetto Zaccaria ed Oberto Spinola, inflissero ai nemici una bruciante sconfitta.
I genovesi se ne tornarono a casa baldanzosi e trionfanti, portandosi via la catena del porto di Pisa come trofeo e l’appesero sulle Mura di Porta Soprana come simbolo visibile della loro vittoria, arrivarono persino a scioglierne le maglie per esporne gli anelli sui palazzi e sulle chiese più importanti della città.
Oltre a ciò, fecero di più: oltre novemila prigionieri tra i pisani, deportati e rinchiusi qui, in questa zona, in questa piazza.
Qui vissero, qui morirono e vi furono sepolti, da questo nasce il nome di questo angolo così suggestivo di Genova.
Sotto Campopisano c’è la sua storia, lì c’è il destino delle persone che vi hanno abitato, che laggiù hanno sognato e sofferto, nel ricordo della loro città natale che non avrebbero mai più rivisto.
Fa una certa impressione, almeno a me, camminare sui suoi ciottoli.
Che gente dura, i genovesi: sono aspri, di poche parole, sono schivi, chiusi, è proprio nel carattere dei liguri questo tratto così marcato, è il nostro segno distintivo.
E sono gente tosta i genovesi.
Se avete dei dubbi, guardate quale perentoria affermazione si trova incisa su un portale in Via di Santa Croce.

“Mi piego ma non mi spezzo”
Certo il padrone di casa doveva essere uno che sapeva farsi rispettare, non conveniva questionare con lui, senza dubbio avrà avuto dei dirimpettai mansueti ed accomodanti che, preso atto del motto di famiglia, avranno accuratamente evitato fastidiosi quanto inutili dissidi condominiali.

Il famoso Risseu di Campo Pisano
Camposanto Pisano a Genova dei prigionieri pisani della Meloria. La storia dei fantasmi di Campo Pisano ha la sua origine nel 1284 con la vittoria dei genovesi su Pisa nella battaglia della Meloria.
Questa piazza e la zona circostante viene edificata a partire dal XV secolo; successivamente essa venne inglobata nelle mura del XVI secolo. La piazza ha la forma di una ansa con le case alte e il pavimento a “risseu” bianchi e blu (i risseu sono “ricami di pietra” fatti utilizzando ciottoli marini usati a Genova e in Liguria per decorare le pavimentazioni dei selciati e delle piazze cittadine).
Il turista che oggi arriva in questa piazza viene colto dalla bellezza del luogo, con le sue alte case quasi intente ad abbracciare il viandante e il mare che compare in uno spiraglio tra le case che portano alla Marina. Ebbene, tutto questo romanticismo deve esser sfuggito ai novemila prigionieri pisani che vennero rinchiusi in questo luogo, i quali, a causa del rigido inverno e delle precarie condizioni nelle quali erano costretti a vivere, morirono quasi tutti e lì vennero seppelliti.
Le loro anime senza pace son ancora presenti in zona e c’è chi afferma che nelle notti di tempesta si possano ancora scorgere le sagome dei prigionieri pisani che in catene risalgono la scalinata che dalla Marina porta in Campo Pisano.” (tratto da http://www.isegretideivicolidigenova.com/ )
LA PIETRA DELLA CATENA PISANA

Il bassorilievo raffigurante il porto di Pisa con le due torri, Magnale e Formice, e la lunga catena stesa tra le stesse
(foto di Antonio Figari)

Particolare del bassorilievo raffigurante le catene del porto di Pisa
(foto di Antonio Figari)
“Le battaglie si vincono e si perdono con identico cuore. Io faccio rullare i tamburi per tutti i morti, per essi faccio squillare le trombe in tono alto e lieto, Vivan coloro che caddero, viva chi perde in mare i propri vascelli. Vivan coloro che affondano con essi. Vivan tutti i generali sconfitti e tutti gli eroi schiacciati e gli innumerevoli eroi sconosciuti, uguali ai più grandi conosciuti eroi.”
Walt Whitman
LE REPUBBLICHE MARINARE
(breve sintesi)
La definizione di repubbliche marinare, nata nel 1800, si riferisce alle città portuali italiane che nel Medioevo, a partire dal IX secolo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica.
La definizione è in genere riferita in particolare alle quattro città italiane i cui stemmi sono riportati nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. La bandiera della marina si fregia degli stemmi di queste quattro città dal 1947. Oltre alle quattro più note, tra le repubbliche marinare si annoverano però anche Ancona, Gaeta, Noli e la repubblica dalmata di Ragusa; in certi momenti storici esse ebbero un'importanza non secondaria rispetto ad alcune di quelle più conosciute.

Mappa delle Repubbliche Marinare Maggiori e Minori
Elementi che caratterizzarono una repubblica marinara sono:
l'indipendenza (de iure o de facto);
autonomia, economia, politica e cultura basate essenzialmente sulla navigazione e sugli scambi marittimi;
il possesso di una flotta di navi;
la presenza nei porti mediterranei di propri fondachi e consoli;
la presenza nel proprio porto di fondachi e consoli di città marinare mediterranee;
l'uso di una moneta propria accettata in tutto il Mediterraneo e di proprie leggi marittime;
la partecipazione alle crociate e/o alla repressione della pirateria.
Localizzazione e antichi stemmi delle repubbliche marinare

Venezia
La Repubblica di Venezia, detta "La Serenissima", ebbe per secoli un ruolo fondamentale nel commercio tra l'Europa e il Mediterraneo orientale; nel momento della sua massima espansione territoriale era riuscita a conquistare gran parte dell'Italia del Nord-Est, arrivando a pochi chilometri da Milano. Lungo le coste mediterranee si impossessò della penisola istriana, dell'intera Dalmazia (ma Ragusa fu veneziana solo per centocinquant'anni) e di vaste regioni della Grecia: le isole Ionie, la Morea (attuale Peloponneso, anche se solo temporaneamente), Creta, Cipro, Negroponte (attuale Eubea) e diverse altre isole dell'Egeo.

Genova
L'antagonista per eccellenza di Venezia fu Genova che nel 1298 sconfisse la flotta veneziana. La Repubblica di Genova ebbe vari epiteti in base alle proprie caratteristiche economiche, commerciali e navali: La Superba, La Dominante, La Dominante dei mari e La Repubblica dei Magnifici. Oltre ad una presenza significativa in Oriente e nel Mar Nero, aveva il monopolio dei commerci nel Mediterraneo occidentale. Notevole la sua massima espansione territoriale, che oltre alla Liguria e l'Oltregiogo, comprese Corsica, Sardegna, Crimea, Tabarca, Rodi, Creta, vaste aree della Grecia e della Turchia, Gibilterra, alcune zone della penisola Iberica, della Sicilia, alcune isole dell'Egeo e Pera, la colonia nell'odierna Istanbul di Galata a Costantinopoli.


Pisa
La Repubblica di Pisa ebbe una notevole importanza, anche per le conquiste territoriali che nel momento della sua massima espansione comprendevano la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari; era attiva soprattutto in Occidente; la rivalità con Genova e le guerre con Firenze le furono fatali.

Amalfi
Amalfi ebbe una storia gloriosa e pre coce di potenza marittima, e le navi amalfitane battevano i mari insieme a quelle veneziane quando le altre repubbliche ancora dovevano affermarsi. La città campana non occupò mai vasti territori ma ebbe il dominio commerciale nel Mediterraneo meridionale ed orientale molto prima di Venezia. Se la sua storia di indipendenza e di navigazione iniziò molto presto, anche la decadenza arrivò presto, principalmente a causa dell'arrivo dei Normanni nel Meridione, che soppressero le autonomie locali per dar vita al grande stato del Regno di Sicilia, oltre che per la rivalità delle nascenti repubbliche di Pisa e Genova.

L'attuale stemma della Marina Militare, così come rinnovato nel dicembre 2012
Lo stemma rinnovato
Lo stemma della Marina Militare è stato rivisto completamente, in particolar modo il quarto di Venezia, la croce pisana e la corona, dall'araldista Michele d'Andrea, autore, tra l'altro, del primo tentativo di modifica del leone di Venezia fatto durante la realizzazione della bandiera collonnella del Reggimento “San Marco”. Essendo i decreti del 1941 e del 1947 molto approssimativi, gli interventi di modifica del nuovo stemma non hanno richiesto un nuovo decreto, potendosi muovere tra le larghe maglie interpretative dei due testi;[11] lo stemma rinnovato è infatti stato ufficializzato con un semplice foglio d'ordine della marina, il n. 52 del 16 dicembre 2012.
È stata data nuova volumetria alle prue, prima quasi ridotte a dei bassorilievi, mentre per il loro disegno si è fatto riferimento alle prue bronzee che ornano il basamento delle aste portabandiera del Vittoriano. Le torri laterali mostrano una maggiore tridimensionalità e sono state pensate per essere più fedeli alla vista laterale del castelletto ligneo collocato nella porzione anteriore delle navi militari romane. L'ancora centrale è stata rimpicciolita e nel cerchio della corona sono scomparse le cordonate.
Il leone di San Marco è diventato più muscoloso e leonino, con una criniera più folta, zampe più possenti e una coda meno rigida. Il nimbo è stato ridisegnato, così come il mare (cinque righe di onde) che lambisce una visibile terraferma dove è poggiato, sotto la zampa anteriore sinistra del leone, il libro chiuso rilegato in cuoio rosso. Il simbolo di Pisa è stato privato delle nervature interne ed i pomi ora non hanno più le linee di contorno, come se fossero saldati alla croce, ora più dilatata (anche se non esistono regole per definire le proporzioni e gli angoli di detta croce).
Infine, è stato ridotto lo spessore del cavo torticcio d'oro per far risaltare i simboli araldici.
CARLO GATTI
Rapallo, 30 Maggio 2018
Bibliografia:
- “BENEDETTO ZACCARIA” - di Roberto S. LOPEZ - Ediz. CAMUNIA Editrice 1996 - Firenze
- Enciclopedia TRECCANI
- T.C.I - Toscana
- Genova e La Liguria - Insediamenti e culture Urbane - di Paolo Stringa. CA.RI.GE
- Enciclopedia Della Liguria - (IL SECOLO XIX) - 2000
- Genova - (IL SECOLO XIX) - 1992
- MEDIOEVO - Repubbliche Marinare - Il Clan dei Genovesi - De Agostini 1998
- Vari siti Web citati di volta in volta nel saggio
CAPO MISENO LA PIU’ POTENTE BASE MILITARE DELL’ANTICHITA’
CAPO MISENO
LA PIU’ POTENTE BASE MILITARE DELL’ANTICHITA’

PREMESSA STORICA
All'inizio del 1800 La Spezia era un piccolo borgo dell'impero napoleonico, con una popolazione, di circa 3000 persone. Napoleone Bonaparte, intuì l'importanza strategica del Golfo e fece progettare la costruzione di un grande Arsenale, ma le sue sconfitte a Lipsia e a Waterloo ne impedirono la realizzazione.
Dopo la caduta dell'Impero napoleonico, i territori dell'antica Repubblica di Genova furono incorporati dal Regno di Sardegna.
Il 3 febbraio 1851 segnò una data importante per il decollo del porto e quindi di tutte le attività industriale e commerciali genovesi; Cavour, allora Ministro della Marina, Agricoltura e Commercio presentò al Parlamento Subalpino il progetto di legge per il trasferimento a La Spezia degli stabilimenti militari marittimi e programmò per Genova un deposito franco per il miglioramento dei commerci via mare, l’operazione, come sappiamo andò a buon fine!
L'idea di Napoleone fu ripresa tout court da Camillo Benso Conte di Cavour che ottenne nel 1857 il trasferimento della Marina Militare da Genova a La Spezia e il finanziamento per la costruzione di un Arsenale Militare.
La costruzione dell'arsenale militare marittimo di Taranto fu comunque decisa dal Parlamento Italiano con la legge n. 833 del 29 giugno 1882, per rimediare alla sempre crescente necessità di difesa dell'Italia protesa verso il Mar Mediterraneo.
Nel 1864, Camillo Benso Conte di Cavour fu il primo politico italiano a comprendere la valenza strategica di Augusta, come possibile sede di base navale della Regia Marina; ma il quel momento storico il pericolo per la giovane Nazione Italiana era percepito da est e da nord e quindi si preferì puntare sull’Adriatico e il Tirreno e sviluppare la base di Taranto.
Il grande statista piemontese, così come fece Napoleone Bonaparte, s’ispirò alla strategia degli ANTICHI ROMANI: la base di Miseno fu strutturata come una potentissima macchina militare cui era affidato il controllo sull'intero Mediterraneo occidentale, dalle coste tirreniche dell'Italia alle colonne d'Ercole e oltre. Si trattava di uno dei due principali punti di appoggio del potere imperiale: l'altro era costituito dalla flotta basata a Ravenna, competente per il Mediterraneo orientale. Dati i mezzi di trasporto dell'epoca, le due armate di mare costituivano i reparti dell'esercito imperiale che più rapidamente potevano raggiungere località, anche lontane, dove si manifestavano focolai di crisi o dove, comunque, era necessario, far sentire la presenza militare di uno Stato vastissimo e cosmopolita quale era l'Impero Romano.

Baia (ricostruzione)

Pozzuoli (ricostruzione)

Campi Flegrei

Veduta da Monte di Procida con la spiaggia di Miliscola, Capo Miseno e il bacino interno dell'antico porto di Miseno.

Il porto di Miseno sorgeva su un precedente cratere vulcanico allagato dal Mar Tirreno.

La parte più interna del porto, un lago naturale, quasi chiusa da una lingua di terra, sulla quale era posto il castrum dei classiarii.
Il porto di MISENO (Misenum) si trovava presso l’attuale Bacoli e l’omonimo Capo Miseno, simile per conformazione a quello di Ravenna. Poteva contenere almeno fino a 250 imbarcazioni, come quello di Classe a Ravenna. In età augustea, in seguito all’impraticabilità del precedente porto militare di Portus Iulius nella baia di Puteoli (utilizzato da Ottaviano e Agrippa durante la guerra contro Sesto Pompeo), la vicina Miseno divenne la più importante base militare della flotta romana a guardia del bacino del Mediterraneo occidentale.
L’Imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto
(Roma 23 settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14)
Fondatore della Praetoria Classis Misenenis (Flotta Imperiale Romana)

Battaglia di Azio
Augusto, dopo la battaglia di Azio (2 settembre 31 a.C.), decise di compiere una radicale riforma della marina militare. La flotta fu organizzata come un vero e proprio esercito sul mare e coloro che prima erano volontari, divennero professionisti impegnati a servire la flotta prima per sedici e poi per vent'anni. Nel 6 d.C. creò l’aerarium militare, ovvero delle risorse finanziare permanenti che ne permettessero il finanziamento-autonomo.
La flotta all’inizio venne dislocata in Gallia Narbonese, a Forum Iulii, (oggi Fréjus, in Francia sulla costa mediterranea) ma questa base venne sciolta durante la dinastia giulio-claudia e vennero lasciate solo due flotte Praetoriae. Una a Capo Miseno, per la difesa del Mediterraneo occidentale, con la Classis Misenensis composta da circa cinquanta natanti e circa diecimila marinai classiarii, quasi due legioni terrestri. L’altra a Ravenna, la Classis Ravennatis, per la difesa del Mare Nostrum orientale. Le due Classis erano al comando di un prefetto e ad esse si affiancavano le flotte delle provincie a supporto delle armate terrestri: la Classis Alexandrina in Egitto, la Classis Germanica sul fiume Reno e la Classis Pannonica nel bacino Danubio-Rava e Sava.

OTTAVIANO AUGUSTO

MISENO
Per cinque secoli a presidio di un Impero
L’OPERA che segue é un documento di rara importanza e bellezza! Tratta delle Norme destinate ai comandanti di una flotta.
Le LIBURNE di stanza presso la Campania erano agli ordini del comandante della flotta di Miseno; quelle che navigavano nel mare Ionio, invece, erano guidate dal comandante della flotta ravennate; in sottordine ad entrambi i comandanti erano dieci tribuni delegati da ogni singola coorte.
Ogni liburna aveva il proprio capitano, vale a dire il nocchiero, che oltre alle incombenze della marineria aveva cura di addestrare quotidianamente i timonieri, rematori, i combattenti.
Il seguente documento composto di 16 Capitoli, non solo abbraccia gran parte del SAPERE di un Capitano di mare di parecchi secoli fa, ma costituisce nello stesso tempo la summa degli elementi fondanti della scienza nautica futura per chi intenda andar per mare, sia egli un militare oppure un navigante mercantile!
|
PRÆCEPTA di Vegezio (dal libro IV del De re militari) [1] |
versione italiana e note a cura di DOMENICO CARRO
| Sommario:
- XXXI: Precetti della guerra navale.
|
XXXI. PRECETTI DELLA GUERRA NAVALE.
Per ordine della tua Maestà, o invitto imperatore, avendo portato a termine il trattato relativo alla guerra terrestre, manca ancora, a mio avviso, quella parte che riguarda la guerra navale ["navalis belli"], sulla cui dottrina c’è pochissimo da dire, giacché, essendo da un pezzo pacificato il mare ["pacato mari"], non si tratta che di condurre contro i barbari delle battaglie terrestri ["terrestre certamen"].
Il popolo romano, per il suo prestigio e per le esigenze della sua grandezza, pur non essendovi costretto da alcun imminente pericolo, in ogni tempo mantenne allestita la flotta ["classem"], onde averla sempre pronta ["praeparatam"] ad ogni necessità. Indubbiamente, nessuno osa sfidare o arrecare danno a quel regno o popolo, che sa essere pronto a combattere e risoluto a resistere ed a vendicarsi.
Pertanto, con le flotte ["cum classibus"] erano stanziate una legione presso Miseno ed una presso Ravenna, sia perché non si allontanassero eccessivamente dalla difesa di Roma, sia perché, all’insorgere di un’esigenza, potessero recarsi con le navi ["navigio"], senza indugio e senza dover aggirare la Penisola, in qualsiasi parte del mondo.
Infatti la flotta Misenense ["Misenatium classis"] aveva nelle sue vicinanze la Gallia, le Spagne, la Mauretania, l'Africa, l'Egitto, la Sardegna e la Sicilia. La flotta Ravennate ["classis Ravennatium"] soleva raggiungere con navigazione diretta ["directa navigatione"] l'Epiro, la Macedonia, la Grecia, la Propontide, il Ponto, l'Oriente, Creta e Cipro. Ciò perché nelle operazioni belliche la celerità giova di solito più del valore.
XXXII. DENOMINAZIONE DEI COMANDANTI IN UNA FLOTTA.
Il comandante della flotta ["praefectus classis"] Misenense era preposto alle navi da guerra ["liburnis"] che erano di base in Campania, mentre il comandante della flotta Ravennate reggeva quelle che erano nelle acque del mare Ionio [incluso l’Adriatico].
Alle dipendenze di ciascuno di loro vi erano dieci tribuni ["deni tribuni"] delegati per le singole coorti.
Ogni galea aveva il proprio comandante ["navarchus"], che è all’incirca l’equivalente dell’armatore ["navicularius", per le navi mercantili], il quale, oltre agli altri compiti nautici ["nautarum officiis"], curava l’addestramento quotidiano dei timonieri ["gubernatoribus"], dei rematori ["remigibus"] e dei militi navali ["militibus"].
XXXIII. ORIGINE DEL NOME DI LIBURNA.
Diverse provincie, nelle varie epoche, furono molto potenti per mare; vi furono quindi diversi tipi di navi ["genera navium"]. Sennonché, avendo Augusto combattuto la battaglia navale d'Azio, poiché Antonio venne sconfitto con il concorso determinante dei Liburni, con l'esperienza di sì gran battaglia si rese manifesto che le navi liburniche erano migliori di tutte le altre, avendone dunque ripreso la foggia e il nome, gli imperatori romani costruirono le loro flotte avvalendosi di quel modello. La Liburnia, che fa parte della Dalmazia, è amministrata dalla città di Iadera [odierna Zara], ad imitazione della quale si costruirono le navi da guerra e si chiamarono liburne["liburnae"].
XXXIV. PRECAUZIONI NELLA COSTRUZIONE DELLE NAVI DA GUERRA.
Se nella costruzione delle case è richiesta la buona qualità della sabbia e delle pietre, tanto più nel costruire le navi ["fabricandis navibus"] deve essere diligentemente ricercato ogni materiale, giacché, qualora difettosa, costituisce un maggior pericolo una nave piuttosto che una casa.
La galea si compone principalmente di legno di cipresso e di pino domestico o selvatico, di larice e di abete, ed è più utile che sia connessa con chiodi di rame anziché di ferro. Sebbene la spesa sembri alquanto più gravosa, tuttavia, tenuto conto della maggior durata, ne risulta invece un guadagno; infatti, con il caldo e l’umidità, i chiodi di ferro vengono presto consumati dalla ruggine; quelli di rame si conservano invece integri anche in mezzo ai flutti.
Occorre principalmente assicurare che gli alberi utilizzati per costruire le navi da guerra siano tagliati dal quindicesimo al ventitreesimo giorno dopo la luna nuova, poiché soltanto il legname tagliato in questi otto giorni si conserva immune al tarlo. Tagliato in altri giorni anche nello stesso anno, corroso internamente dai vermi si converte in polvere, come ci ha insegnato la stessa arte e la pratica quotidiana di tutti gli architetti, e come apprendiamo anche dalla considerazione della religione , alla quale piacque celebrare soltanto questi giorni per l'eternità.
XXXVI. MESI NEI QUALI SI TAGLIANO LE TRAVI.
Le travi si tagliano utilmente dopo il solstizio di estate, nei mesi di luglio e di agosto, e nell’equinozio di autunno, sino alle calende [cioè il 1°] di gennaio, poiché in questi mesi, asciugatasi l’umidità, il legname è più secco e quindi più resistente.
Occorre inoltre evitare che le travi si seghino subito dopo l’abbattimento dell’albero, e che appena segate non si pongano in opera per la costruzione della nave, giacché il legno degli alberi ancora interi e quello in tavole, per diventare più asciutto, merita una doppia essiccazione. Infatti, le tavole che si commettono verdi, quando abbiano trasudato l'umidità naturale, si contraggono e formano delle fessure più larghe: nulla è più pericoloso ai naviganti ["navigantibus"] che una tavola verde.
XXXVII. TIPI DI NAVI DA GUERRA.
Per quanto attiene alle dimensioni, le navi da guerrae più piccole hanno un sol ordine di remi ["remorum singulos ordines"], due ["binos"] quelle un poco più grandi; quelle di dimensioni convenienti possono averne tre o quattro ["ternos vel quaternos"], e in qualche caso anche cinque ["quinos"]. Né ciò sembri qualcosa di straordinario: difatti si narra che alla battaglia navale d'Azio abbiano partecipato vascelli ["navigia"] di gran lunga maggiori, muniti anche di sei o più ordini di remi ["senorum vel ultra ordinum"].
In ogni modo, alle navi da guerra più grandi si associano delle unità sottili da esplorazione ["scaphae exploratoriae"], con dieci remi per lato, che i Britanni chiamano picati [cioè impeciati]. Queste si usano per fare incursioni e talvolta per intercettare delle vettovaglie delle navi nemiche, mentre, esercitando la sorveglianza, si scopre l’avvicinamento o le intenzioni delle stesse navi nemiche.
Tuttavia, affinché la presenza degli esploratori ["exploratoriae naves"] non sia tradita dal loro stesso chiarore, si tingono le vele ed i cavi delle manovre di colore azzurro ["veneto"], che somiglia a quello delle onde marine ["marinis fluctibus"], e vi si spalma anche quella cera che si usa per gli scafi delle navi.
Inoltre, i marinai ["nautae"] ed i militi navali ["milites"] indossano abiti azzurri, per rimanere più facilmente occulti all’osservazione nemica, non solo di notte, ma anche di giorno.
XXXVIII. DENOMINAZIONE DEI VENTI E LORO NUMERO.
Chiunque trasporti un esercito con le navi ["armatis classibus"] deve saper riconoscere i presagi delle tempeste, poiché le navi da guerra andarono miseramente a fondo più spesso a causa delle burrasche e dei marosi che per la forza dei nemici. In ciò si deve adoperare tutta la perizia della filosofia naturale, poiché dalla conoscenza del cielo si desume la natura dei venti e delle tempeste. E quando il mare infuria, come la cautela protegge i previdenti, così l’incuria distrugge i negligenti.
Pertanto, l’arte della navigazione ["ars navigandi"] deve anzitutto considerare attentamente il numero ed i nomi dei venti. Gli antichi credevano che, conformemente alla posizione dei punti cardinali, vi fossero solo quattro venti principali, spiranti dalle singole parti del cielo; ma l'esperienza posteriore ne trovò dodici. Di questi, per rimuovere ogni dubbio, forniamo non solo i nomi greci, ma anche quelli latini; così, dopo aver mostrato i venti principali, indicheremo quelli che sono ad essi contigui a destra e a sinistra.
Cominciamo pertanto dal solstizio di primavera, cioè dal punto cardinale Est, dal quale si origina il vento Afeliote, vale a dire il Subsolano; alla sua destra è contiguo al Cecia, o Euroboro; alla sua sinistra l’Euro o Volturno.
Il punto cardinale Sud ha il Noto, cioè l'Austro, alla cui destra vi è il Leuconoto, cioè il "bianco Noto"; alla sua sinistra il Libonoto, cioè il Coro.
Il punto cardinale Ovest possiede lo Zeffiro, cioè il Subvespertino, alla cui destra è contiguo il Lips, ossia l'Africo; a sinistra il Giapice, ossia il Favonio.
Al Nord toccò in sorte l'Aparzia o Settentrione, al quale è contiguo a destra il Trascia o Circio, a sinistra il Borea o Aquilone.
Questi venti soffiano spesso da soli, qualche volta in coppia, e nelle grandi tempeste anche in tre simultaneamente. Per il loro impeto, i mari, che sono per loro natura tranquilli e quieti, infuriano con onde ribollenti; quando spirano alcuni di essi, a seconda delle stagioni e delle regioni, dalla tempesta ritorna il sereno, e di nuovo questo si tramuta in burrasca.
Con il vento favorevole le navi ["classis"] raggiungono il porto desiderato, con quello contrario sono costrette a fermarsi, o tornare indietro, o affrontare una prova decisiva. Pertanto, difficilmente compie un naufragio chi ha esaminato con diligenza la natura dei venti.
XXXIX. MESI PIÙ SICURI PER LA NAVIGAZIONE.
Proseguiamo con la trattazione dei mesi e dei giorni, giacché il vigore e la durezza del mare non tollera tutto l'anno i naviganti ["navigantes"], ma per legge di natura alcuni mesi sono adattissimi alle flotte ["classibus"], altri dubbi, altri intollerabili.
La navigazione si reputa sicura ["secura navigatio creditur"] … dopo che sono sorte le Pleiadi, dal giorno VI prima delle calende di giugno [27 maggio] fino al sorgere di Arturo, cioè fino al giorno XVIII prima delle calende di ottobre [14 settembre], giacché per beneficio dell'estate si mitiga l’asprezza dei venti.
Successivamente, la navigazione è incerta ["incerta navigatio est"], e quindi piuttosto critica, fino al giorno III prima delle idi di novembre [11 novembre], giacché dopo le idi di settembre [13 settembre] nasce Arturo, stella rabbiosissima; poi, il giorno VIII prima delle calende di ottobre [24 settembre] sopraggiunge il pungente maltempo equinoziale, verso le none di ottobre [7 ottobre] appaiono i Capretti piovosi e il giorno V prima delle idi di tale mese [11 ottobre] appare il Toro.
Dal mese di novembre, poi, il tramonto invernale delle Vergilie, le navi ["navigia"] con frequenti tempeste. I mari vengono dunque chiusi alla navigazione dal giorno III prima delle idi di novembre [11 novembre] fino al giorno VI prima delle idi di marzo [10 marzo]. In effetti, la luce diurna ridotta al minimo, la notte prolungata, la densità delle nubi, l'oscurità dell'aria, la raddoppiata violenza dei venti, delle piogge o delle nevi, respingono non solo le flotte ["classes"] dalle rotte marittime, ma anche i viandanti dai viaggi terrestri.
In realtà, dopo la ripresa della navigazione ["natalem navigationis"], che viene celebrata con solenni giochi e pubblici spettacoli presso molte popolazioni, permane pericoloso cimentarsi in mare fino alle idi maggio [15 maggio], a causa di molteplici costellazioni e della stessa stagione; non lo dico perché cessi il traffico mercantile ["negotiatorum"], ma perché occorre adoperare una maggior cautela quando l'esercito naviga con le navi da guerra, che quando l'audacia accelera i profitti dei commerci privati.
XL. OSSERVAZIONE DEGLI ASTRI RECANTI TEMPESTE.
Inoltre, il sorgere ed il tramontare di molte altre stelle suscitano violentissime tempeste ["tempestates"], di cui sono stati indicati i precisi giorni, per attestazione di molti autori. Tuttavia, poiché tali giorni vengono alquanto cambiati da svariate cause, e poiché, bisogna confessarlo, alla natura umana non è consentito conoscere compiutamente i fenomeni celesti, lo studio delle osservazioni nautiche ["nauticae observationis"] è stato diviso in tre parti. Si è infatti scoperto che le tempeste avvengono o nel giorno stabilito, o prima, o dopo. Quindi, quelle che nascono nel giorno stabilito si chiamano con parola greca cheimaton, quelle che precedono procheimaton, le susseguenti metacheimaton. Comunque, elencare per nome ogni cosa apparirebbe lungo o inopportuno, dato che molti autori hanno descritto non solo la natura dei mesi, ma anche dei giorni.
Anche i transiti degli astri che chiamano pianeti, quando lungo il loro percorso prestabilito per volere divino entrano ed escono da un segno zodiacale, usano spesso turbare il sereno. Per contro, i giorni di interlunio sono valutati, non solo dalla scienza, ma anche dall’esperienza popolare, pieni di tempeste e da temersi al massimo grado da parte dei naviganti ["navigantibus"].
Da molti altri segni si preannuncia l’arrivo delle burrasche dalla calma, e della bonaccia dalle tempeste; tali eventi sono mostrati sul disco della Luna come in uno specchio. Il colore rubicondo annunzia i venti; il ceruleo, le piogge; un colore intermedio, nuvoloni e furenti burrasche. Il disco giocondo e lucente promette alle navi ["navigiis"] la serenità ch’esso reca nel suo stesso aspetto, soprattutto se al primo quarto e non sia né rosseggiante con i corni smussati, né offuscato dall’umidità.
Anche del Sole che sorge o che tramonta, è interessante osservare se splende con raggi uniformi o diversificati da una nube interposta, se è fulgido del consueto splendore o ardente per i venti incalzanti, se è pallido o macchiato per la pioggia imminente.
Indubbiamente anche l'aria e lo stesso mare, così come la grandezza e la qualità delle nuvole, forniscono istruzioni ai marinai ["nautas"] preoccupati.
Alcuni segni vengono indicati dagli uccelli, altri dai pesci: Virgilio, con ingegno quasi divino, li incluse nelle Georgiche e Varrone li perfezionò diligentemente nei sui libri navali ["libris navalibus"] .
I timonieri ["gubernatores"] dichiarano di sapere queste cose, ma le conoscono così come le appresero dall’esperienza pratica, e non rafforzate da una più elevata dottrina.
L’elemento marino costituisce la terza parte del mondo, e si anima, oltre che per il soffio dei venti, anche per un suo proprio respiro e movimento. Infatti, a certe ore, di giorno come di notte, un certo moto del mare, che chiamano marea, scorre in un senso e nell'altro e, come un torrente o un fiume, ora inonda le terre, ora rifluisce in alto mare. Questa ambiguità del moto alterno, se favorevole, giova alla rotta delle navi ["cursum navium"], se contrario, la ritarda.
Ciò deve essere evitato con grande cautela da chi sta per combattere. Infatti non si vince con l’ausilio dei remi l'impeto della marea, cui talvolta cedono anche i venti. E poiché nelle varie regioni, nei diversi stati della luna crescente o calante, a certe ore questi fenomeni variano, quindi chi sta per sostenere un combattimento navale ["proelium navale"] deve, prima dell’ingaggio, conoscere la natura del mare e del luogo.
XLIII. CONOSCENZA DELLE ACQUE E IMPORTANZA DEI REMATORI.
La perizia dei marinai ["nauticorum"] e dei timonieri ["gubernatorum"] consiste nel prendere conoscenza delle acque nelle quali si naviga e dei porti, onde evitare i luoghi pericolosi per gli scogli affioranti o sommersi, i bassi fondi e le secche; infatti, si avrà tanta maggior sicurezza quanto il mare sarà più profondo.
Nei comandanti navali ["navarchis"] si predilige la diligenza, nei timonieri ["gubernatoris"] l’esperienza, nei rematori ["remigibus"] la valentia. Infatti, la battaglia navale ["navalis pugna"] si combatte in mare tranquillo; e la mole delle navi da guerra, non per il soffio dei venti, ma per impulso di remi percuote con il rostro gli avversari e schiva invece il loro impeto. In tali circostanze, i muscoli dei rematori ["remigum"] e l'arte del pilota che regge il timone ["clavum regentis magistri"] sono i principali artefici della vittoria.
XLIV. ARMI E MACCHINE BELLICHE NAVALI.
La battaglia terrestre richiede indubbiamente molti generi di armi, ma la lotta navale ["navale certamen"], non solo esige un maggior numero di armi, ma anche macchine d’assalto ["machinas"] e macchine da lancio ["tormenta"], come se si dovesse combattere sulle mura e sulle torri. Che cosa vi è di più crudele, infatti, di un attacco navale ["congressione navali"] in cui gli uomini sono uccisi dalle acque e dalle fiamme?
Pertanto, la principale cura deve essere posta per le armature, di modo che i militi siano protetti da corazze metalliche o di cuoio, ed anche da elmi e schinieri. Nessuno può dolersi del peso delle armi, poiché combatte a bordo delle navi ["in navibus"] mantenendosi sul posto. Si impiegano anche gli scudi più ampi e più resistenti ai colpi delle pietre, oltre che alle falci ["falces"], ai ramponi ["harpagones"] ed agli altri tipi di armi da getto navali ["navalia genera telorum"].
Da parte nostra, si schierano frecce, armi da getto, fionde, mazzafromboli, palle di piombo, onagri, balestre, scorpioni, con proiettili e sassi; e, cosa più importante, coloro che sono resi temerari dal proprio coraggio, accostate le navi da guerra e gettate le passerelle, passano sulle navi avversarie ed ivi, come suol dirsi, ai ferri corti, combattono corpo a corpo con le spade.
Inoltre, nelle navi da guerra più grandi si stabiliscono ripari e torri, per poter più agevolmente ferire o uccidere i nemici dai tavolati più alti, come da un muro. Con le balestre si infiggono nelle carene delle navi nemiche delle frecce avvolte con stoppa – imbevuta di olio incendiario, zolfo e bitume – ed infiammate; e le tavole spalmate di cera, pece e resina, con tanto alimento d'incendio repentinamente prendono fuoco. Alcuni sono uccisi dalla spada e dalle pietre, altri sono costretti ad ardere tra le onde; tuttavia, fra tanti generi di morte, il caso più crudele è quello dei corpi che rimangano insepolti, in pasto ai pesci.
XLV. CRITERI PER TENDERE INSIDIE PER MARE.
A somiglianza dei combattimenti terrestri, si conducono degli assalti improvvisi contro gli equipaggi ["nauticis"] che non se l’aspettano, o si tendono degli agguati negli opportuni passaggi ristretti fra le isole.
E per annientare più facilmente coloro che vengono presi alla sprovvista, si procede come segue: se i marinai nemici ["hostium nautae"] sono affaticati dal lungo vogare, se vengono travagliati dal vento contrario, se la corrente di marea è a favore dei nostri rostri, se i nemici dormono senza alcun sospetto, se l’ancoraggio che occupano non ha vie d’uscita, se si verifica l’auspicata occasione di combattere, allora con il favore della sorte si deve andare all’ingaggio e attaccare battaglia come opportuno.
E a questo proposito, se la cautela dei nemici, evitate le insidie, opponga un combattimento ordinato, allora si deve disporre la formazione delle navi da guerra non in linea retta come sul terreno, ma incurvata a mezza luna, in modo che la forza navale, con i due corni in avanti, sia incavata in centro; così, se i nemici tentassero di sfondare, circondati dalla stessa formazione saranno affondati. D’altra parte, nei corni si pone il nerbo insigne delle navi da guerra e dei militi.
XLVI. CRITERI PER LA BATTAGLIA NAVALE.
Inoltre, è utile che la tua flotta ["classis"] si mantenga sempre al largo ["alto et libero mari"] e spinga verso costa quella nemica, poiché quelli che sono ricacciati a terra perdono l'ardore di combattere. È stato accertato che in tali combattimenti giovarono moltissimo alla vittoria tre generi di armi: le stanghe, le falci e le bipenni.
Si chiama stanga ["asser"] quella trave sottile e lunga, che è appesa all'albero ["malo"] come un pennone ["antemnae"] ed ha entrambe le estremità ferrate. Le navi nemiche, accostandosi da destra o anche da sinistra, sono da essa colpite con forza, come da un ariete; ed essa senza dubbio abbatte ed uccide i combattenti ["bellatores"] o i marinai ["nautas"] nemici, e più spesso sfonda la stessa nave.
La falce ["falx"] è un ferro affilatissimo e curvo come una falce agricola, il quale, fissato su pertiche delle più lunghe, recide d'un tratto le drizze ["chalatorios"] – sono le manovre ["funes"] che tengono sospeso il pennone ["antemna"] – e, avendo fatto cadere le vele della galea avversaria, la rende più indolente ed inutile.
La bipenne ["bipennis"] è una scure che ha una lama larghissima ed affilatissima da entrambe le parti. Con queste armi, nel pieno fervore del combattimento, i marinai ["nautae"] o i militi ["milites"] più esperti, imbarcatisi sulle più piccole imbarcazioni ["scafulis"], tagliano di nascosto i cavi ["funes"] con i quali sono tenuti i timoni ["gubernacula"] delle navi nemiche. Fatto ciò, queste vengono immediatamente catturate, come se fossero navi inermi ed impotenti; e, infatti, quale mezzo di salvezza rimane a chi ha perduto il timone ["clavum"]?
Delle navi fluviali ["lusoriis"], che tutelano posti di confine con la vigilanza quotidiana sul Danubio, stimo preferibile tacere, poiché dal loro più frequente uso recente, l'arte nautica ha scoperto più di quanto l'antica dottrina avesse insegnato.
Eruzione del Vesuvio del 79 d.C. – La morte di Plinio il Vecchio
Testimonianze storiche:
FUGA DAL VESUVIO - In questo paradiso naturale, già apprezzato e frequentato all'epoca dei Romani (e certamente anche prima che l’egemonia romana si estendesse sulla penisola) nell'estate del 79 d.C. successe il “finimondo”.
È quanto racconta Plinio il Giovane (61 d.C. – 112 d.C.), testimone oculare dei fatti, nella seconda delle due lettere inviate a Tacito (lo storico dell’Impero romano). Dice, infatti, lo scrittore romano che “fra quelli che fuggivano da Miseno per mettersi in salvo, ce n'erano molti che si disperavano dicendo che quella era l'ultima notte del mondo". E Miseno è a più di 20 km da Ercolano, e a circa 30 km da Pompei!
Nell'anno 79 d.C. (data della catastrofe pompeiana, secondo una probabile ricostruzione storica), sotto l'imperatore Tito Flavio Vespasiano, figlio di Vespasiano, a Capo Miseno, più esattamente nell'insenatura di Baia, si trovava di stanza la flotta romana al comando del navarca (ammiraglio) Plinio (il Vecchio), uomo politico e letterato, oltre che valente naturalista. Con lui c'era la sua famiglia, costituita dalla sorella e dal diciottenne figlio di lei.
Il ragazzo, anch’egli Plinio (il Giovane), in quanto adottato dallo zio, dovette conservare il nome gentilizio della famiglia, a scapito di quello del padre naturale. Successivamente, divenuto a sua volta un importante uomo pubblico, nel 107 (si era frattanto al tempo dell'imperatore Traiano) inviò due lettere a Tacito in cui gli descrive l'eruzione del Vesuvio; e, tra le altre cose, racconta anche come in quella occasione era morto suo zio; nella speranza che Tacito, il quale in quegli anni andava pubblicando le sue Storie, se ne servisse come documentazione.
Plinio il Giovane, nella prima lettera a Tacito, descrive così l'inizio dell'eruzione e lo sviluppo della colonna eruttiva, che egli, insieme allo zio, osserva da Miseno:
Era a Miseno [Plinio il Vecchio] e, presente, governava la flotta. Il 24 agosto era trascorsa appena un'ora dopo mezzogiorno e mia madre gli mostra una nuvola che allora appariva, mai vista prima per grandezza e figura. [...] La nube si levava, non sapevamo con certezza da quale monte, poiché guardavamo da lontano; solo più tardi si ebbe la cognizione che il monte fu il Vesuvio. La sua forma era simile ad un pino più che a qualsiasi altro albero.
Come da un tronco enorme la nube svettò nel cielo alto e si dilatava e quasi metteva rami. Credo, perché prima un vigoroso soffio d'aria, intatto, la spinse in su, poi, sminuito, l'abbandonò a se stessa o, anche perché il suo peso la vinse, la nube si estenuava in un ampio ombrello: a tratti riluceva d'immacolato biancore, a tratti appariva sporca, screziata di macchie secondo il prevalere della cenere o della terra che aveva sollevato con sé.
Segue, nella lettera, il racconto degli eventi che portarono alla morte di Plinio il Vecchio. Questi, attratto dallo straordinario fenomeno, decide di avvicinarsi, con una piccola imbarcazione, alla zona interessata. Nel frattempo riceve un messaggio con un invocazione di aiuto da parte di amici (Rettina, moglie di Tascio) che si trovano nell'area vesuviana.
Egli cambia idea: all'ansia dello scienziato subentra lo spirito dell'eroe. Fa scendere a mare le quadriremi, vi prende posto. Egli vuole portare soccorso non solo a Rettina, ma a molti, perché la ridente contrada era frequentata.
S'affretta là donde altri fuggono e tiene dritta la rotta e il timone diritto verso il pericolo, senza traccia di paura al punto che dettava e annotava tutte le variazioni di quel male, tutte le figure che i suoi occhi avevano sorprese.
Plinio dirige le sue navi verso Torre del Greco, ma non riuscendo a sbarcare, fa rotta su Stabia, dove si trova la villa dell'amico Pomponiano:
Già sulle navi la cenere cadeva, più calda e più fitta man mano che si avvicinavano; già cadevano anche i pezzi di pomice e pietre annerite ed arse e spezzettate dal fuoco; già, inatteso, un bassofondo e la riva, per la rovina del Monte impedisce lo sbarco. Ebbe un momento di esitazione, se dovesse tornare indietro e il pilota così lo consigliava, ma egli subito disse: "la Fortuna aiuta i forti. Raggiungi Pomponiano!"
[...]
Lì Pomponiano aveva fatto caricare su navi il bagaglio ed era determinato a fuggire, se il vento contrario si fosse placato. Per mio zio, invece, il vento soffia molto propizio ed egli riesce a sbarcare. Abbraccia il trepido amico, lo consola, gli fa coraggio.
[...]
Frattanto dal Monte Vesuvio rilucevano in più di un punto estesi focolai di fiamme ed alte colonne di fuoco: il loro fulgore spiccava più chiaro sulle tenebre della notte.
Quella notte Plinio, ospitato nella villa dell'amico, si ritirò nel suo appartamento, e si addormentò. Ma...
[...] il cortile da cui si accedeva all'appartamento, per cumulo di cenere e lapilli, aveva tanto accresciuto il suo livello che egli, se avesse ancora indugiato nella stanza, non sarebbe potuto uscirne più. Perciò fu svegliato. Venne fuori e si ricongiunse a Pomponiano e gli altri che mai avevano ceduto al sonno.
Discutono tra loro se sia interesse comune rimanere dentro l'abitazione o vagare all'aperto. La casa, infatti, vacillava per frequenti e violente scosse di terremoto, e, quasi divelta dalle sue fondamenta, pareva ondeggiare ora qui ora là, e poi ricomporsi di nuovo in quiete.
D'altronde, all'aperto si temeva la caduta di lapilli, anche se lievi e corrosi. Tuttavia si confrontarono i rischi e si scelse di uscire all'aperto. In lui pensiero su pensiero prevalse, negli altri paura su paura. Mettono dei guanciali sul capo e li legano fortemente con teli: in tal modo si difendevano dalla pioggia di lapilli.
Già altrove era giorno, lì era notte: una notte più fitta e più nera di tutte le notti. Tuttavia la rischiaravano molte bocche di fuoco e varie luci.
Deliberarono di raggiungere la spiaggia e di vedere dal punto più vicino possibile se ormai il mare consentisse un tentativo di fuga. Ma il mare ancora grosso continuava ad essere contrario. Lì egli buttò giù un telo e vi si sdraiò...
Plinio il Vecchio, probabilmente intossicato dai gas, viene colpito da un malore e, non potendo continuare la fuga, viene abbandonato dai compagni. Il suo corpo sarà ritrovato solo tre giorni più tardi. La lettera si conclude con una postilla:
Tutta la mia narrazione è fondata sull'esperienza diretta e sulle notizie udite immediatamente dopo la catastrofe, quando la memoria degli eventi è prossima alla verità. Tu farai una selezione dei fatti più importanti, perché scrivere una lettera non è lo stesso che scrivere una storia, come scrivere per un amico non è lo stesso che scrivere per tutti.
Tacito si mostrò, invece, molto interessato alla vicenda personale dell'amico e lo pregò di scrivergli ancora, per fargli conoscere come egli visse, a Miseno, quei tragici eventi. Così Plinio il Giovane scrisse la seconda lettera, in cui è riportata la descrizione di intensi fenomeni che si sarebbero verificati anche nell'area flegrea in occasione dell'eruzione del 79 d.C. Infatti, lui, sua madre e molti altri abitanti di Miseno abbandonarono le abitazioni per cercare riparo nelle campagne circostanti. Egli scrive:
Precedentemente, per la durata di molti giorni, la terra aveva tremato senza però che ci spaventassimo troppo, perché i terremoti sono un fenomeno consueto in Campania. Ma quella notte, la terra tremò con particolare violenza e si ebbe l'impressione che ogni cosa veniva non scossa, ma rivoltata sottosopra.
[...]
Già il giorno era nato da un' ora e la luce era ancora incerta e quasi languiva. Già le case intorno erano sconquassate. L'ambiente in cui ci trovavamo, pur all'aperto, era tuttavia angusto e la paura di un crollo era forte, anzi certa.
Solo allora decidemmo di abbandonare la città di Miseno.
[...]
Una volta fuori del centro abitato, sostiamo. Molti spettacoli prodigiosi vediamo, molte angosce patiamo. I carri che ci facemmo portare con noi, anche se erano su un terreno assolutamente piano, sobbalzavano ora in una, ora in un'altra direzione e, pur puntellati con sassi, non rimanevano fermi nel medesimo punto.
Inoltre vedevamo il mare ritirarsi, quasi ricacciato dal terremoto. Senza dubbio, il litorale si era allungato e sulle aride sabbie era rimasto al secco un gran numero di pesci.
[...]
Dalla parte orientale, un nembo nero e orrendo, squarciato da guizzi sinuosi e balenanti di vapore infuocato, si apriva in lunghe figure di fiamme: queste fiamme erano simili a folgori, anzi maggiori delle folgori.
[...]
Non molto tempo dopo quel nembo discende sulle terre, copre la distesa del mare. Avvolse Capri e la nascose, sottrasse al nostro sguardo il promontorio di Miseno.
[...]
Rischiarò un poco: non riappariva la luce del giorno, ma era un indizio che il fuoco stava per avventarsi sopra di noi. Ma il fuoco, a dire il vero, si fermò abbastanza lontano. Fu tenebra di nuovo: fu cenere di nuovo, fitta e pesante. Noi ci alzavamo ripetutamente e ci scrollavamo di dosso la cenere. Altrimenti ne saremmo stati coperti e il suo peso ci avrebbe anche soffocato.
[...]
Alla fine quella tenebra diventò quasi fumo o nebbia e subito ritornò la luce del giorno, rifulse anche il sole: un sole livido come suole essere quando si eclissa. Dinanzi ai miei occhi spauriti tutto appariva mutato: c'era un manto di cenere alta come di neve.
LE ARMI DELLA FLOTTA ROMANA

Rostro di nave romana della battaglia delle Egadi 241 a.C. - Trapani Museo Pepoli
IL ROSTRO
Il rostro era una micidiale arma in dotazione alle navi da guerra romane. Era formato da un pezzo fuso in bronzo che si andava ad inserire nel punto di congiunzione tra la parte finale della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua. La parte anteriore del rostro disponeva di un possente fendente verticale rafforzato da fendenti laminari orizzontali. Esso serviva come strumento per irrompere con forza sulle fiancate delle navi nemiche allo scopo di affrettarne drasticamente l’affondamento. A volte potevano essere di due o più punte, in bronzo e simboleggiavano la testa di un animale.
LIBURNA
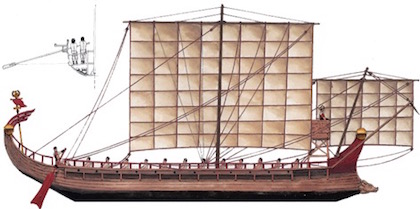
Fra i diversi tipi di naves longae, troviamo un modello che si conquistò il podio delle navi da guerra, la liburna, che era stata chiamata così dal nome degli allora molto famosi per le scorribande piratesche, i dalmati Liburni. Probabilmente era la nave migliore della flotta romana. Venne introdotta la prima volta nella battaglia di Azio, ma fu Augusto che, apprezzandone le capacità belliche, ad impiegarla stabilmente nella flotta, facendone un modello. Con una carenatura stretta, risultava molto veloce, era agile nelle manovre, ottima negli inseguimenti, adatta anche a trasportare velocemente le truppe. Ve ne erano vari modelli, dai più piccoli a due ordini di remi, ai più grandi sei ordini di remi.

ALCUNE INTERESSANTI CURIOSITA’
Queste navi erano costruite solo con legni preziosi come l’abete, il pino, sia silvestre che domestico, il cipresso e il larice e i chiodi utilizzati erano in bronzo, per prevenire la ruggine, col ferro inevitabile. Vegezio ci narra dettagliatamente, rivelandoci anche dei particolari inconsueti, come dovevano venir costruite le navi liburne: il legno doveva essere tagliato solo tra la quindicesima e la ventiduesima luna, perché in questo periodo si conserva meglio, evitando la corrosione in acqua, che avverrebbe certamente se il legno venisse segato negli altri giorni. Ma non basta: il legno andava tagliato solamente a luglio e agosto e tra l’equinozio d’autunno fino non oltre gli inizi di gennaio, perché in questi periodi il legno è più asciutto. Non solo: dopo aver tagliato il legno, bisognava lasciarlo riposare per un certo arco di tempo, perché arrivasse a quella giusta secchezza che consentiva le prestazioni migliori.
BIREME E TRIREME
Più antica, derivante dalle imbarcazioni ellenistiche e utilizzata anche dai Fenici, vi era la bireme. Lunga e stretta (con circa 24 metri di lunghezza e solamente 3 di larghezza), aveva due file di rematori, 60 per lato, posti tutti su un’unica lunga panca. Erano a loro volta divisi in 30 e 30, metà in alto e metà in basso. Oltre ai remi, queste navi avevano anche un albero con vela quadrata e per questo, con la loro forma aerodinamica e la leggerezza, raggiungevano una notevole velocità. Le bireme furono le navi dell’antichità, sostituite in età più moderna dalle trireme, che svolsero una funzione determinante nella flotta romana.
Anche queste navi avevano una forma aerodinamica, con la loro lunghezza di 40 metri per 6 di larghezza: quindi grandi tanto da poter contenere armi e una flotta di una centuria di fanti di marina.

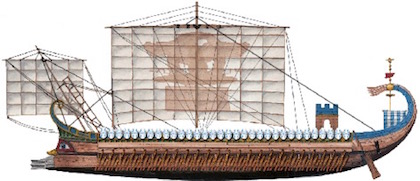
Tre erano qui i livelli dei rematori, con 30 uomini ciascuno, in tutto quindi erano 180, posizionati sotto il ponte, certamente in condizioni non ottimali. Probabilmente inventata dai Fenici e raffigurata per la prima volta su alcuni bassorilievi assiri dell’VIII secolo a.C., la bireme fu utilizzata come unità militare fino alla fine dell’età romana e nel corso della prima età bizantina.

TRIREME
Queste navi, costituivano la vera "spina dorsale" della marina romana. Potevano trasportare una centuria (80 uomini) di fanti di marina.
QUADRIREMI E QUINQUEREMI
Di dimensioni analoghe (45 metri di lunghezza e 8 di larghezza e un pescaggio, ovvero la parte immersa, di un metro circa la quadrireme e un poco di più la quinquereme) possiamo considerarle come una sorta di corazzate dell’epoca. Su queste navi vi erano sempre: due corvi, uno a poppa e uno prua, e molte armi sul ponte, destinate agli assedi, come baliste, onagri e armi da lancio. Erano costituite da una o due torri dove stazionavano gli arcieri, pronti al lancio dei dardi incendiari. 240 vogatori, 15 marinai e 75 milites classiarii erano imbarcati sulle quadrireme, mentre la quinquireme aveva 300 vogatori e 120 milites classiarii. È noto che sia nella seconda guerra punica che nella battaglia di Milazzo le quadrireme avessero due livelli di rematori, ed erano più basse delle quinquiremi, pure essendo della stessa larghezza (circa 5,6 m). Il dislocamento era intorno alle 60 tonnellate e poteva trasportare circa 75 fanti di marina. Era estremamente apprezzata per la grande velocità e manovrabilità, mentre il suo relativamente scarso pescaggio la rendeva ideale per le operazioni costiere.
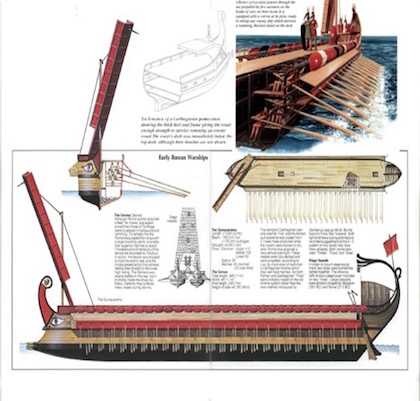
La quadrireme fu classificata come “grande nave” dai romani (maioris formae). Le quinqueremi erano molto più difficili da stabilizzare di quanto non lo fossero già le triremi, e non fornivano un aumento di velocità corrispondente, in quanto l’uso di più uomini per ciascun remo riduceva lo spazio disponibile e non permetteva a tutti i rematori di manovrare con tutta la forza; d’altro canto garantivano una protezione migliore contro gli speronamenti e permettevano di portare più fanti di marina.
ESAREME
L’Imperatore, gli ufficiali, lo Stato maggiore della marina romana, salivano solo sulle esareme, di dimensioni imponenti e che avevano una funzione principalmente dimostrativa, allo scopo di impressionare il nemico nelle battaglie, utilizzata anche per il trasporto del princeps in parata militare. Nonostante non partecipasse alle battaglie era una nave di grande impatto: grandiosa e maestosa, perfettamente equipaggiata in armi. Nella flotta vi era una sola esareme che rappresentava l’ammiraglia. Nella battaglia di Azio, esaremi erano presenti in entrambe le flotte. Era un tipo di nave pesante di cui non si conosce con certezza se fosse con sei ordini di remi per lato oppure una trireme con due rematori per remo. Plutarco, Cassio Dione e Floro ci narrano che vi furono anche navi con nove o dieci ordini di remi durante la battaglia di Azio, ma non vi sono riscontri archeologici a confermarlo.
Navi da trasporto
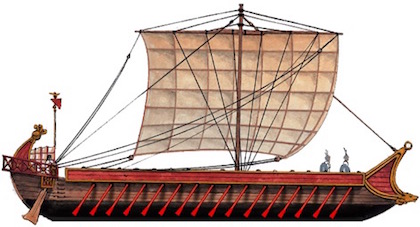
Tra le navi da trasporto vi era la navis actuaria, che trasportava le truppe di terra e la cavalleria. Particolarmente capienti ma non eccessivamente grandi (21 metri la lunghezza e 6,50 la larghezza, con una linea di galleggiamento di meno di un metro), potevano trasportare anche fino a 800 soldati. Generalmente avevano quindici remi per lato e avevano anche alberi da vela. Inoltre, una loro caratteristica era quella di avere la chiglia piatta e montare timoni posteriormente e anteriormente.
L’imperatore Giuliano, durante la campagna sasanide del 363, pare ne utilizzò un migliaio, costruite in loco sull’Eufrate, al fine di trasportare approvvigionamenti, legname e anche macchine d’assedio. Infine, troviamo le navi onerariae o corbitae, anch’esse impiegate nel trasporto merci e approvvigionamento
LE ARMI NAVALI
IL CORVO
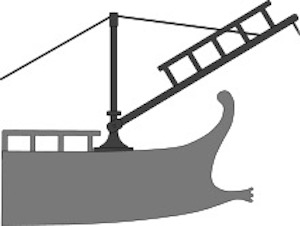
Il corvo era un congegno di abbordaggio navale utilizzato dai Romani nelle battaglie navali della Prima Guerra Punica contro Cartagine.
Nel libro III delle Storie, Polibio descrive il corvo come una passerella mobile larga 1,2 m e lunga 10,9 m, con un piccolo parapetto su entrambi i lati. Il ponte era dotato di uncini alle estremità che agganciavano la nave nemica, consentendo alla fanteria di combattere quasi come sulla terraferma.
La nuova arma fu ideata per compensare la mancanza di esperienza in battaglie fra navi e consentì una tecnica di combattimento che permetteva di sfruttare la conoscenza delle tattiche di combattimento terrestri in cui Roma era maestra. L'efficienza di quest'arma fu provata per la prima volta nella Battaglia di Milazzo, la prima vittoria navale romana; e continuò ad essere provata negli anni successivi, specialmente nella dura Battaglia di Capo Ecnomo.
In seguito, con la crescita dell'esperienza romana nella guerra navale, il corvo fu abbandonato a causa del suo impatto sulla navigabilità dei vascelli da guerra.
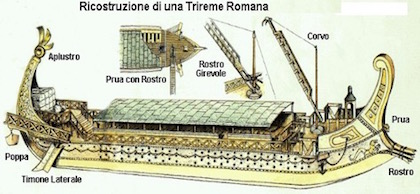
IL ROSTRUM
Sperone di ferro a tre punte localizzato a prua, che serviva a speronare le navi nemiche e facilitarne l'abbordaggio,(ogni nave, inoltre, era munita di un antirostro una sorta di speroni che evitavano l’eccessivo inserimento nel corpo della nave nemica speronata, e che permetteva di sganciare facilmente il rostro dopo l’attacco).
I corvi erano una sorta di ponte elevatoio girevole situato a prua terminante in un uncino che venivano abbassati grazie ad un sistema di carrucole sulla nave nemica per permettere l'aggancio il passaggio dei soldati romani che si riversavano così sulla nave nemica.
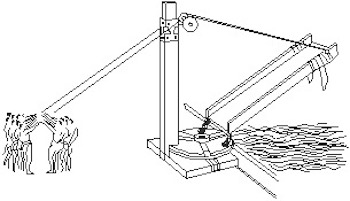
Quando il Corvo cominciò ad essere ingombrante e pericoloso per la stabilità della nave venne sostituito dall'harpax: quest'ultimo era semplicemente un dardo con un uncino che scagliato da una balista o da uno scorpione si conficcava nella nave avversaria per poi essere tirato portando le due navi a contatto, delle torrette presenti a poppa su cui si posizionavano gli arcieri (che scagliavano frecce di fuoco) in modo che potessero tirare da una posizione rialzata e quindi più vantaggiosa.
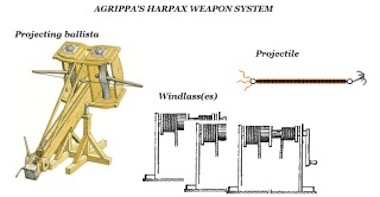
ONAGRO
Era una sorte di catapulta che sparavano vasi pieni di carboni ardenti e di pece. Mentre le balistae sparavano frecce di 1m di lunghezza a oltre 200m di distanza.
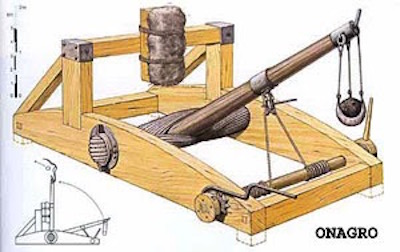
BALISTA
Era la macchina da guerra più complessa dell'antichità e vennero ideate e costruite per la prima volta dai Greci. Esse potevano scagliare dardi di 3 cubiti (132 cm) che potevano viaggiare per 650 metri prima di toccare il suolo.
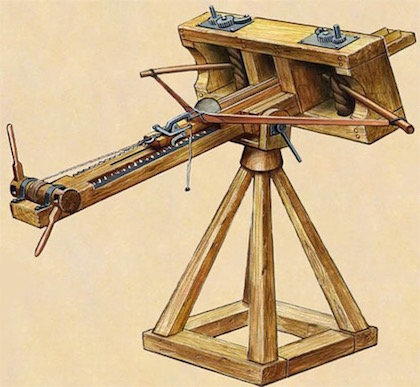
Scorpione
SCORPIONE
I Romani, per essere precisi, non usavano sempre le balistae, ma una loro semplificazione più piccola e compatta: lo scorpione che poteva scagliare dardi standardizzati fino a 3 spanne (69 cm), che potevano essere scagliati con precisione ad una distanza di 100 metri, mentre la gittata utile era di 400 metri. Normalmente vi erano più scorpioni o balistae su una singola nave a seconda della sua mole.

Stanga
La Stanga era una trave sottile e lunga, con entrambe le estremità di ferro, appesa all'albero della nave come un'antenna. Le navi, quando si scontravano, lanciavano con violenza le loro stanghe a destra o a sinistra, quasi fossero degli arieti, uccidendo i marinai nemici e sfondando la nave stessa.
La Falce era un ferro ricurvo ed appuntito, come una vera e propria falce, che era montato su lunghe aste, atto a recidere l'attrezzatura velica avversaria, rendendo le navi più lente.
La Bipenne è invece una scure, con alle due estremità una punta in ferro molto larga ed appuntita, che i classiarii utilizzano durante la battaglia per tagliare di nascosto le funi alle quali erano legati i timoni delle navi nemiche. Ciò rendeva la nave nemica ingovernabile e quindi facilmente catturabile e disarmabile.
SEZIONE MACCHINE DA GUERRA


Balista
BALISTA
Macchina bellica impiegata, soprattutto negli assedi, per lanciare giavellotti, pietre, frecce o dardi infuocati, palle di piombo, mediante lo scatto di un arco di grandi dimensioni. L’ arco della balista romana era costituito da due aste di legno, imperniate in un telaio posto su un cavalletto. Queste due aste erano tenute in pressione da due fasci di fibre intrecciate, che fungevano da mezzo di propulsione, essendo tese al massimo, come molle. Una robusta corda, agganciata alle due aste, veniva tesa e fissata all’ estremità di un carrello mobile, trattenuta da un grilletto o pernio. Il giavellotto, o altro, era collocato in una scanalatura del carrello, cosi che, sganciando di colpo dal pernio la corda tesa dalle due aste dell’arco, veniva spinto violentemente in avanti e scagliato ad una distanza di qualche centinaio di metri (un giavellotto o dardo fino a m. 350; una pietra di 800 grammi fino a m. 180).
La struttura della balista era mobile, entro certi limiti, sia nel piano orizzontale che in quello verticale, in modo tale che il lancio del proiettile poteva essere orientato secondo le necessità.
Posta su un apposito carro, trainato da cavalli, la balista era impiegata anche in battaglie campali e, in tal caso, era denominata CARROBALISTA.
Questa macchina non è una invenzione romana, dato che era già conosciuta dagli Assiri, dai Greci e dagli Egiziani.

Onagro
ONAGRO
Macchina bellica da assedio, impiegata per lanciare grossi sassi o proiettili di piombo a distanza. Era simile alla catapulta, ma differiva da questa per avere una traiettoria di lancio molto più curva, tale che l’oggetto scagliato poteva superare ostacoli alti e colpire i nemici riparati dietro recinti o all’ interno delle mura della città assediata. Era inoltre impiegata per l’indebolimento delle fortificazioni o contro le truppe d’ attacco e l’artiglieria nemica. La macchina era così chiamata per la violenta scossa che aveva nello sparo, paragonata al calcio di un onagro, asino selvatico allora presente in Grecia.
Nell’ onagro il palo che imprimeva la forza propulsiva al proiettile terminava in un secchiello appeso a funi e nel cui cavo veniva collocato l’oggetto da scagliare. Il palo, in posizione orizzontale prima del lancio, liberato dal gancio che lo tratteneva e tirato da un fascio di fibre in tensione, scattava in verticale e andava con un colpo secco ad urtare contro una barra. Nel contraccolpo lasciava partire dal suo alloggiamento il proiettile che, salendo ad una altezza di circa 40 metri cadeva a parabola ad una distanza di circa 30 metri. L’ oggetto piombando con tutto il suo peso nel bel mezzo di un gruppo di nemici, provocava conseguenze devastanti, sia in senso fisico, sia come effetto psicologico, poiché nessuno si sentiva più sicuro all’ interno di una cinta muraria.
Il peso del proiettile, secondo Vitruvio, poteva arrivare fino a 60-80 Kg. Secondo Vegezio ogni legione recava con sé 10 onagri trainati da cavalli o buoi. Ma le macchine più grandi spesso venivano costruite sul posto oppure portate in pezzi e montate poi sul campo di battaglia.

Catapulta
CATAPULTA
Macchina d’ assedio, usata per scagliare grossi sassi (anche di un quintale), proiettili o sostanze infiammabili, con molta violenza. Era costituita da un braccio di legno che terminava con un secchio contenente il proiettile. L’ altra estremità era inserita in corde torte che fornivano al braccio la forza propulsiva. Le catapulte venivano solitamente assemblate o del tutto costruite sul luogo dell’ assedio, impiegando il legno ivi disponibile.
NAVE LUSORIA
Una navis lusoria (che in latino significa danza/nave giocosa, era una piccola nave militare del tardo Impero Romano fungeva da trasporto truppe che avevano il compito di pattugliare il LIMES (il confine) dalle orde barbariche che si nascondevano nelle foreste e assalivano all’improvviso le legioni romane. Era alimentato da una trentina di soldati di guerra e da una vela ausiliaria. Agile, maneggevole e veloce, dimostrò la sua fama nel pattugliamento dei fiumi settentrionali Reno e Danubio vicino al Limes Germanicus, il confine germanico. Lo storico romano Ammiano Marcellino menzionò la navis lusoria nei suoi scritti, ma non si poteva averne un’idea precisa fino alla scoperta di queste barche a Mainz (Magonza) in Germania nel 1981-82.

Ricostruzione della Navis lusoria (della Classis Germanica) nel Museo delle navi romane di Magonza (Mainz).
La nave romana di Mainz (Magonza)
Nel novembre del 1981, durante gli scavi nel corso di una costruzione di un hotel Hilton a Magonza, furono trovati e identificati resti di legno come parti di una vecchia nave. Prima che la costruzione riprendesse tre mesi dopo, il sito produsse resti di cinque navi datate al IV secolo usando la dendrocronologia. I relitti furono misurati, smontati e, nel 1992, portati al Museo dell’antica marineria (in tedesco: Museum für Antike Schifffahrt ) del Museo Centrale Romano-Germanico ( Römisch-Germanisches Zentralmuseum ) per ulteriore conservazione e studio.
Scientificamente i relitti venivano chiamati Mainz 1 attraverso Mainz 5 e generalmente chiamati Mainzer Römerschiffe, le navi Mainz Roman. Furono identificati come vascelli militari che appartenevano alla flottiglia romana in Germania, la Classis Germanica. Le navi possono essere classificate in due tipi, ovvero piccoli trasporti di truppe (Mainz 1, 2, 4, 5) denominati navis lusoria e una nave pattuglia (Mainz 3). La lusoria è più stretta della actuaria navis, un tipo precedente e più ampio di nave da carico romana.
Una nave ricostruita a grandezza naturale è esposta al Museum of Ancient Seafaring, a Mainz, e serve come rappresentante della lusoria. Per la ricostruzione di questa nave in particolare Mainz 1 e 5 sono serviti come modelli. La replica misura 21,0 per 2,8 m mentre il parapetto misura 0,96 m Di nuovo si usa la quercia. Le doghe hanno uno spessore di 2 cm, generalmente 25 cm (10 in) e sono costruite in carreggiate.
La chiglia ha uno spessore di soli 5 cm e è costituita da tavole; contiene un canale centrale per la raccolta dell'acqua. Il mast-frame contiene un foro per posizionare l'albero. Mentre la nave poteva essere navigata, il metodo principale di propulsione era il canottaggio di una fila aperta di rematori su ciascun lato. L'effetto protettivo dei cannoni è ulteriormente esteso dagli scudi dei soldati appesi all'esterno. Le barche erano guidate da un doppio timone a poppa. Una navis lusoria era armata dal timoniere, due uomini per maneggiare la vela e circa 30 soldati che manovravano i remi.
È stato calcolato che la lusoria stretta e relativamente lunga poteva raggiungere una velocità di marcia da 11 a 13 km / h (da 6 a 7 nodi) e una velocità massima di 18 km / h (10 nodi).
Bibliografia
- I Porti Romani sul Mare - Imperium Romanun
- Miseno Bacoli – Classis misenensis – ARCHEO rivista archeologica
- I Porti Romani dei Campi Flegrei – ARCHEO FLEGREI
- L'arte della guerra romana Flavio Renato Vegezio
- Testimonianza storiche dell’eruzione di Pompei del 79 d.C.- Plinio il Vecchio
Osservatorio Vesuviano-L’Italo Americano
- L’Evoluzione navale – Imperium Romanun
- Armi d’assedio- Storia Romana – Approfondimenti-Circolo dei Saggi
- La Marina Militare Romana tra il I e il III Sec. D.C. di Roberto Petriaggi
- Le navi lusorie di Alberto Angela
- Le Liburne – Varie font
Carlo GATTI
Rapallo, 17 Maggio 2018
UNA GIORNATA DA COMANDANTE di Rossella Balaskas
UNA GIORNATA DA COMANDANTE
di
Rossella Balaskas

Immaginiamo una giornata di navigazione tipica, con tempo buono: sveglia tra le 7 e le 7:30, un’occhiata fuori, un’altra al GPS e al ripetitore ECDIS sopra la scrivania; bevo il caffè davanti al computer, mentre invio i messaggi di ETA (estimated time of arrival) al prossimo porto e agli eventuali porti successivi.
Poi salgo sul ponte.
Dalle 8 alle 12 è di guardia il 3°Ufficiale, solitamente una persona di giovane età e con poca esperienza di mare, quindi da seguire attentamente: rispondo alle sue domande, lo incoraggio, gli lascio qualche lavoro da fare nel pomeriggio…
Alle 9 aprono gli uffici a terra e, puntualmente, arrivano copiose le e-mail: documenti da preparare per i prossimi porti; ispezioni da organizzare; chiarimenti su materiale da ordinare; controlli da fare sulla base di osservazioni fatte ad altre navi, per essere sicuri di non avere gli stessi problemi…
Personalmente preferisco rispondere subito, in modo che il lavoro non si accumuli; così, con l’aiuto del 1°Ufficiale, controlliamo ciò che ci viene richiesto, approfittando dell’occasione per fare un giro in coperta e controllare i lavori di manutenzione.
Il Direttore di Macchina ci aiuta per la parte tecnica. La vecchia rivalità tra macchina e coperta viene superata quando le persone si conoscono e si stimano!

A mezzogiorno si pranza ed è subito il momento di mandare il Noon Report: un messaggio alla compagnia in cui sono indicate condimeteo, miglia percorse, consumi ecc.
Nel pomeriggio ci prepariamo all’arrivo.
Poiché si tratta di una nave che fa principalmente cabotaggio, tutti noi conosciamo i porti, ma un piccolo ripasso non fa mai male: dò un’occhiata alla carta accertandomi che il 2°Ufficiale abbia riportato correttamente le chiamate da effettuare a Piloti, Capitanerie ed eventuali VTS e lascio detto quando chiamarmi per la manovra (ma tanto li frego, salgo sempre prima di essere chiamata!).
La speranza che l’ormeggio non sia disponibile e che si sia “costretti” ad andare alla fonda per un giorno o due c’è sempre. Purtroppo, spesso è una speranza vana! Così anche oggi, dopo aver consultato i Piloti un’ora prima dell’arrivo, abbiamo ricevuto conferma che andremo all’ormeggio.
Telefono al Direttore, anche lui già al suo posto in Centrale Controllo Propulsione, per informarlo.
Prima dell’arrivo faremo alcune prove e controlli, di cui il più importante è il test del timone e, inoltre, qualche miglio prima di arrivare alla Stazione Piloti, ci fermeremo brevemente per testare la macchina indietro.
Il bello della nave piccola è che si ferma tranquillamente in un paio di miglia! Anche se per sicurezza e quieto vivere, quando non ci sono particolari esigenze, me la prendo più comoda.
Più tardi, richiamo quindi il Direttore per dargli l’orario ufficiale del PIM – pronti in macchina (SBE -standby engine in inglese ndr), chiedergli di mettere in moto i generatori e informarlo che inizierò a ridurre la velocità.
Una piccola curiosità, gli orari sono sempre divisibili per 6, retaggio di quando non esistevano i computer e i conti si facevano a mano, per semplificare!
A questo punto mandiamo via e-mail la Lettera di Prontezza, comunicazione ufficiale che la nave è pronta a caricare o scaricare (in alcuni porti italiani, la prontezza si notifica anche via VHF al terminale o all’Avvisatore Marittimo).
Dopo avere diminuito la velocità e provato la macchina indietro, approcciamo la Stazione Piloti dove imbarca il Pilota.
Un altro vantaggio di stare su una nave che fa sempre gli stessi porti è che conosciamo bene i Piloti, e loro conoscono bene la nave, quindi lo scambio di informazioni è abbastanza conciso: Pescaggi, una ripassata alle caratteristiche di manovra, qualche convenevole; poi si entra nel vivo! La manovra, se il tempo è buono, dura da mezz’ora a un’ora; di norma sono presenti (obbligatoriamente, per via del carico pericoloso che trasportiamo) uno o anche due rimorchiatori.
Una volta ormeggiati, sale a bordo l’Agente Raccomandatario per ritirare i necessari documenti; in alcuni Paesi è accompagnato dalle Autorità locali (in tal caso i documenti si moltiplicano!).
Una volta sbrigate le formalità di arrivo e mandata l’ennesima e-mail, con gli orari fino all’ormeggio, scendo a fare un po’ di pubbliche relazioni con il Loading Master (rappresentante del terminale) e Cargo Surveyor (ispettore del carico); della parte tecnica si occupa il 1°Ufficiale, ma qualche firma da mettere c’è sempre e, quindi, non manco di farmi vedere.
È tardi e la cena è saltata, ma due chiacchiere in buona compagnia possono risollevare il morale! Infatti anche Loading Master e Cargo Surveyor sono, in larga parte, volti noti e amichevoli.
Ormai manca solo di vedere l’inizio delle operazioni commerciali per mandare l’ultima e-mail della giornata poi, con la nave al sicuro in banchina, potrò andare a dormire il sonno dei giusti!
In tutto questo, il mio gatto mi guarda sonnacchioso dal divano, come a dire “perché mai affannarsi?”

P.s.: Ovvio che le giornate non sono tutte identiche ne sempre idilliache: maltempo, malumore e maleducazione a volte la fanno da padroni e allora bisogna consolare, incoraggiare, a volte rimproverare… in questo aiutano molto ironia e soprattutto autoironia.
Spesso una battuta ben azzeccata scioglie le tensioni e vale più di mille discorsi!
ROSSELLA BALASKAS
Rapallo, 22 Maggio 2018
QUALCHE PAROLA SUI RIMORCHIATORI-PORTO DI GENOVA
Qualche parola sui rimorchiatori
John Gatti

l rapporto tra il Pilota e il Comandante dei rimorchiatori va costruito e curato nei dettagli.
Il filo che li lega deve essere il risultato di una profonda conoscenza reciproca basata sul senso marinaresco, sulla fiducia, sulla complicità, sull’abilità, sul rispetto e sulla stima.
E’ importante conoscere le differenze tra i vari rimorchiatori per apprezzarne i pregi e capirne i difetti, come lo è capire quando e come conviene usarne uno piuttosto che un altro o sapere cosa si può pretendere da loro e a cosa si deve rinunciare per non correre inutili rischi.
Tuttavia non è sufficiente.
Per entrare in sintonia con il Comandante del rimorchiatore è fondamentale vivere alcune esperienze dal Ponte di Comando di quei mezzi: solo così è possibile dare il giusto peso alle difficoltà che si hanno a voltare i cavi(assicurare i cavi alle bitte) dovendo rimanere quasi a contatto con la prora della nave in movimento, o per realizzare cosa significhi l’impatto della corrente di scarico di un’elica potente che parte all’improvviso; per non commettere imprudenze, inoltre, occorre sapere come cambia la prospettiva per chi si trova in posizione pericolosa tra la nave e un ostacolo, mentre il rapporto spazio/tempo diminuisce velocemente.

E’ di grande aiuto riuscire a “riconoscere” i Comandanti dalla voce al VHF (ricetrasmettitore, fisso o portatile, per le comunicazioni marine) perché con alcuni si lavora meglio che con altri e, in certe situazioni, la sintonia potrebbe essere il valore aggiunto determinante sull’ultima carta da giocare. Anche per questo è importante essere psicologicamente pronti a raccogliere i consigli giusti: l’umiltà di accettarli può aiutare a non commettere errori e un rapporto costruito su solidi basi fa in modo che, comunque, non vengano compromessi l’autorità e il controllo della manovra.
In tutto questo è ovviamente necessario considerare la figura e le competenze del Comandante della nave: un uomo di mare che potrebbe anche non parlare la nostra lingua, ma che capisce esattamente le difficoltà di una manovra impegnativa. Per questo e per molti altri motivi lo si deve informare sulla manovra che si intende fare e sui rimorchiatori che verranno impiegati.

Tramite il Tavolo Tecnico, condotto dall’apposita sezione della Capitaneria, i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici, riunendosi giornalmente, hanno l’opportunità di discutere di procedure, limare incomprensioni, smussare problemi, valutare rischi e trovare soluzioni a manovre complicate, ma anche comprendere e ribadire il fatto che ogni operazione coinvolge altri soggetti e che non si può non tenerne conto.

Detto questo, e solo a scopo discorsivo, elenco alcuni punti delicati da tenere sempre a mente quando si utilizzano dei rimorchiatori in manovra:
- – Se i rimorchiatori vengono voltati (assicurati con il cavo alla bitta) fuori dalle acque ridossate (riparate) dalla diga del porto, non bisogna dimenticare che le onde li fanno rollare (movimento oscillatorio di un nave provocato dai marosi che la colpiscono trasversalmente) e che ci sono dei marinai a lavorare sul Ponte di Coperta bagnato e spazzato dal mare. E’ imperativo regolare la velocità e la rotta per rendere l’operazione più agevole e sicura.
- – La fase in cui si voltano i rimorchiatori è molto delicata: per dare o ricevere il cavo si devono avvicinare fin quasi a toccare la nave e più è alta la velocità più l’operazione diventa pericolosa. Sei o sette nodi, compatibilmente con le caratteristiche dei propulsori, è di solito il giusto compromesso, soprattutto per il rimorchiatore di prora che, nell’avvicinarsi alle grosse petroliere e alle portacontenitori di ultima generazione, sparisce completamente alla vista di chi dirige le operazioni dal Ponte di Comando.
- – Se la nave in manovra utilizza due rimorchiatori è buona norma, quando possibile, voltare prima quello di poppa e poi quello di prora; per mollarli vale il contrario: prima quello di prora e poi quello di poppa. Questo perché, nella malaugurata ipotesi di un problema al rimorchiatore di prora, si ha sempre la possibilità di utilizzare quello di poppa per frenare la velocità o per aiutare l’accostata.
- – L’effetto giratorio che agisce sul rimorchiatore, dovuto alla massa d’acqua spostata dalle grandi petroliere, è da valutare con molta attenzione: mentre lo stesso è quasi assente nella manovra di navi dalla stellatura prodiera molto accentuata (affinamento delle forme della carena, riferita soprattutto alla sezione prodiera e poppiera; in pratica: più queste forme sono tonde, meno sono stellate, portacontainer, navi passeggeri, ecc.). Pertanto, in queste condizioni e anche se non si sviluppano grandi velocità, bisogna considerare che durante le operazioni di passaggio del cavo parte del moto avanti del rimorchiatore è annullato per mantenere la direzione; effetto che sparisce allontanandosi di una decina di metri circa.
- – Avvisare sempre i rimorchiatori di qualsiasi variazione di rotta e velocità, informarli non appena sono stati voltati, se si intende modificare la manovra concordata e prima di usare la macchina o di dare fondo alle ancore.
- – Precisare al Comandante della nave dove si intendono voltare i rimorchiatori spiegandogli l’importanza di usare un heaving line (lanciasagole appesantito ad una estremità con lo scopo di facilitarne il lancio) con un peso adeguato: troppo spesso il vento porta via la messaggera (cima maneggevole di piccola sezione, usata per virare a bordo il cavo del rimorchiatore), con conseguente perdita di tempo… e più è lungo l’intervallo in cui il rimorchiatore rimane sotto la prua della nave in movimento, più alto è il rischio d’incidenti, senza considerare che nel frattempo la nave avanza con scarsa capacità di governo.
- – Prima di liberare il rimorchiatore di poppa, è necessario creare le condizioni affinché il cavo non finisca nell’elica in movimento e, anche in questa fase, gli ordini all’equipaggio devono essere chiari e tempestivi.
- – Accertarsi che il personale al posto di manovra sia a distanza di sicurezza dal cavo in lavoro del rimorchiatore.
- – Avere sempre un margine di sicurezza. Quando si parla di manovra, il senso di questo concetto è spesso legato al bollard pull (misura convenzionale riferita alla potenza di tiro) necessario a contrastare le condizioni del vento, della corrente e del moto ondoso: non bisogna dimenticare che la potenza sviluppata dai rimorchiatori dipende dalla lunghezza del cavo e dalla direzione del tiro, oppure, usandolo alla spinta, dalla direzione che avrà quest’ultima.

Ogni elemento che contribuisce alla buona riuscita della manovra ha un peso specifico relativo molto grande: le condizioni meteo-marine, la nave e la sua efficienza, il Comandante e il suo equipaggio, il Pilota, gli ormeggiatori e, ovviamente, i Rimorchiatori e chi vi è imbarcato. Armonia nel lavoro di gruppo e fiducia reciproca:
– La chiamata del rimorchiatore viene fatta dopo che il Pilota è imbarcato ed è successiva al confronto con il Comandante. Al momento della richiesta, quindi, la nave probabilmente si trova già a meno di un miglio dall’imboccatura. Dato il poco preavviso, per il rimorchiatore arrivare puntuale non è sempre né facile né possibile, ma l’impostazione della manovra dipende spesso dal momento in cui si è certi di avere il rimorchiatore voltato (legato).
- La manovra viene vista e vissuta in modo differente a seconda della posizione da cui la si guarda: gli ormeggiatori dalla barca o da terra, gli ufficiali da prora o da poppa, i Comandanti dei rimorchiatori dai punti in cui operano. Da ognuno di questi posti si vede solo una porzione di manovra. Gli unici ad avere il privilegio di una visione d’insieme (pur considerando diversi angoli ciechi), che sanno esattamente cosa stanno facendo la macchina e il timone e che hanno un programma ben preciso della manovra, sono il Comandante e il Pilota. Per questo motivo è importante che venga dato il “ricevuto” a qualsiasi comunicazione radio d’interesse: spesso è impossibile vedere direttamente cosa sta facendo il destinatario del messaggio e il dubbio che sia stato ricevuto e capito resta attivo fino a quando non viene confermato.
- Essere precisi nelle comunicazioni. “Tra qualche minuto sono sotto bordo…”, “Lo sto già facendo…” (come risposta a un comando), “Sto tirando/spingendo a tutta…”, ecc. A queste risposte segue un’azione. Va da sé che a risposta imprecisa seguirà un’azione errata.
- La potenza dei rimorchiatori spesso permette di risolvere situazioni complicate ma, proprio perché può incidere così tanto sullo scenario generale, il Comandante deve stare sempre concentrato sulla manovra e prevedere le conseguenze delle sue azioni; mi viene in mente la possibilità di rompere il cavo; quella di far perdere il controllo della nave tirando o spingendo troppo; oppure quella di creare difficoltà alla barca degli ormeggiatori con le scie dei suoi propulsori; o, ancora, sottovalutando l’effetto del rimorchiatore sulla manovra non mettendo il cavo perfettamente in bando quando richiesto oppure appoggiandosi allo scafo della nave.

Per affrontare almeno parte del mondo del “rimorchio” in modo approfondito, occorrerebbe molto spazio e sarebbe necessario entrare nei tecnicismi della professione che lo circonda. Non si può non tenere conto, ad esempio, dei diversi tipi di rimorchiatori (ASD, ATD, RSD, ecc.) perché ognuno di questi ha pregi e difetti, punti deboli e punti forti da poter sfruttare; occorrerebbe parlare dei pericoli insiti nel rapporto rimorchio/nave; dei sistemi di valutazione per determinare il numero di rimorchiatori da utilizzare; della lunghezza del cavo di rimorchio, quando è meglio utilizzarlo alla spinta piuttosto che voltato; quando usare il cavo nave e quando quello del rimorchiatore; ecc…, ma andare così in profondità non è l’intento di questo articolo.

Voglio però entrare in punta di piedi nella pratica raccontando un episodio di tanti anni fa che ha contribuito efficacemente ad accrescere la mia esperienza e che fa capire l’essenzialità del lavoro di squadra.
L’importanza dell’esperienza.
Ero passato Pilota effettivo da poco e le cose stavano andando bene: mi sentivo sereno e sicuro di me. Probabilmente troppo.
Al termine di una giornata tranquilla, proprio nell’ora del cambio turno tra Piloti diurni e notturni, il caso volle che fossi io il primo di “spia” (registro che riporta i nomi dei piloti in servizio e le manovre eseguite) all’arrivo di una nave di discrete dimensioni e con un pescaggio importante. Doveva andare “prua a terra”, il che significa “senza evoluzione”. In pratica si sarebbe dovuto procedere lungo il canale per poi accostare a dritta una volta raggiunta la banchina di destinazione: niente di particolarmente difficile… per chi ha l’esperienza necessaria a valutare e svolgere bene ogni passaggio.
Erano tutti contrari a mandarmi a bordo, soprattutto il Capo Pilota di allora. Ricordo infatti di aver insistito parecchio per conquistarmi la sua fiducia. Alla fine cedette, alla condizione che avrei usato due rimorchiatori; se il Comandante avesse voluto procedere con uno soltanto, allora sarei dovuto sbarcare per far salire al mio posto un Pilota più esperto.
Arrivato in plancia mi trovai di fronte un uomo di nazionalità tedesca, gentile, ma piuttosto “quadrato” e non fu facile convincerlo a prendere il secondo rimorchiatore, anche perché la nave era fornita di un bow thruster (elica di manovra prodiera, azionabile dal Ponte di Comando, che genera una forza laterale utile in manovra) discretamente potente.
Assenza di vento, niente corrente, due rimorchiatori, elica di prua, Comandante tranquillo: nulla che facesse prevedere che quella sarebbe stata una delle manovre che mi sarei ricordato meglio negli anni a venire.
In realtà l’errore che feci non fu di proporzioni enormi, semplicemente ritenni non fosse il caso di applicare una semplice regola che i Piloti più esperti mi avevano ripetuto più volte: “quando vai prua a terra con una nave di pescaggio, prima fermala e poi inizia l’accostata!”
Ricordo che durante i tre quarti d’ora necessari a raggiungere la banchina pensai più volte a come la nave rispondeva bene al timone e di come il Molto Adagio Avanti producesse una velocità perfettamente adeguata alla stazza della nave.
Fermai la macchina per tempo lasciando che l’abbrivo (impulso con cui inizia o aumenta gradualmente la velocità della nave; indica anche la quantità di moto che conserva quando cessa l’azione dei mezzi propulsivi) diminuisse piano piano, con l’intenzione di fare una manovra prudente. In effetti arrivammo tra le testate delle due banchine con una velocità di poco superiore al nodo: praticamente quasi fermi. Era quel “quasi” che non andava bene…
A quel punto avrei dovuto dare macchina indietro o, quanto meno, mettere il rimorchiatore di poppa in bozza a fermare…
La verità è che mi sembrava di andare talmente piano e che il timone rispondesse in modo così preciso che, invece di fermare la nave, feci mettere il timone a dritta per infilarmi sfruttando la poca velocità residua.
All’inizio andò bene, ma poi, all’improvviso, la nave smise di venire a dritta: sentiva maledettamente il fondale e la prua si fermò puntando direttamente il prolungamento della banchina di fronte.
Non eravamo vicinissimi e per questo motivo non mi preoccupai più di tanto. Feci mettere la macchina Indietro Adagio e il rimorchiatore di prora a piegare piano.
Risultato: la nave non rallentò neanche un po’ e la direzione restava la stessa, solo che nel frattempo lo spazio a disposizione diminuiva.
Cominciai a preoccuparmi. Indietro Tutta, rimorchiatore di poppa in bozza a fermare e quello di prora a piegare a tutta forza!
Risultato: la nave continuava ad andare avanti e la rotazione riprese in modo quasi impercettibile.
Nel giro di qualche minuto la situazione precipitò: il Comandante saltava da un’aletta all’altra come un grillo imprecando senza sapere cosa fare, mentre io cominciavo a sudare freddo realizzando di essermi giocato tutte le carte che avevo a disposizione.
Fu a quel punto che il rimorchiatore di prora, continuando a vogare a tutta forza, si girò quasi a spring (cavo d’ormeggio che da prua guarda verso poppa o da poppa verso prora ostacolando o impedendo alla nave di avanzare o retrocedere) e quello di poppa si sguardò quel tanto che bastava per rendere il massimo nella frenata aiutando anche l’accostata.
Sfiorammo il cemento… ma passammo indenni!
I due Comandanti dei rimorchiatori sono ormai in pensione da diversi anni, ma quando mi capita di incontrarli li ringrazio ancora per l’abilità e l’occhio dimostrati quel giorno.
Sono tante le storie che potrei raccontare dove il binomio Comandante del rimorchiatore e il suo Direttore hanno dimostrato una preparazione e una padronanza che è possibile acquisire solo dopo un percorso lavorativo molto specifico. Sono professioni che lasciano ancora spazio all’abilità personale, dove si creano equilibri che rendono difficile sostituire un uomo con un altro.

JOHN GATTI
Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018
FONS GEMINA - SAN MARTINO DI NOCETO - RAPALLO
FONS GEMINA – RAPALLO

L’ACQUA DI FONTE CI RICORDA LE APPARIZIONI DI MARIA VERGINE…
In molti poeti e scrittori di tutti i tempi aleggia, al di là di ogni dubbio, la suggestione e la malinconia di una devozione filiale per la Madonna, vista come lo Spirito dell’acqua simbolo di vita, Stella del mare, Regina del Cielo corredentrice del Verbo che dà la vita.
Quando appare, la Madonna non di rado lascia dietro di sé una fonte miracolosa. La più celebre è quella di Lourdes, naturalmente, ma ce ne sono di più antiche, come quella di Caravaggio, e di più moderne, come quella di Montichiari, Santuario di Maccio (Como), Madonna dello Splendore (Giulianova), Amore Misericordioso (Collevalenza), Marvicio nel cuore dell’Aspromonte, ma l’elenco sembra infinito perché esce dai confini nazionali per andare in Francia, Polonia, Russia ed oltremare.
LA FINE DELLA SETE NON È BERE A SAZIETÀ,
MA DIVENTARE FONTANA PER DISSETARE ALTRI,
FACENDOSI SORGENTE PER L'ALTRUI ARSURA.
LORENZO PIVA
"NON BISOGNA CHE CESSI LA PIOGGIA PER METTERCI IN CAMMINO. E' BELLO ANCHE BAGNARSI DI ERRORI E RIMPIANTI PUR DI ARRIVARE IN CIMA ALLA MONTAGNA DELLA VERITÀ"
(FONTE NON SPECIFICATA)
Il racconto sulla FONS GEMINA può soltanto iniziare il suo breve viaggio con il ricordo che tutti i rapallesi hanno nel cuore:
Nostra Signora di Montallegro
Dedichiamo la sintesi ai nostri numerosi followers stranieri.
Secondo la tradizione locale la Vergine apparve nel primo pomeriggio di venerdì 2 luglio 1557 al contadino Giovanni Chichizola, originario di San Giacomo di Canevale, frazione del comune fontanino di Coreglia Ligure, di ritorno dal mercato ortofrutticolo di Genova. Giunto nell'entroterra rapallese, nelle proprietà boschive della famiglia di fazione ghibellina Della Torre, all'altezza del monte Letho (conosciuto dai locali come "monte di morte" o "della morte" a causa delle numerose scorribande dei briganti), l'uomo - affaticato dal lungo viaggio a piedi e stremato dal caldo - si addormentò nei pressi di uno sperone di roccia.
All'improvviso, fu destato da un bagliore: al contadino apparve una "dama vestita d'azzurro e bianco e dall'aspetto grazioso e gentile", come testualmente riportò in seguito ai primi popolani e alle autorità civili e religiose accorsi sul monte. La donna pronunziò solo poche parole, che per la comunità cristiana rapallese risuonano ancora vive:
“Va’ e dì ai Rapallesi che io voglio essere onorata qui”

Il Santuario di N.S. di Montallegro

DORMITIO MARIA (Il TRANSITO di MARIA SANTISSIMA)
Per dar prova della "miracolosa apparizione", la Madonna lasciò in dono al contadino un quadretto di “arte bizantina” raffigurante la Dormitio Maria (il Transito di Maria Santissima), da donare alla comunità rapallese. Dopo l'improvvisa scomparsa della "Bella Signora", sulla stessa roccia in cui era avvenuta l'apparizione cominciò inoltre a sgorgare acqua fresca e pura.
FONS GEMINA
Un po’di storia…
Il Prof. Massimo Bacigalupo ce la racconta così:
“L’ultimo capitolo della prima edizione di Rapallo nei secoli (di Pietro Berri-1964, a cura del Comune di Rapallo) è il più ridente e ci porta a San Martino di Noceto alla scoperta della Fons Gémina, monumentino di cui nessuno sembra aveva trattato prima di Berri, il quale ce ne fornisce la storia e ne trascrive e traduce le dotte epigrafi. In realtà questo capitolo è il racconto di una gita lungo la rotabile che sale a Ruta passando per S. Maria, ed è animato da un entusiasmo che ci dice molto sulla personalità di Berri, uomo non facile alle esternazioni sentimentali, ma ben sicuro nei suoi gusti e nelle sue convinzioni, come fermo e autorevole nello stile. Eccolo invece per un attimo confessare fra le righe il suo amore per questa vallata e per la fonte sulla quale ha lasciato traccia un vecchio arciprete latinista, per il quale evidentemente egli prova la simpatia del compagno di studi a distanza di decenni. Inoltre Berri accetta l’ipotesi del Ferretto che nei pressi della fonte, nella Villa Granello, si trovasse un’antica pieve ospite della quale sarebbe morto il Vescovo Onorio fuggiasco da Milano, il giorno 23 febbraio del 570. 1400 e passa anni fa, altro che Rapallo nei secoli! San Martino è intitolata al guerriero e poi vescovo di Tours che proprio in Liguria nel IV secolo avrebbe diviso il mantello con un mendicante.

Camogli: Il mosaico simbolo della STELLA MARIS che guida e protegge i naviganti

Scopriamo che la frazione è sempre stata legata a Camogli per lo smercio dei prodotti agricoli e per la vocazione marinaresca degli abitanti, e che “i Camogliesi avevano ricambiato questa reciprocità di interessi e questa fraternità nell’aspro lavoro sulle tolde sbattute dalle onde, e, ai margini dell’antica via pedonale, occhieggiano tuttora tra il folto della vegetazione, le villette che i vecchi lupi di mare avevano fatto costruire sulle ombreggiate pendici”.
ALBUM FOTOGRAFICO



I due ruscelli gemelli a destra e sinistra s’incontrano formando un piccolo laghetto… la FONS GEMINA



Venendo da Rapallo in direzione Ruta di Camogli, la Cappelletta é situata a circa 300 metri dalla Chiesa di San Martino di Noceto.

Fonte Canala (Fons Gemina)
Nel territorio rapallese, oltre alla chiesa parrocchiale di San Martino di Noceto, è presente un'antica fonte denominata fons gémina realizzata nel 1810 così come testimonia una lapide marmorea in latino; nella nicchia sopra l'arco a sesto acuto è conservata una statuetta della Madonna Coronata di argentei gigli.
Fons Gemina significa, in latino, “fonte gemella” ed è una fonte che trae il nome dalla particolarità che da essa sgorgano due fonti distinte. Essa è, molto probabilmente, di origine romana e risale invece solo al 1810 la struttura a sesto acuto in cui è posta una statuetta marmorea della Madonna.
La fonte è sita a San Martino di Noceto, una frazione di Rapallo che in passato era ricca di noccioli e castagni, da cui dovrebbe derivare il nome “Noceto”.
UN APPUNTAMENTO:
Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino
Rapallo: “Fons Gemina”, Concerto alla Fonte a San Martino
Da Filippo Torre di “Fons Gemina” riceviamo e pubblichiamo:
A coronamento del suo sesto anno di attività, il Circolo Culturale “Fons Gemina” presenta un evento lungamente atteso e mai realizzato prima: il concerto presso il monumento di cui l’associazione porta il nome.
Nel 2012 i soci fondatori del circolo scelsero infatti la “Fonte Gemella” (“Fons Gemina”, in latino) di San Martino di Noceto per simboleggiare la propria aspirazione a rappresentare un sicuro punto di riferimento nell’ambito del tessuto culturale di Rapallo; nel corso degli anni l’associazione ha voluto quindi rappresentare per la città una vera e propria “sorgente di idee”, così come espresso dal proprio motto.
La Fons Gemina, uno dei monumenti meno noti di Rapallo, è nel contempo uno dei più antichi; esso si trova tra la chiesa millenaria di Ruta e quella di S. Martino di Noceto e il suo aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione realizzata nel XVII secolo. La sua origine è tuttavia riconducibile al X secolo, periodo nel quale la fonte viene citata come “speciale” in quanto caratterizzata da due sorgenti perenni gemelle.
Ci è parso quindi che il Concerto alla Fonte fosse il modo migliore per suggellare un anno particolarmente ricco di eventi, incentrato come consuetudine sulla multidisciplinarietà delle proposte.
L’appuntamento, che si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rapallo, è fissato alle 17.00 di sabato 19 maggio. Ne sarà protagonista il quartetto d’archi composto da Alessandro Alexovits (violino I), Massimo Vivaldi (violino II), Simona Merlano (viola) e Paola Siragna (violoncello). Il repertorio, incentrato su composizioni di diverse epoche e stili, non mancherà di proporre alcuni dei brani più celebri della storia della Musica.
In caso di pioggia, il concerto si svolgerà presso l’attigua Chiesa Parrocchiale di S. Martino di Noceto.
Vi aspettiamo come sempre numerosi.

Chi scrive, dedicò nel 18.5.2011 un saggio sul sito di
MARE NOSTRUM RAPALLO:
Rapallo: SANTUARIO DI N.S.MONTALLEGRO: Navi, Marinai e la Devozione Mariana
CARLO GATTI
Rapallo, 16 Maggio 2018
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
LA FARINATA GENOVESE VENNE DAL MARE…
TRA MITO e LEGGENDA
Dice che era un bell'uomo e veniva,
veniva dal mare... parlava un'altra lingua...
però sapeva amare … (Lucio Dalla)


LA MELORIA
Anche la farinata venne dal mare… un viaggio breve e fu portata da uomini “cazzuti” che sapevano amare anche la buona cucina!

Una leggenda racconta che sia nata per pura casualità nel 1284, mentre infuriava la battaglia della Meloria che vide vittoriosa Genova su Pisa. Si racconta che le navi da guerra genovesi si trovarono coinvolte in una tempesta, ma é più probabile che la nave della farinata genovese sia stata colpita da un colpo di bombarda a pelo d’acqua… in direzione della cambusa. In ogni caso, si verificò una via d’acqua (termine marinaro che sta per falla) e alcuni barili d’olio e sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata.
Ciutòsto che röba avanse, creppa pansa.
(Piuttosto che far avanzare del cibo, mangiamo tutto anche se poi stiamo male).
Non c’era alternativa: morire di fame oppure abbuffarsi su quelle provvidenziali scodelle di purea di ceci, olio e acqua di mare. A questo punto il destino volle che alcuni marinai, miga tanto abbelinae, optassero per una terza soluzione e lasciassero questo composto al sole che asciugandosi si sarebbe trasformata in una strana specie di frittella. Alla fame non si comanda e i marinai si convertirono a quella sconosciuta pietanza scoprendo una nuova ricetta che, per puro caso, diventò famosa a partire dal quel lontano 1284 fino ai giorni nostri.

Venditrice di farinata genovese (inizi ‘800)
Rientrati vittoriosi nei caroggi Genovesi senza sole…, i marinai provarono a cuocere quell’impasto nel forno a legna. Il risultato fu eccellente e venne chiamato “l’oro di Pisa” per deridere i nemici sconfitti…
Secondo un altro “ciaeto storico” (pettegolezzo):
la farinata affonda le sue radici addirittura nell’antica Roma quando le truppe romane occuparono Genova e dintorni.
A quel tempo la farina di grano era considerata un lusso e i soldati preparavano questa pizza rudimentale con un impasto di farina di ceci e acqua, che poi cuocevano al sole, utilizzando i propri scudi come “forni”.
Prendiamo quindi atto che la farinata di ceci (fainà in dialetto) ha navigato, a fasi alterne, per oltre duemila anni da un porto all’altro, anzi da un angiporto all’altro essendo un piatto “povero” ma estremamente gustoso e nutriente che i marinai in franchigia gustavano passando tra i piaceri di un lupanare e l’altro.
Liguria, Toscana e Piemonte sembrano essere le culle della farinata classica per altro conosciuta anche in altre regioni italiane, magari con delle varianti locali vendute come apprezzati street food.
C’è però chi sostiene che i natali di questa specialità non si debbano alla Superba, ma alla Toscana, precisamente a Pisa. La sconfitta dei pisani é dura ancora oggi da digerire… naturalmente noi ci scherziamo! Ma loro no!
Che la farinata non si faccia solo in Liguria è vero, poiché la si prepara anche sulla costa francese, più o meno nei dintorni di Nizza, dove viene chiamata socca. Ma non c’é da meravigliarsi, Nizza é stata genovese fino al 1860. Si può trovare anche nel basso Piemonte, dove é conosciuta come bela cada. Vi propongo una originale testimonianza della mia amica Marilena, torinese di nascita:
"Proprio alla torta verde, sempre reperibile nei forni e in qualche macelleria, è dedicata una festa in concomitanza della fiera del Santo Cristo, che a fine aprile fa rivivere le storiche usanze di Nizza. Dove le sagre sono l’occasione giusta pure per assaggiare la belecàuda, altrimenti acquistabile in alcuni panifici: non è altro che la farinata - con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva - da cuocere in teglie di rame nel forno a legna e servire (come suggerisce il nome) “bella calda”. Esattamente come la serviva Tantì, che nel secolo scorso portava con una bicicletta a tre ruote la teglia con la farinata calda, un “tantì” indicava una porzione ed è diventato il soprannome del venditore ambulante."
Sulla costa della Toscana del nord viene chiamata cecina o torta di ceci.
Nel savonese la si fa anche con farina di grano tenero e viene chiamata farinata bianca.
Fatevi questa domanda: se la farinata si prepara in una regione e in tutte le zone ad essa confinanti, dove potrà essere nata? In attesa della vostra riflessione e di fonti storiche inoppugnabili, una cosa mi pare certa: ovunque sia nata, la farinata in Liguria è tradizione, territorio, cultura e appartenenza. Questo prodotto da forno viene eseguito in maniera eccelsa in tutta la Liguria, ma Genova è la sua città d’elezione.
Consegnata la farinata alla Storia di ieri … entriamo ora nella FARINATA di oggi e vediamo di capire qualcosa della sua “cosiddetta” semplicità la quale, come abbiamo visto, é intrisa di olio d’oliva e acqua salata, ma anche di tanti segreti mai confessati agli estranei della casta dei “sacerdoti” locali, i soli che possano tramandare la tradizione con riti di iniziazione di natura similmente religiosa …
Chissà se funziona ancora così? Ma di sicuro un tempo non lontano era proprio così!

CECI
Amedeo, quando andava per pagelli al largo di Rapallo, portava con sé un residuato bellico: la tanka di una Jeep Willys che riempiva di acqua di mare trasparente; la usava per l’impasto della farinata ma anche per fare il sale domestico, raro da reperire durante la guerra e nel primo dopoguerra.
Amedeo non era un “sacerdote”, ma le fisse per la farinata le aveva eccome … Si sentiva, per esempio, in competizione con il mitico fornâ (fornaio) Ö BANSIN della perla del Tigullio, verso il quale nutriva un complesso di superiorità …
Ogni tanto si partiva per il basso Piemonte, prima tappa Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si compravano i ceci a seme grosso: il cece di Merella, il migliore del mondo?!? Se li faceva macinare… e si proseguiva per Gavi Ligure; la seconda tappa era dovuta alla scorta di vino bianco che, a suo dire, era l’unico vino in grado di convolare a nozze con a fainà. Secondo la filosofia del suo tempo, questi ingredienti facevano la differenza tra le due benemerite categorie in gara: il professionisti sapienti e i dilettante trìsti e belinoin.
Era dura stargli dietro… ma la farinata che usciva da quel forno a legna, disastrato dalla guerra, mi ritorna regolarmente in sogno ancora oggi!

RICAPITOLIAMO
La ricetta della farinata di ceci (tradizione ligure) possiamo riassumerla così:
E’ una torta salata, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extra vergine d’oliva. La farinata (fainà) é una prelibatezza che viene cotta nel forno a legna, in teglia (testo di stagno ramato), da cui il caratteristico colore dorato che assume con la cottura.
Pochi ingredienti con tanti segreti??? Avviamo l’indagine!
300 gr di farina di ceci
1 litro d'acqua
5 cucchiai di olio extravergine di oliva
Sale quanto basta
LE VARIE FASI
Dosi
Semplicissime: il rapporto tra farina e acqua deve sempre essere di 1 a 3. Vale a dire che per ogni etto di farina di ceci servono tre etti di acqua. Non dimentichiamo il sale, nella misura di circa un grammo ogni etto di composto: se la somma tra acqua e farina è 400 grammi, saranno necessari circa 4 grammi di sale, o poco meno.
Teglia
Nelle farinaterie si usa una teglia apposita, il cosiddetto “testo”, una grande padella rotonda a bordi bassi in rame stagnato, disponibile anche in versione casalinga con un diametro di 30-32 cm.
Se non avete il testo, potrete rimediare con una teglia da forno a bordi bassi, preferibilmente rotonda. Se invece non siete puristi fanatici della tradizione ma mirate alla sostanza, la classica teglia rettangolare andrà comunque bene.
Impasto
Una volta muniti di teglia e ingredienti, è il momento di passare alla preparazione. Mettete la farina di ceci in un’ampia ciotola e cominciate ad aggiungere l’acqua a poco a poco, sempre girando con una frusta per non formare grumi.
Siete tipi da poche storie? Allora prendete un frullatore a immersione e frullate per qualche secondo: avrete un impasto liscio e vellutato in pochi secondi. Aggiungente quindi il sale.
Per un testo di circa 32 cm di diametro, corrispondente a una teglia rettangolare di cm 40 x 20, le dosi indicative sono di circa 130 grammi di farina, 390 di acqua e 5 grammi di sale.
Riposo
Una volta fatto il laborioso impasto, bisogna farlo riposare, almeno 4 ore, meglio se tutta la notte.
Durante il riposo, si formerà una sorta di schiuma in superficie: levatela con un cucchiaio, altrimenti brucerà durante la cottura.
Ci siamo quasi
Impasto pronto, riposo effettuato, forno caldo, anzi caldissimo. Non rimane che infornare. Non prima, però, di aver unto la teglia con un generoso strato di olio, dello spessore di circa due millimetri.
Girate bene l’impasto della farinata e rovesciatelo sulla teglia, allo spessore di circa un centimetro o poco più. Girate il tutto leggermente con un cucchiaio di modo da mescolare l’olio della teglia con l’impasto appena rovesciato. Se vi piace, aggiungete qualche ago di rosmarino.
Cottura
Non resta che aspettare: 10-13 minuti in genere sono sufficienti, ma ovviamente il tempo dipende dalla temperatura raggiunta dal vostro forno. Tenete presente che la farinata è pronta quando assume la classica colorazione dorata in superficie. E soprattutto, che non deve essere eccessivamente cotta, ma presentare l’interno ancora morbido e cremoso, e non asciutto e stopposo.
Sfornate e spolverizzate infine con pepe fresco, macinato al momento.
Il Vino
Con la farinata – a base di farina di ceci, olio, sale e pepe, cotta nel forno a legna ben si abbina il Coronata Val Polcevera, vino bianco sapido e fresco.
I consigli del nonno:
Ungi bene la teglia, cala la broda, metti l'olio, batti il fondo e inforna caldo-caldo.
Quando sopra si forma una crosta semidura (croccante) é pronta! Senza muovere la teglia, deve essere ben in piano quando cuoce, altrimenti resteranno zone crude e zone troppo cotte.
Preferiscila appena sfornata, praticamente ustionante e con una spolverata di pepe.
ALCUNI APPROFONDIMENTI NELLA PREPARAZIONE DELLA FARINATA.
LA PAROLA AGLI ESPERTI DI OGGI
"Io faccio la farinata da 17 anni e impasto tutti giorni 25 chili di ceci!"
I requisiti sono: morbida dentro e crespolosa in superfice.
La temperatura del forno deve essere da 300 a 350 gradi.
Il forno dove lavoro e profondo 240 cm. le teglie (testi) sono di 80 cm di diametro. Quindi ne posso infornare anche tre a temperature più alte.
Lo spessore della farinata deve essere 1 cm, poi dipende dai gusti se piace secca o morbida
ALCUNI TRUCCHI

Nelle nostre farinaterie, a seconda dell’area geografica, i legni più adoperati sono il faggio e la quercia. Talvolta il càrpino, ma questo è un prodotto che potremmo definire di scappatoia.

Faggio segato con corteccia
Diversi tipi di legno da usare nel forno a legna

Faggio
· FAGGIO: +fiamma / -brace. Ottimo rapporto qualità prezzo

Quercia
· QUERCIA: +brace / - fiamma. Fa una bella fiamma all’inizio poi lentamente si abbassa e trasforma in brace. La brace mantiene il calore a lungo.
· ULIVO: +brace +fiamma. Introvabile molto raro e caro.
· CARPINO Alternativa a basso costo al legno di quercia.
LEGNA DA NON USARE: Pioppo e Castagno perché scoppiettano, pezzetti di braci ardenti potrebbero finire sulla farinata durante la cottura, questa è legna da camino.
ABETE, PINO E RESINOSE contengono resine tossiche, inoltre trasferiscono odori estranei ai prodotti in cottura.
- È meglio adoperare legno italiano e se possibile con origine certificata, meglio ancora se fornita in un sistema di autocontrollo.
- Se serve fiamma molto vivace la legna di faggio va preferita a quella di quercia.
- Viceversa se occorre una brace più longeva e una fiamma meno incisiva l’ideale è la quercia;
- Prediligere legni stagionati almeno 8 mesi.
Il potere calorico del faggio a zero umidità è pari a 4.456 kcal/kg ma:
- 15% di umidità 3700 kcal/kg;
- 30% di umidità 2940 kcal/kg;
- 50% di umidità 1930 kcal/kg;
Carlo GATTI
Rapallo, Mercoledì 9 Maggio 2018
O LEUDO - Fiorenzo Toso
O LEUDO
di
(Fiorenzo Toso)
Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì son stæto mainâ. Comme tutti i òmmi do mæ paise, mi ascì ò visto de tære lontañe, de dònne mäveggiose, e delongo m'assunnavo quelle træ fasce d'oivi derê a-a casa, che a mæ moggê scua e stondäia a mandava avanti quande mi navegavo.
Mæ poæ o m'à mostrou comme se deve scigoâ pe ciammâ o vento quande gh'é bonassa, e comme s'à da pregâ pe tegnî lontan e dragoñe, e coe de vento.
Oua che son chì, vegio, desnavegou, e che a mæ dònna a l'é mòrta, e e fasce di oivi son in zerbo, oua che i mæ figgi no navegan, ma tëgnan i stabilimenti da bagni pe-a demoa di foresti, oua che i mæ nëi parlan unna lengua che no capiscio, a coæ do mâ ghe l'ò delongo into sangue, a me s'inscia drento tutte e vòtte che vaggo à giandonâ in sciâ mæña, co-i atri dötræ da mæ etæ che se rebellan ancon pe-i caroggi do paise.
A-i nòstri tempi s'andava à veia. I capitagni braggivan i comandi in bon zeneise, giastemmando San Pê, e i peneixi portavan l'anelletta à l'oegia. S'arrivava à un pòrto e subito s'andava à beive pe scordâ e træ fasce e a moggê stondäia, ma intanto l'indoman l'ea pægio, e no gh'ea ninte da fâ. Unna vòtta, à Scingapore, mi e un de Carlofòrte emmo provou à fummâ l'eubbio, no ve diggo, paiva d'ëse in sce unna nuvia. N'an attrovou a-a mattin int'un caroggetto, sensa unna palanca, mezi nui e con un mâ de testa da scciuppâ. O capitagno, un de Camoggi, o ne l'aiva dito de no stâse à fiâ di cineixi, che son de gente gramme. Na che no son de gente gramme, no son miga pezo di atri. O l'é de naätri mæximi che no se doveivimo fiâ.
Pan cöse lontañe, e intanto pâ vëi... A-o Cao d'Orno, unna vòtta, mi e un compagno emmo visto unna dònna pescio. Segùo, a pâ unna föa, ma intanto mi l'ò vista, a l'ea nùa, de d'ato a l'ea pægia à unna dònna e de sotta a l'aiva a coa verde, co-e scagge e tutto.
Dixan che i mainæ, de stâ delongo pe mâ, no capiscian ciù ninte, veddan de cöse che no ghe son, se imaginan de istöie. O giorno dòppo, a borrasca a n'à streppou a veia grande, e quello mæ compagno lì o l'é cheito in mâ. Mi diggo ch'a l'é stæta a dònna pescio ch'a l'à vosciuo con lê. Ò insomma, l'é megio credde coscì, che pensâ ch'o segge mòrto apreuvo à un corpo de vento. Unna föa. E a saià ben unna föa, ma quante vòtte, inte quelli giorni, no me ghe saieiva bollou mi ascì in mâ, sensa quella föa?
À Bonnesaire andavimo delongo à mangiâ da un do paise ch'o l'aiva unn'ostaia donde favan o pesto, o menestron e a fainâ co-a säçissa. Mangiavimo, beveivimo, e in sciâ fin se metteivimo à cantâ e pagavimo coscì, à son de tralalleri, e i zeneixi de lazzù vegnivan à sentîne fin d'in fondo a-a Pampa.
Regòrdi. Ma no se peu vive solo de regòrdi. Oua mi, o Ciomê e o Dria emmo attrovou un leudo abbandonou into cantê do sciô Tasciæa, quello ch'an da cacciâ zu pe fâghe un atro stabilimento da bagni.
O l'é un bello leudo, ma dev'ëse ciù de vint'anni ch'o l'é lì, da quande o cantê o l'à fæto baracca: beseugnieiva cangiâghe o fasciamme, l'erboo meistro o l'é inte tanti tòcchi e o cöpresso se l'an portòu via. Emmo attrovou fiña e veie, ma son meze mangiæ da-i ratti. Seguo, à repessâle comme se deve, dovieivan ancon tegnî o vento.
Gh'emmo pensou, mi co-i atri doî. À dâghe recatto, o se porrieiva mette in mâ de lengê. O l'à unna bella armatua, nervosa, o l'à di scianchi comme unna figgia à sezz'anni. O n'asbrivieiva fin à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resäto. Ma niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Vernassa, dove o Dria o gh'à di pænti, a-a Bordighea, donde gh'é un mæ amigo, quello ch'o parlava co-i draffin e ch'o sunnava a tromba de succa. S'o l'é ancon vivo.
D'arescoso da-i figgi, tutti e trei emmo levou i dinæ d'in banca. Pöca cösa. Quello ch'aivimo guägno o l'é partio tutto, tòsto tutto, pe tiâ sciù a famiggia, pe dâghe da mangiâ, pe fâli studdiâ. E niatri lonten, à Caracas, à Hong Kong, à San Francisco, tanto che no an fæto in tempo à conoscine, i nòstri figgi.
O sciô Tasciæa o leudo o ne l'à regallou. O l'é mezo feua de testa, meschinetto, ma o l'à capio pægio: lê ascì o l'à navegou, o l'é stæto capitagno. Pöi o l'à averto o cantê e o s'é misso à fâ e barcasse pe-o pòrto de Zena, into momento che e barcasse no servivan ciù à ninte. Sò moggê co-o figgeu a se n'é anæta con un milaneise, un ch'o l'à un abergo à Sanremmo, e lê o l'é arrestou mezo alloou, o no s'é mai ciù repiggiou: oua o l'à tòsto novant'anni. Sò figgio o l'é cresciuo, o l'é vegnuo a-o paise l'anno passou e o gh'à fæto firmâ di papê. Coscì caccian zu quello che resta do cantê e ghe mettan di atri bagni, Bagni Paradiso, Bagni Sole e Mare, chi ô sa.
Co-i dinæ ch'emmo levou d'in banca cattiemo e cöse che serve pe dâ recatto a-o leudo. Beseugna trovâ i erboi – emmo zà parlòu co-o bancâ do caroggio drito, ch'o l'é stæto meistro d'ascia –, sarsî e veie, cartezzâ, vernixâ, desentegâ i ratti.
No finiemo sens'atro avanti d'ëse mòrti, mi, o Ciomê e o Dria. E se mai fescimo in tempo, no aviëscimo sens'atro ciù a fòrsa nì o bon d'avaâ o barco, de fâlo navegâ, de stâ apreuvo a-a rotta.
Ma de regòrdi solo no se peu vive. De föe, de seunni manco. E sto leudo o no l'é un seunno, o l'é bon legno saxonou, che à dâghe recatto o n'asbrivieiva à l'Erba, in Còrsega, in Sardegna int'un resato. E niatri se contentiëscimo de costezzâ fin à Zena, à Nöi, dove o Ciomê o l'à di amixi, a-o Tellâ, dove gh'é quello mæ coxin, quello ch'o l'addomestega i öchin e ch'o tia de cotello comme un singao. S'o l'é ancon vivo.
Alessandra Cutrì intervista Fiorenzo Toso

Docente di Linguistica generale presso l’Università di Sassari, Fiorenzo Toso è linguista e dialettologo specialista dell’area ligure, redattore principale del Vocabolario delle Parlate Liguri (1985-1992, 4 voll.) e autore della Letteratura genovese e ligure (1989-1991, 6 voll.), del volume Gli ispanismi nei dialetti liguri (1993), della Storia linguistica della Liguria (1995), della Grammatica del genoveseDizionario etimologico storico tabarchino (2004) e della Grammatica del tabarchinoXeneises. La presenza linguistica ligure in America Meridionale (2006), de La letteratura ligure in genovese e nei dialetti locali. Profilo storico e antologia (2009, 7 voll.), del Piccolo dizionario etimologico ligure (2015), per citare solo alcuni lavori maggiori. Fra le altre cose, si occupa anche di plurilinguismo (Lingue d’Europa. La pluralità linguistica dei Paesi europei fra passato e presente, 2006), di fenomeni di insularità e di contatto linguistico (Linguistica di aree laterali ed estreme. Contatto, interferenza, colonie linguistiche e «isole» culturali nel Mediterraneo occidentale, 2008), di minoranze linguistiche (Le minoranze linguistiche in Italia, 2008; La Sardegna che non parla sardo. Profilo storico e linguistico delle varietà alloglotte. Gallurese, Sassarese, Maddalenino, Algherese, Tabarchino, 2012) e di etimologia (Parole e viaggio. Itinerari nel lessico italiano tra etimologia e storia, 2015). (1997), del (2005), del volume
A oltre 150 anni dalla nascita dello Stato italiano i dialetti stanno perdendo terreno a causa di cambiamenti politici ed economico-sociali che hanno portato all’emergere della lingua italiana mentre, a livello globale, si assiste parimenti al “trionfo” dell’inglese. L’aumentata mobilità delle persone, la diffusione di internet e la maggiore istruzione nell’epoca della globalizzazione portano spesso i parlanti ad allontanarsi dalle lingue originarie (in particolare dai dialetti) e ad “appiattire” le loro potenzialità comunicative nell’uso di un unico idioma dotato di maggior prestigio; si tratta, forse, di una tendenza ciclica e storicamente inevitabile. Mettere in atto misure di tutela dei dialetti è possibile e necessario? Potrebbe rivelarsi un’azione forzata, antistorica e regionalistica?
Ho iniziato a occuparmi del patrimonio linguistico ligure nel 1976, quando avevo circa 15 anni, raccogliendo le parole del genovese parlato al mio paese d’origine per quello che sarebbe diventato il Vocabolario delle parlate liguri, di cui divenni in seguito redattore. Ricordo il titolo di un articolo di Manlio Cortelazzo su una rivista locale, a sostegno dell’iniziativa: “Un’impresa urgente: salvare i dialetti”. Infatti, a quell’epoca, i linguisti e i sociologi – nel quadro di una certa temperie culturale – preconizzavano la scomparsa nel giro di pochi anni delle parlate locali. Siamo al 2017, e per quanto mi riguarda ho ancora molte occasioni di trascorrere ore discorrendo in genovese con persone di ogni età, genere, formazione e livello culturale. Attenzione, questo non significa che non ci sia una crisi – di uso, di funzionalità, di “immagine” se vogliamo – delle parlate locali, ma mi sento anche di dire che fare della sprachprognostik sui processi di obsolescenza linguistica non è facile, e che occorre essere molto prudenti nella valutazione dei fattori che possono contribuire a generarla. L’informatica, ad esempio: avrà pure contribuito a espandere lo spazio dei codici standardizzati di più larga diffusione – dalle lingue nazionali all’onnipresente inglese – ma è anche un veicolo potente e democratico di diffusione per qualsiasi altra lingua o dialetto. Oggi, attraverso i social, i siti dedicati ecc., un testo, un video, una trasmissione in una lingua di minor diffusione possono arrivare a un pubblico ampio, e con costi limitati. Più in generale: in giro, e per tanti motivi che sarebbe ozioso ripetere, c’è evidentemente una “domanda” di territorialità linguistica, che si manifesta in varie forme, dall’enfatizzazione della componente diatopica nell’uso dell’italiano a fini connotanti (è tutto un fiorire di comici con inflessioni locali, di insegne, denominazioni di prodotti, magliette che riportano parole “tipiche”, ecc.) fino a diverse forme e proposte di “recupero” di tradizioni linguistiche più genuine. Riguardo a quest’ultimo aspetto, i problemi che si pongono sono decisamente complessi. Anzitutto, rifacendomi alla domanda, in linea di principio eviterei di associare sempre e comunque un’eventuale prospettiva antistorica (e le relative forzature) alle manifestazioni in sé di una impostazione “regionalistica”. Comunque la si pensi, il regionalismo non è necessariamente antistorico, è un rispettabile atteggiamento politico e amministrativo, e il dibattito relativo riguarda in generale, attraverso letture complesse e dalle più svariate prospettive ideologiche, le diverse società occidentali. Ciò vale anche sotto l’aspetto dei patrimoni linguistici: persino un paese di grandi tradizioni centralistiche come la Francia parla oggi di “langues de France” come concetto esteso alle varianti dialettali (picard, champenois, gallo…), promuovendone anche lo studio accademico per singole realtà (cosa che in Italia ad esempio non viene fatta, raccogliendo questo tipo di interessi sotto la generica formula della “Dialettologia italiana”); e che nella corretta gestione del patrimonio storico-culturale dei territori siano anche implicati, quando ci sono, gli elementi di originalità linguistica, non mi pare di per sé un fatto scandaloso o eversivo. Di recente ho curato a Genova una mostra storico-documentaria sul genovese, che ha riscosso un notevole interesse di pubblico e di critica e ha contribuito, credo, ad avviare la riflessione anche su alcuni dei temi che stiamo discutendo. Bene, l’unica contestazione, del tutto fuori luogo e come tale generalmente percepita, è stata quella di uno storico della lingua e accademico della Crusca che ha trovato da ridire sul sottotitolo della manifestazione (Il genovese. Storia di una lingua), considerandolo lesivo del prestigio dell’italiano e… potenziale veicolo di promozione di un bilinguismo inglese-dialetto ai danni della lingua nazionale! Rendiamoci conto che se il livello di riflessione su questi temi rimane ancorato a queste forme di strumentalizzazione e di provincialismo reazionario, sarà sempre problematico impostare una riflessione seria sul tema della pluralità linguistica di un paese in cui, oltre tutto, le forme del multilinguismo vanno continuamente riformulandosi. Ammettiamo piuttosto che in Italia l’interesse per questi temi è stato cavalcato più facilmente da una certa area politica: ma aggiungiamo anche che un certo atteggiamento intellettuale, che riflette anche la difficoltà della cultura nazionale a convivere col “problema” del proprio policentrismo, ha fatto di tutto per consegnare, legato mani e piedi, il tema della regionalità (non solo linguistica) a quel contesto politico. Quanto al fatto se sia necessario o meno, e in che misura possibile, “tutelare i dialetti”, anche qui la risposta è per forza di cose articolata. Necessario: se si ammette che le forme della diversità linguistica sono un bene culturale e un elemento di ricchezza (non soltanto in termini espressivi o connotanti: penso anche ai vantaggi cognitivi del bi- e plurilinguismo ad esempio), la risposta dovrebbe essere implicita. Trovo però tremendamente ipocrita che nel momento in cui si formulano opinioni del tipo “il dialetto è una ricchezza, una risorsa” e così via, non si ammetta l’opportunità, almeno in astratto, di promuoverne la conservazione come si fa per qualsiasi altra risorsa, naturale, monumentale, culturale e così via. Possibile: la pianificazione linguistica ha cessato da tempo di essere un’opinione, è a tutti gli effetti una rispettabile branca della linguistica: di impossibile, in sé, non c’è nulla. Il punto è semmai un altro, nel momento in cui si manifesti una volontà condivisa e diffusa di approdare a questa tutela (cosa che del resto non è né scontata, né attuale): si tratterebbe di verificare i tempi, i modi e gli obiettivi, e di capire anzitutto cosa può significare la “tutela del dialetto”. L’uso parlato, che è anzitutto legato alle scelte e alla consapevolezza dei locutori? La sua rappresentazione identitaria, che di per sé è un guscio vuoto in mancanza di una pratica diffusa? La memoria storica attraverso la promozione degli studi, che è in ogni caso propedeutica allo sviluppo di qualsiasi altra iniziativa? Insomma, la risposta è aperta.
A che punto è la politica sulla tutela delle minoranze linguistiche in Italia? A quante lingue si può applicare e cosa resta ancora da fare? Su quali basi una lingua è definita “minoritaria” e quindi da tutelare? Penso, ad esempio, al caso del brigasco.
Con questa domanda ci riallacciamo ad alcuni dei temi sfiorati nella risposta precedente: il disagio tutto italiano per le problematiche del plurilinguismo e del policentrismo, che rappresentano da sempre altrettanti elementi costitutivi della realtà culturale del paese, si è manifestato in maniera particolarmente evidente proprio attraverso il fallimento della politica di tutela delle minoranze linguistiche. Prevista dalla Costituzione, raccomandata dalle istituzioni europee, essa riguardava storicamente, dal dopoguerra, le sole minoranze “nazionali”, ossia quei gruppi di popolazione che percepiscono la propria alterità linguistica in rapporto a un diverso senso di appartenenza culturale e nazionale, per di più sancito da accordi interstatali: i sudtirolesi (ed estensivamente i ladini della provincia di Bolzano), i valdostani, gli sloveni delle province di Trieste e di Gorizia. La legge 482 del 1999 è giunta con un clamoroso ritardo a “tutelare” un gruppo di altre “lingue” (ma più correttamente si sarebbe dovuto parlare di tutela dei parlanti, e dei loro diritti linguistici), scelte in base al criterio della distanza “genetica” dall’italiano, e senza tener conto delle implicazioni sociolinguistiche relative a ciascuna di esse. Da un lato quindi si è effettuata una selezione quanto meno arbitraria all’interno del panorama linguistico nazionale (friulano sì, veneto no; algherese sì, tabarchino no), dall’altra si è deciso, ad esempio, che minuscole comunità di parlanti dialetti germanici, ellenici o albanesi andassero in linea di principio “tutelate” alla stessa stregua e con le stesse modalità della compatta maggioranza etnica altoatesina, presso la quale la coufficialità con l’italiano riguarda una lingua di solidissime tradizioni culturali e amministrative. Questa idea di creare lingue a tavolino non è molto diversa dalle ipotesi – magari bollate come reazionarie ed eversive – di chi propone di standardizzare una “lingua piemontese” o una “lingua napoletana”, ma ha significato mettere a posto la coscienza delle istituzioni statali, ossificando un panorama linguistico in larga parte impreparato a tutto questo, e aprendo nei casi più controversi ulteriori elementi di disagio: l’urgenza di disporre di una lingua sarda o di una lingua occitana è diventata così l’alibi per forzare processi gestiti spesso e volentieri da minoranze attive ed élite politico-culturali, a discapito della volontà dei parlanti e di un sereno confronto sul opzioni possibili; al contempo, la gestione delle relative risorse (peraltro in progressivo calo nel corso degli anni) è diventata spesso e volentieri appannaggio di quanti, di tali processi, si sono fatti proponenti ed artefici. D’altro canto, queste forme di “ufficializzazione” non hanno dato, come del resto era logico aspettarsi, risultati concreti in termini di inversione del trend negativo che caratterizza l’uso delle lingue ammesse a tutela; per di più, isolate dal contesto plurilingue di cui sono storicamente parte, esse hanno finito per essere percepite come feticci identitari prima che come strumenti di comunicazione, restando quest’ultima prerogativa affidata all’italiano o ad altri idiomi concorrenti: nelle valli del Piemonte occidentale ad esempio, il carattere “occitano” dei dialetti locali viene molto rappresentato, a fini prevalentemente turistico-commerciali e latamente politici, ma la gente continua a usare prevalentemente l’italiano o il piemontese, e altrove non pare proprio probabile che il finanziamento di questa o quell’iniziativa didattica o amministrativa, per quanto volenterosa, farà nel tempo recuperare locutori al dialetto walser di Formazza o alla parlata albanese di Villa Badessa. Mancando, inoltre, una qualsiasi forma di vigilanza sui processi di riconoscimento e auto-riconoscimento delle comunità (meglio, delle amministrazioni) che intendevano dichiarare la presenza sul loro territorio della lingua minoritaria, si è verificata una vera e propria corsa all’auto-certificazione, dagli esiti a dir poco grotteschi. Per fruire di possibili finanziamenti, decine di comuni di solide tradizioni dialettali piemontesi, calabresi, venete e così via si sono dichiarate di volta in volta “occitane”, “grecofone”, “germanofone” o “ladinofone”, col risultato di sovvertire gravemente, anche in termini percettivi, il panorama linguistico locale: dai comuni dell’Isola d’Ischia che hanno cercato di farsi passare per centri di lingua tedesca (sembra una battuta di Totò, e invece non lo è) al caso appunto del brigasco, un dialetto inequivocabilmente e riconoscibilmente ligure, come tale noto al mondo degli studiosi (oltre che nella tradizione locale), ma scandalosamente “promosso” dal giorno alla notte al rango di varietà “occitana”. Questo caso in particolare, proprio per le reazioni che ha suscitato nel pubblico e tra gli studiosi, è forse l’esempio più tristemente noto (ma tutt’altro che isolato) dei fenomeni di malcostume amministrativo connessi con la 482. A quasi vent’anni dalla sua approvazione, quindi, questa legge per molti aspetti scandalosa andrebbe profondamente modificata – come opzione minima – o, preferibilmente, sostituita con provvedimenti nella cui formulazione siano coinvolti linguisti e giuristi competenti, che chiariscano anzitutto cosa si debba intendere per “tutela”, tenendo conto della varietà delle situazioni coinvolte (e di quelle rimaste fuori, spesso in maniera palesemente discriminatoria, dall’ammissione ai benefici di legge), del contesto interlinguistico complessivo in cui si manifesta l’alloglossia, e di altri parametri a vario titolo decisivi per una corretta applicazione di una “politica” linguistica che guardi anche alle più aggiornate esperienze internazionali in materia.
Fra le lingue minoritarie parlate sul suolo italiano vi è il tabarchino, idioma presente a Calasetta e Carloforte, in Sardegna, e nato dal genovese in epoca tardo-medievale per necessità di comunicazione legate agli scambi commerciali sulle sponde del Mediterraneo. Quale altra lingua ha contribuito alla formazione del tabarchino e quanto esso si è differenziato nel tempo rispetto al genovese moderno? Esistono isole genovesi al di fuori dell’Italia oggi?
Il caso del tabarchino è per l’appunto rappresentativo dei deficit e degli insuccessi della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Tipico e riconosciuto esempio di eteroglossia, caratterizzato da percentuali d’uso della varietà locale che sono tra le più alte in assoluto in Italia, il tabarchino è stato oscenamente “dimenticato” nell’elencazione delle varietà ammesse a tutela perché considerato la variante di un “dialetto italiano” qual è il genovese. Le perplessità dei linguisti e dei giuristi, che hanno prodotto una ormai ricca letteratura in proposito, non sono valse finora a fare approvare i diversi emendamenti con i quali si è cercato di rimediare a questa incresciosa situazione, che vede anche il paradosso di due soli comuni in tutta la Sardegna privi di una qualche forma di valorizzazione del loro patrimonio linguistico (essendo il sardo e il catalano di Alghero ammessi a tutela), per quanto il tabarchino sia poi correttamente menzionato dalla legislazione regionale. Le comunità tabarchine attuano peraltro da anni forme efficaci di auto-tutela, che ne fanno anzi un modello rappresentativo di difesa “dal basso” della specificità linguistico-culturale locale: tuttavia, la mancata copertura legislativa, oltre a impedire l’accesso ad adeguate risorse, rappresenta una palese e inaccettabile discriminazione, ai limiti dell’incostituzionalità, una volta che nel bene o nel male la categoria degli idiomi ammessi a tutela preveda, tra i criteri di “selezione”, le prerogative dell’insularità linguistica. D’altro canto il tabarchino rappresenta in termini culturali una varietà riconoscibilmente “altra” anche rispetto al genovese, essendo il portato di un processo di immigrazione in Sardegna verificatosi nel corso del sec. XVIII a partire dagli stabilimenti liguri in Tunisia, risalenti a loro volta al Cinquecento. Le vicende per certi aspetti romanzesche della diaspora dei tabarchini dalla loro sede originaria su un isolotto al largo della costa africana, fanno del loro idioma un caso pressoché unico di conservazione e attualizzazione di una parlata che, dopo aver goduto nel tempo di prerogative importanti anche in termini comunicativi internazionali (come varietà dell’uso commerciale tra europei e tunisini) continua a esercitare oggi una funzione essenziale di riconoscimento collettivo all’interno delle comunità presso le quali la è diffusa. Vero è peraltro, che, proprio per la sua antica funzione di lingua commerciale, ancora vitale in Tunisia durante tutto l’Ottocento, il tabarchino non si è differenziato molto dal genovese, continuando fino a tempi relativamente recenti ad aggiornare i propri esiti fonetici, morfologici, sintattici e lessicali alla varietà metropolitana. Quel che fa del tabarchino una lingua a sé rispetto al ligure continentale sono quindi le peculiarità ambientali e culturali, tra Africa, Spagna e Sardegna, che hanno determinato il suo indissolubile legame con una cultura “altra”, meticcia, frutto di apporti molteplici e complessi, ben riconoscibile nel contesto sardo e italiano per le proprie peculiarità, tanto che l’eredità storica tabarchina è oggi candidata ad assumere il ruolo di patrimonio immateriale dell’umanità secondo la classificazione dell’UNESCO. Diverso è il caso di altre varietà liguri “trapiantate” fuori dall’area d’origine, come il bonifacino della Corsica meridionale, che rappresenta uno stadio prossimo al genovese duecentesco, o il monegasco, che è oggi la lingua nazionale del Principato di Monaco, frutto di un’immigrazione dalla Riviera di Ponente verificatasi durante il Trecento. Sono questi gli scampoli di quella che fu una presenza linguistica distribuita lungo le coste mediterranee e del Mar Nero nel corso della secolare esperienza mercantile dei genovesi, una presenza ben attestata sia dalla documentazione scritta (trattati politici e commerciali, atti legislativi ecc.), sia dalle sopravvivenze, soprattutto lessicali, di elementi liguri in diverse lingue e dialetti di quest’area estesissima: dal neoellenico dell’isola di Chio (la Scio dei Genovesi) allo yanito di Gibilterra (una varietà andalusa di contatto con l’inglese, in cui gli affioramenti lessicali liguri sono dati dalla presenza di una forte componente ligure sul territorio della colonia britannica); dai dialetti urbani della Corsica a quel che resta del figoun trapiantato in Provenza nel corso del sec. XV. Né va dimenticata l’esistenza di una componente ligure importante nel lessico dello spagnolo popolare rioplatense, il cosiddetto lunfardo, come risultato di un’immigrazione in America Latina che ha lasciato tracce di un uso comunitario del genovese, in parte ancora vitali, soprattutto sul versante pacifico del subcontinente.
La diffusione dell’inglese a livello internazionale ha reso questo idioma lingua veicolare moderna; nel periodo dell’Alto Medioevo, però, e per tutta l’età moderna, alcuni volgari italiani (come già visto, ad esempio, il genovese) e in seguito l’italiano e lo spagnolo, furono il codice privilegiato di comunicazione nei porti del Mediterraneo, spesso in forma di lingua franca, una sorta di pidgin fatto di elementi provenienti dalle diverse parlate delle popolazioni che entravano in contatto. Quali sono le nostre conoscenze su questa lingua franca, quali le fonti e le testimonianze? Quale fu l’apporto a questa lingua franca dell’arabo e del turco?
La lingua franca mediterranea è quello che si potrebbe definire un autentico phantôme terminologique, nel senso che al concetto tutto sommato ben definito che vi si accompagna (in estrema sintesi, un idioma semplificato destinato alla comunicazione interetnica tra popolazioni che parlano lingue geneticamente distanti) non si accompagna in realtà una documentazione storica sufficiente a confermarne la tipologia e persino la stessa esistenza storica. Anche il nome di questo “oggetto” risulta sfuggente da un punto di vista semantico (lingua dei “franchi”, ossia degli occidentali, o lingua “franca” in quanto scorrevole, semplice? o tutte e due le cose?), e ricompare in situazioni e contesti storici diversi, dall’Adriatico all’Africa settentrionale in età moderna, in maniera assai più labile in Oriente durante il medioevo, poi in Grecia tra Ottocento e Novecento, lasciando intendere che sotto la denominazione di “lingua franca” si celino in realtà forme di espressione assai differenti tra loro. D’altronde, le fonti che lo descrivono come un “italiano parlato male” utilizzano una formula che, oltre ad essere generica, viene parimenti utilizzata per indicare diversi idiomi italoromanzi utilizzati come lingue commerciali e coloniali (ad esempio, per un viaggiatore francese del Cinquecento, è “un italien corrompu” il genovese di Chio), mentre gran parte delle (presunte) attestazioni dirette di questo idioma, frutto in realtà di elaborazioni letterarie (da Molière a Goldoni) ripetono costantemente una fraseologia stereotipata, fatta di verbi all’infinito, di formule di cortesia e poco più. Elementi morfosintattici attribuibili a una modalità pidginizzante mancano invece nella documentazione riconducibile a situazioni di effettivo contatto tra parlanti le diverse lingue neolatine e varietà semitiche, come le lettere di schiavi europei ai tempi della corsa barbaresca, o la documentazione relativa a Tabarca, l’unica stabile comunità “europea” sulle coste dell’Africa settentrionale. La mia impressione quindi – ma è soltanto un’impressione sia chiaro – è che il concetto di lingua franca celi una realtà tanto complessa quanto difficilmente definibile, in cui potevano integrarsi di volta in volta l’uso interetnico di vere e proprie varietà romanze (come quello del genovese in Tunisia, ben documentato tra Quattrocento e Ottocento), modalità rudimentali di apprendimento dell’italiano da parte di arabofoni o turcofoni, forme di comunicazione basate sulla commistione di codice e sull’interferenza tra diversi idiomi romanzi, e così via. Non parlerei quindi di una vera e propria “lingua” nel senso di varietà riconoscibile e riconosciuta rispetto ad altri idiomi geneticamente affini, e neppure di un pidgin stabilizzato, quanto di un insieme di modalità di comunicazione, caratteristiche soprattutto, nel periodo che va dalla seconda metà del Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento, dell’incontro e del confronto verificatosi nel panorama politico-culturale, davvero complesso, delle antiche reggenze barbaresche, col prevalere di modalità genericamente “italianizzanti” tra Algeri e Tunisi, e “ispanizzanti” verso il Marocco; del resto, l’unico repertorio ampio di “lingua franca”, un dizionarietto del 1830 a uso delle truppe francesi in Algeria, suona di estrema (e per certi aspetti tardiva) stilizzazione di un fenomeno assai più labile nelle sue manifestazioni. Quanto e cosa questo insieme di situazioni abbia lasciato in eredità alle lingue dell’Africa settentrionale e del vecchio Levante è difficile dire: certamente il lessico dell’arabo maghrebino, del turco, del greco e di altre varietà “mediterranee” è ricco di italianismi, ispanismi, venetismi, genovesismi, provenzalismi, francesismi e così via, non meno di quanto turcismi e arabismi siano presenti nelle varietà neolatine della sponda settentrionale del Mediterraneo, ma ciò non assicura necessariamente l’esistenza di un tramite rappresentato dalle modalità pidginizzanti della lingua franca. Il quadro così delineato ridimensiona un po’, in ogni caso, alcune teorie suggestive, come quella sull’origine monogenetica dei pidgin, che sarebbero nati, secondo alcuni studiosi, dal trasferimento dell’ossatura morfologica semplificata della “lingua franca mediterranea” lungo le coste della Guinea, subendovi una rilessificazione in senso portoghese. Non è chiaro tra l’altro, a mio modesto avviso (anche ad attribuire una decisiva importanza all’interazione ligure-lusitana lungo le coste dell’Africa atlantica ai tempi della tratta degli schiavi, secondo una suggestiva lettura, tra gli altri, di Germán De Granda), il contesto storico-culturale in cui si sarebbe verficato tutto ciò, mancando soprattutto una sostanza documentaria in grado di instaurare affinità specifiche tra la “lingua franca” mediterranea (oggetto sostanzialmente sconosciuto) e i pidgin africani e americani.
Quale influenza ha avuto il genovese, lingua di una delle repubbliche marinare, sull’italiano e sui dialetti: in quali parlate del suolo italiano, ad esempio, la sua presenza si avverte di più e quali sono gli ambiti semantici?
La mostra alla quale accennavo prima, tenutasi a Genova tra settembre e novembre di quest’anno, documenta anche, attraverso il suo catalogo, la ricchezza delle interrelazioni linguistiche e culturali che furono generate dall’espansione mercantile ligure nel Mediterraneo. Come ha scritto di recente Emanuele Banfi, anzi, probabilmente più ancora di quella del veneziano la storia oltremarina del genovese merita di essere conosciuta e approfondita in ragione delle modalità del suo radicamento in una pluralità di orizzonti linguistici differenti e con modalità d’impianto peculiari, legate anche alle esigenze di controllo di approdi e di basi commerciali, più che di territori estesi, da parte di una popolazione di mercanti caratterizzata da un limitato potenziale demografico. Lingua di incontro più che di dominio, il genovese si è caratterizzato così per una forte tendenza alla micro-colonialità, in quei luoghi, dalla Crimea a Gibilterra, dove i liguri rappresentarono essenzialmente una minoranza dominante o un elemento catalizzatore, per le loro stesse specializzazioni economiche, in grado di attrarre componenti etniche e demografiche di svariata provenienza: i diplomi bilingui in genovese e armeno o ebraico prodotti nell’ambiente turcofono di Caffa ne sono un esempio lampante, non meno delle attestazioni dell’uso del genovese, alla Boca di Buenos Aires, anche da parte della popolazione d’origine ispanica o degli immigrati di varia origine e provenienza, circostanza che spiega l’importante componente ligure nello spagnolo popolare rioplatense. Se si guarda più in dettaglio al contesto italiano, quantificare il lascito linguistico e in special modo lessicale genovese nella lingua nazionale e nei dialetti non è facile, considerando che le stesse affinità morfologiche e fonetiche tra gli idiomi italoromanzi rendono a volte difficile determinare l’esatta provenienza di una voce. È vero peraltro che Genova si propone anche, e precocemente, come centro di assunzione e di irradiazione di innovazioni della più svariata origine, orientale non meno che nordica e occidentale, soprattutto nel lessico delle costruzioni navali, marinaresco, commerciale, della pesca e così via. A livello dialettale, una notevole circolazione linguistica in area alto-tirrenica contribuì non poco a diffondere termini d’origine o di tramite ligure verso la Corsica (peraltro esposta a un apporto lessicale massiccio anche per la sua appartenenza politica a Genova) e la Toscana costiera e insulare (numerosi sono gli esempi lessicali che si possono trarre, fra gli altri, da un esame del dialetto di Capraia), con “discese” notevoli anche lungo le cose sarde, italiane meridionali e siciliane. Non è certo stupefacente allora che persino una parola percepita come essenzialmente “siciliana” quale mattanza, sia in realtà un antico ispanismo di tramite genovese, approdato tardivamente nel lessico delle tonnare siciliane anticamente gestite da imprenditori liguri. Dal porto di Genova passano inoltre, per diffondersi nell’italiano letterario, molti termini legati al mondo della navigazione e della marineria (da scoglio a prua, da ciurma a cavo, e alcuni ancora in tempi recenti, come il lusismo piovasco), ma anche a prodotti commerciali (penso di avere dimostrato recentemente l’origine genovese di baccalà), a innovazioni tecnologiche e così via. Spesso le datazioni di una voce, attestate in genovese o in italiano regionale ligure prima che in altre zone, contribuiscono a chiarire i processi di diffusione di questa terminologia, che fu particolarmente copiosa nel passaggio dal genovese al toscano anche per la maggiore vicinanza geografica del porto ligure rispetto a Venezia, che ha irradiato spesso il proprio lessico marinaro in area adriatica assai più che in direzione della Toscana. Uno studio sistematico dei genovesismi in italiano è del resto tra le attività connesse al mio lavoro di spoglio lessicale della documentazione ligure preottocentesca, dalla quale stanno emergendo elementi importanti di valutazione. Più difficile è parlare, al di là del lessico, di componenti liguri nel processo di formazione di varietà dialettali italiane: è ormai riconosciuto un fondamentale apporto di tale origine nel galloitalico meridionale, ossia in quell’insieme di dialetti, diffusi in Basilicata e in Sicilia, che presentano tracce inequivocabilmente “settentrionali” e che risalgono verosimilmente a fenomeni immigratori dei secc. XII-XIII, legati anche ai ripopolamenti promossi dopo la cacciata degli arabi dalla Sicilia; ancor più evidente è, come già accennavo, la componente ligure in alcuni dialetti urbani della Corsica, come quello di Ajaccio e quello di Calvi, la cui popolazione doveva parlare in passato un idioma “coloniale” (paragonabile a quello tuttora in uso a Bonifacio) sul quale si sovrapposero in seguito le varietà corse del contado. Proprio dal bonifacino dipende in gran parte il decisivo apporto ligure, anche di carattere morfologico, del dialetto “misto” corso-ligure dell’isola Maddalena, e una componente genovese variamente stratificata si riconosce anche nella parlata sassarese, come effetto di una commistione, su base corsa, di elementi fonetici, morfologici, sintattici e lessicali liguri e sardi.
Il sardo è considerato oggi, e a partire da quella che è considerata la prima classificazione scientifica dei dialetti italiani operata da Ascoli (1882), una lingua autonoma rispetto alle altre parlate italiane, caratterizzata da una notevole conservatività rispetto al latino, caratteristica mantenuta grazie al suo isolamento rispetto alla terraferma. Questa immagine corrisponde alla realtà? A chi o a cosa si deve l’idea del sardo come dialetto isolato e conservativo?
Nei dieci anni di insegnamento all’università di Sassari mi sono avvicinato con molto rispetto e con qualche titubanza al “problema” della lingua sarda, ma mi guardo bene dal definirmi uno specialista in materia. In ogni caso la specificità linguistica del sardo e il sua carattere di lingua (o se si preferisce, di insieme di varietà dialettali a se stante rispetto all’italiano) è un dato di fatto conclamato e accolto non soltanto dalla linguistica italiana, ma anche da quella internazionale. Detto questo, sarebbe opportuno rivedere alcuni luoghi comuni sul sardo, a partire soprattutto da quello della sua “staticità” e conservatività consustanziale, che in parte è anche il frutto di una interpretazione per certi aspetti “ideologica” della categoria di insularità, come conseguenza di una visione “resistenziale” della società sarda, e in fondo degli stessi entusiasmi del maestro riconosciuto della linguistica sarda, il tedesco Max Leopold Wagner. Certo, il sardo conserva caratteristiche particolarmente arcaiche rispetto ad altri idiomi romanzi, ma questo non riguarda anzitutto l’intera area linguistica sarda, divisa tra un meridione campidanese assai più dinamico e un settentrione logudorese-nuorese maggiormente conservativo; inoltre, un’evoluzione a partire da condizioni particolarmente precoci di radicamento del latino è continuata ovviamente e continua a manifestarsi, come avviene per qualsiasi lingua o dialetto, secondo modalità che risentono anche della collocazione sociolinguistica di una lingua, almeno finora, prevalentemente parlata. Più in generale, le condizioni di arcaicità non sembrano affatto dovute all’insularità del territorio, circostanza che ne fa anzi uno spazio vocazionalmente “aperto” fin dalla più remota antichità, quanto alla presenza all’interno della Sardegna di aree montane, maggiormente conservative come conservativo sotto molti punti di vista, non soltanto da quello linguistico si dimostra (secondo una ben nota considerazione di Fernand Braudel) anche il resto della montagna mediterranea. Che l’ambiente sardo dimostri una specifica propensione alla “resistenza” agli influssi esterni è del resto, come dicevo, un mito identitario e una forma di rappresentazione di se stessi assai prima che una realtà storica: basta solo guardare a quanto il lessico delle varie lingue che si sono susseguite in Sardegna con caratteri di superstrato, dal pisano al genovese, dal catalano allo spagnolo e all’italiano, abbia permeato il vocabolario isolano nei più ampi e disparati ambiti semantici. E non va infine dimenticato che la Sardegna, proprio per il suo carattere di spazio “aperto” ospita da secoli diverse varietà alloglotte orientate di volta in volta verso le rispettive “madrepatrie”, in modo tale da costituire veri e propri “ponti”, elementi di raccordo tra la sardità linguistica e un più ampio orizzonte romanzo: le parlate corse del nord dell’isola (gallurese, maddalenino e sassarese, le ultime due con interessanti interferenze liguri), il catalano di Alghero, il già citato tabarchino di provenienza ligure-tunisina. A queste diverse forme del contatto linguistico ho preferito dedicarmi, da quando lavoro in Sardegna, anche in considerazione del fatto che la lingua sarda ha i suoi validi specialisti, e tenendo conto del mio specifico interesse per le vicende “dinamiche” del contatto e dell’interferenza linguistica.
Il dialetto genovese ha subito l’influsso del toscano/dell’italiano? In caso affermativo, in quale epoca quest’influsso è stato più forte e da quale punto di vista? Il genovese è cambiato molto negli ultimi 150 anni?
Come ogni varietà neolatina sottoposta al “tetto” linguistico del toscano/italiano, il genovese e il sistema dei dialetti liguri hanno risentito e risentono dell’influenza di questa varietà enormemente prestigiosa in termini letterari, politici, sociali e di diffusione territoriale. Almeno dal Quattrocento il toscano è massicciamente presente nella scripta ligure, attraverso elementi lessicali, morfologici e sintattici che risultano anche dalla esportazione verso le Riviere di precisi modelli culturali e letterari. Nondimeno, e a differenza di altre regioni italiane, la Liguria esprime precocemente, a partire dalla fine del Duecento, una letteratura autonoma nell’idioma locale, che si sviluppa attraverso i secoli con una chiara consapevolezza della propria continuità e autonomia, sollecitando a più riprese programmi di défense et illustration del genovese, come “lingua del paese” contrapposta più o meno polemicamente all’uso dello “straniero” toscano: il jayro vorgà çenoeyse (“chiaro volgare genovese”, secondo una ricorrente formula trecentesca) si presenta costantemente come protagonista della vita culturale ligure, in aperta e spesso vincente concorrenza con l’italiano soprattutto nei termini dell’identificazione nella langue du pays dello strumento più idoneo a rappresentare i tratti costitutivi della specificità locale. Queste dinamiche sono particolarmente attive tra il Cinque e il Settecento, quando la promozione del genovese diventa un elemento strategico per la definizione ideologica di un’“alterità” promossa da una classe dirigente che si affanna a divulgare l’immagine di una Repubblica caratterizzata dall’originalità delle proprie istituzioni e dalle peculiari manifestazioni della propria “libertà”. Se consideriamo il fatto che i depositari di questa impostazione, ossia i poeti e gli altri autori che scrivono in genovese, appartengono nella stragrande maggioranza al ceto notarile, a diretto contatto con le memorie storiche e con le testimonianze linguistiche del medioevo, possiamo capire perché quella genovese, con i suoi caratteri di continuità, assomigli poco al “canone” concettuale che siamo abituati ad attribuire, in Italia, alla categoria di letteratura dialettale. D’altro canto, gli usi “alti” del genovese nelle discussioni politiche, in senato, nei tribunali, dureranno fino alla caduta della Repubblica (1797-1805) condizionando, assieme alla percezione dell’internazionalità dell’esperienza linguistica ligure nel Mediterraneo, anche i successivi, per quanto velleitari, tentativi di nobilitazione: la Liguria è così l’unica regione italiana, a quel che mi consta, a esprimere nella seconda metà dell’Ottocento un poema “nazionale” scritto nella lingua locale, al seguito dell’esperienza felibristica provenzale e anticipando di diversi anni quella catalana; ed episodi come la pubblicistica e il romanzo, o la traduzione non parodica della Divina CommediaChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità. di (1909) sono indizi importanti del fatto che, fino al fascismo almeno, il genovese non fu percepito in tutto e per tutto come varietà “subordinata” all’italiano. Ciò detto, gli ultimi due secoli, e la seconda metà del Novecento in particolare, segnano il netto e convinto orientamento della società ligure in direzione della cultura italiana (cosa non del tutto scontata, ad esempio, nel periodo barocco, quando l’influenza spagnola fu particolarmente vistosa), e l’adeguamento non meno convinto a modalità linguistiche di maggior prestigio, che, a partire dalla borghesia, defluiscono facilmente (a partire soprattutto dagli anni Settanta) verso gli strati popolari, particolarmente quelli urbani. Teniamo anche conto del fatto che la Liguria, entità per certi aspetti non territoriale, usufruisce meno di altre regioni di “serbatoi” di conservatività linguistica, col suo entroterra semispopolato, con la sua portualità internazionale e con le due Riviere da oltre un secolo costantemente aperte all’accoglienza di un turismo cosmopolita. Ne risulta una regione “poco dialettofona”, anche in base alle statistiche, ma nella quale il retaggio storico ha sempre garantito, soprattutto al genovese, un significativo prestigio: il “complesso di patois” vi è del tutto assente, per quanto la fase cruciale tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso abbia determinato un progressivo ridimensionamento di questa percezione. Sotto questo punto di vista il fascismo operò in maniera ambigua, dimostrando nei confronti dei dialetti liguri (utili per legittimare le pretese irredentistiche sul Nizzardo e sulla Corsica e per il raccordo con le comunità immigrate in America Latina) una singolare tolleranza, fino all’assunzione indebita di miti locali variamente intrisi di umori linguistici autoctoni (ilChe l’inseBalilla); ma agendo al tempo stesso in maniera sistematica per una dequalificazione del genovese, attraverso meccanismi di persuasione che coinvolsero lo stesso panorama culturale e artistico locale, come nel caso del teatro di Gilberto Govi, che meglio di tante altre agenzie diffuse un’immagine degli usi linguistici locali (opportunamente italianizzati) stereotipata, passatista e dequalificata. Il periodo postfascista, caratterizzato anche dalle forti irrequietudini sociali di una città che negli anni Settanta venne investita in pieno dalla stagione del terrorismo, fu a sua volta caratterizzato dall’atteggiamento spesso francamente dialettofobo di una parte dell’ambiente intellettuale e accademico, che intepretò, ad esempio, il persistere delle tradizioni linguistiche locali come una forma di auto-ghettizzazione della classe operaia: di questo ha risentito non poco la ricerca, che si caratterizza a Genova per un clamoroso ritardo a fronte dell’indiscutibile ricchezza storica, documentaria e attuale del patrimonio linguistico-letterario regionale. Con tutto ciò, i dialetti liguri e il genovese in particolare denotano ancora una discreta vitalità in una molteplicità di usi, anche in ambito artistico, circostanza che spesso compensa in qualche modo, come accennavo, l’indiscutibile crisi delle funzioni comunicative. La letteratura in genovese, tradizionalmente lontana nei suoi esiti più alti da modalità “dialettali” continua così a produrre in poesia e in prosa esiti di eccellenza purtroppo assai poco divulgati; la canzone, da De Andrè in poi, si è profondamente rinnovata; è rinata di recente attraverso una pagina settimanale del principale quotidiano regionale una pubblicistica in genovese che interessa ed attrae un pubblico eterogeneo di lettori. A loro modo, sono tutti segnali interessanti di vitalità.
Esiste nella realtà una varietà “ligure” e quanto questa si differenzia rispetto al genovese? Vi sono elementi di derivazione provenzale e/o piemontese?
Ho usato spesso, in questa conversazione, la formula “genovese e ligure”, con la quale ho inteso sottolineare il diverso peso storico, culturale e sociale della varietà cittadina, la “lengua zeneise”, rispetto alle varietà locali. Come ogni contesto regionale, anche quello ligure si caratterizza infatti per una forte variazione diatopica, che viene progressivamente meno a mano a mano che ci si avvicina al “centro” genovese, area innovativa per eccellenza. Dalla periferia occidentale di Savona fino a Sestri Levante sulla costa, così, i dialetti appaiono decisamente orientati sul modello urbano, secondo modalità koinizzanti che si estendono anche alle aree circostanti, soprattutto dell’entroterra, dove questo “genovese” convive spesso, nell’uso, con l’italiano e con varietà più eccentriche, in condizioni di macrodiglossia. A mano a mano che ci si allontana da Genova, emergono invece caratteristiche peculiari ed arcaiche, spesso con significative convergenze tra le due ali estreme della Liguria, dove lo spezzino e il ventimigliese, ad esempio, conservano ancora alcuni tratti del genovese medievale, noti attraverso la documentazione letteraria. Oltre a ciò, gli antichi centri amministrativi e mercantili delle due Riviere e dell’entroterra rivelano spesso, nella loro parlata, una più decisa connotazione in senso “genovesizzante” rispetto alle aree circostanti, con la conseguenza che la varietà urbana mostra di avere agito da un lato in senso centripeto, favorendo il processo di amalgama dei dialetti liguri e la loro percezione unitaria (“genovese” è la denominazione complessiva con la quale il ligure romanzo continua a essere prevalentemente noto), dall’altro in senso centrifugo, accentuando la differenziazione tra le varianti cittadine e i rispettivi contesti rurali. Non esiste quindi un tipo ligure, ma il carattere dei dialetti liguri è molto ben definito da una serie di isoglosse, che ne determinano la netta autonomia verso il tipo provenzale e quello toscano ai due estremi, ma anche rispetto alla galloitalicità settentrionale, dalla quale il tipo ligure si differenzia per numerosi e significativi aspetti, a partire dalla conservazione delle vocali atone e finali, fino a “fenomeni-bandiera” come l’indebolimento fino alla caduta di –r– intervocalica o le palatalizzazioni “spinte” dei nessi PL-, BL-, FL- (cianze ‘piangere’, gianco ‘bianco’, sciamma ‘fiamma’), tratto quest’ultimo che ha, come del resto la robustezza delle vocali, significative assonanze centro-meridionali, puntualmente confermate anche a livello morfologico e lessicale. D’altronde, al di là dello spartiacque che divide la Riviera ligure da un mondo “padano” tradizionalmente sentito come “altro”, i dialetti ancora liguri delle alte valli digradano progressivamente verso il piemontese, il lombardo e l’emiliano, così come non vi è una decisa soluzione di continuità tra le parlate liguri orientali e i dialetti (ancora settentrionali, ma a se stanti) della Lunigiana. Tra Liguria e Provenza passa invece uno dei confini linguistici forse più netti dell’intera Romània, che distanzia nettamente il tipo ligure da quello occitano, lasciando alla varietà italoromanza l’alta valle del Roia con Briga, Tenda, Breglio e Saorgio e il distretto di Mentone oggi in territorio francese. Parlare di elementi di “derivazione” piemontese o provenzale non è quindi corretto, al di là di singoli fenomeni lessicali (non meno significativi di quelli che sottolineano la reciprocità dell’influsso ligure in piemontese, in nizzardo e così via), mentre ha senso ricordare, come si diceva, l’esistenza di varietà “miste” sul versante padano, col prevalere spesso di componenti liguri anche al di fuori dei confini amministrativi: in alta Val Tanaro ad esempio (Briga Alta, Ormea, Garessio in provincia di Cuneo), nel cosiddetto Oltregiogo (a sud della linea Novi Ligure – Ovada in provincia di Alessandria), nelle alte valli emiliane della Trebbia e del Taro.
In che cosa consiste il concetto di “lingua polinomica” e a quali parlate può essere applicato relativamente all’area geografica italiana?
Il concetto linguistico di polinomia è stato elaborato negli anni Ottanta dal sociolinguista corso Jean-Baptiste Marcellesi con specifico riferimento al contesto isolano: nella difficoltà di identificare univocamente una “corsicità” dialettale, ma prendendo atto che l’esistenza di una “lingua corsa” corrispondeva alle esigenze identitarie e percettive della popolazione, lo studioso definì il corso come l’insieme delle varietà dialettali tradizionalmente parlate sul territorio, in quanto frutto di una volontà collettiva dei locutori di riconoscerne l’unitarietà. Si definisce quindi “polinomica” una lingua che, pur priva di uno standard riconosciuto, istituisce relazioni dinamiche con altri idiomi (soprattutto con quelli dominanti, nel caso specifico il francese) manifestando la sua autonomia indipendentemente dalla propria unità strutturale. La definizione supera quella di “sistema dialettale” nella misura in cui la lingua polinomica afferma la propria autonomia rispetto al “tetto” sovraordinato, eludendo i rischi di un equivoco ricorrente nella definizione di “dialetto” come concetto sociolinguistico, secondo l’interpretazione (piegata anche a considerazioni di carattere storico-culturale) che prevale ancora nel contesto italiano: un sistema dialettale che non sia geneticamente subordinato a una lingua può così affermare in linea di principio la propria autonomia anche in mancanza di uno standard di riferimento da contrapporre alla lingua egemone. Il concetto di polinomia non è quindi semplicemente un modo “politicamente corretto” di ridefinire la varietà dialettale di un’area, perché implica una presa di coscienza collettiva e l’instaurarsi di relazioni dinamiche con il codice sovraordinato. In questo senso sono lingue polinomiche le varietà dialettali i cui parlanti ne riconoscano collettivamente, anche attraverso un glottonimo univoco, la parentela di fondo, promuovendo un percorso comune di confronto rispetto alla lingua tetto. Questo modello implica però un’attitudine “militante” dei parlanti, o almeno di una parte visibile e significativa di essi, e sfugge quindi a un’applicazione sistematica ai singoli casi. È certamente una lingua polinomica il corso, ad esempio, e potrebbe definirsi tale il sardo, nel momento in cui vi fosse unanime consenso sull’esigenza di tutelarlo nelle sue varianti e non a partire da uno standard unificato. Nei processi attuali di promozione della tutela e rivitalizzazione di alcune varietà italoromanze, direi che l’attitudine polinomica si sta sempre più affermando, in maniera più o meno consapevole, mentre l’impostazione “occitanista” presente nel sud della Francia, ad esempio, che prevede l’affermazione di uno standard comune alle diverse aree regionali, collide con questa impostazione che è cara al contrario ai “provenzalisti”, sostenitori della tutela delle singole varietà, o quanto meno dell’elaborazione di diversi standard locali. D’altro canto un’impostazione polinomica esiste di fatto, anche precedentemente all’introduzione del concetto da parte di Marcellesi, nella realtà linguistica delle valli grigionesi, dove la definizione comune delle varietà neolatine locali (il romancio, rumantsch) non esclude la promozione delle diverse varietà locali: in questo caso anzi l’elaborazione di una varietà comune sovraordinata (rumantsch grischun) si è rivelata fallimentare, nella percezione dei parlanti, ai fini della elaborazione di una politica complessiva di tutela. In chiave glottopolitica e sociolinguistica il concetto linguistico di polinomia non è quindi privo di efficacia, garantendo pari dignità e prospettive comuni di sviluppo alle diverse varianti che si riconosco sotto un’unica denominazione. Resta peraltro incerto lo statuto polinomico di quei sistemi dialettali (come quello ligure o quello piemontese) in cui una parlata storicamente più forte delle altre può aspirare a essere considerata la varietà “di riferimento” dell’intero sistema, senza necessariamente esercitare, con ciò, un ruolo di “tetto” sulle varianti locali.
Lei si è occupato anche della lingua delle relazioni di missionari italiani in Africa nei secoli XVII-XVIII: cosa può dirci lo studio di queste fonti, insieme a quello dei diari e delle memorie, sulla storia della nostra lingua (e/o su quella delle lingue europee) e quali problematiche possono presentarsi nella valutazione dell’importanza del lessico che vi è impiegato?
In realtà si tratta di un tema che ho soltanto saggiato, a partire da alcuni esempi concreti e specifici, nell’ambito del mio più generale interesse per il contatto linguistico: mi interessava infatti verificare la possibilità che una lingua come l’italiano, sostanzialmente priva di una consistente proiezione extraeuropea ed extramediterranea, si dimostrasse in grado di assumere, per singoli segmenti semantici e in particolari situazioni, quote significative di lessico esotico. Da qui le considerazioni che in alcuni saggi ho dedicato allo statuto degli esotismi diretti, diverso da quello degli esotismi assunti per il tramite di altre lingue europee, nell’ambito di una riflessione complessiva sui concetti di etimologia prossima ed etimologia remota. Il lessico delle relazioni dei missionari nell’antico Regno del Congo (secc. XVI-XVIII) è particolarmente interessante sotto questo punto di vista perché dimostra la “costruzione” di un vocabolario tecnico-specialistico di origine esotica, assunto direttamente in italiano senza il tramite del portoghese; tuttavia, esso conferma al tempo stesso l’occasionalità di questi episodi di contatto linguistico di fronte alla preponderante assunzione di esotismi per via indiretta. Anche alla luce di ciò preferisco considerare a sé la categoria degli orientalismi lessicali, che introduce un apporto diretto e significativo nell’area italoromanza secondo modalità alquanto diverse da quelle che caratterizzano, ad esempio, l’assunzione prevalente di africanismi, amerindismi, nipponismi e così via: un termine arabo o turco passato direttamente in genovese, in siciliano, in veneziano, in italiano, ci racconta infatti una storia enormemente diversa di relazioni economiche, sociali e culturali rispetto a quella di una voce congolese o giapponese, anche se casualmente assunta per via diretta; figuriamoci allora nel caso, assolutamente prevalente, in cui gli esotismi arrivano in Italia attraverso lo spagnolo, il portoghese, il francese o l’inglese: in tali circostanze, il principio della prevalenza dell’etimologia prossima ai fini valutativi fa sì, secondo uno schema perfezionato tra gli altri da Žarko Muljačić, che queste voci siano da considerare prima di tutto ispanismi, lusismi, gallicismi o anglismi, con tutte le conseguenze, quantitative e qualitative, che ne risultano. Tuttavia su questo punto, come dicevo, la mia riflessione è stata fin qui piuttosto episodica, anche per il fatto che sulle scritture in lingua italiana (e nelle lingue d’Italia, per dirla ancora con Banfi) prodotte storicamente in contesti latamente “esotici”, c’è ancora molto da fare. Lo stesso ruolo dell’italiano come lingua diplomatica nel Levante, studiato da Francesco Bruni, tra gli altri, in alcuni importanti lavori, non è stato ancora oggetto di ricognizioni sistematiche, figuriamoci quindi le corrispondenze o i diari, ad esempio, di viaggiatori, missionari, mercanti italiani attivi in paesi remoti. Tempo fa, occupandomi di retrodatazioni, documenti di questo genere si erano rivelati assai promettenti per verificare la precocità nell’assunzione di alcuni esotismi di area malese e amerindia, ma questo tipo di ricerche meriterebbe una sistematicità tale da richiedere l’apporto collettivo e costante di diversi ricercatori impegnati nell’individuazione e nello spoglio delle fonti, con esigenze evidenti di contestualizzazione storica, di esegesi filologica, di approfondimento etimologico e così via. Per fortuna i giovani volenterosi e preparati non mancano, in questo come in altri campi, ed è quindi fondata la speranza che su molti temi affascinanti si possa costantemente tornare “in forze”, per assicurare alla ricerca linguistica quella continuità e quel progresso che da sempre ne fanno una delle discipline più dinamiche dello scibile, in ambito umanistico soprattutto.
ALBUM FOTOGRAFICO - LEUDI DA LAVORO

... Trasportavano sabbia

... Trasportavano botti di vino

Leudo "vinaccere"

... scarico delle botti in mare

A cura del webmaster Carlo Gatti
Rapallo, 2 Maggio 2018


